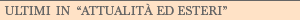Il 15 novembre 1975, quando i capi di Stato e di governo dei sei maggiori Paesi occidentali (Francia, Germania Ovest, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone e Italia) si ritrovarono insieme nel romantico castello di Rambouillet, a cinquanta chilometri da Parigi, forse nessuno immaginava che da quei tre giorni di incontri sarebbe nato l'esclusivo club delle grandi potenze: all'inizio «G6», diventato «G7» con l'ammissione del Canada e infine «G8» con la Russia (nel 2006 il summit sarà ospitato per la prima volta a San Pietroburgo), senza contare il presidente Ue come nono invitato.
All'epoca lo scenario era quello della crisi petrolifera, seguita alla guerra del Kippur nell'ottobre 1973, con la quadruplicazione dei prezzi del greggio in tre mesi. L'economia ristagnava o regrediva, mentre l'inflazione era galoppante («stagflazione» recitava il neologismo). Di fronte a questi eventi l'Occidente si trovò impreparato: nell'estate 1975 il presidente francese Valéry Giscard d'Estaing propose quindi una riunione dei leader delle maggiori potenze per decidere cosa fare.
Il modello prefigurato da Giscard, d'intesa con il cancelliere tedesco Helmut Schmidt, era quello del «Library Group» (cui entrambi avevano preso parte), cioè gli incontri riservati tra i ministri delle Finanze di Francia, Germania Ovest, Gran Bretagna, Giappone e Stati Uniti nella biblioteca della Casa Bianca, ai quali solo sporadicamente partecipava anche quello italiano. Da Washington si fece capire che la nostra esclusione avrebbe inferto un duro colpo alla credibilità del nostro Governo. Ma fu proprio la Farnesina che seppe muoversi con prontezza e intelligenza: il presidente del Consiglio Aldo Moro e il ministro degli Esteri Mariano Rumor preferirono non sollecitare un invito all'Eliseo (si rischiava il rifiuto), ma autorizzarono una missione del segretario generale della Farnesina Raimondo Manzini che, muovendosi secondo i canoni della diplomazia tradizionale basata sui contatti personali a Parigi, Londra, Bonn e Washington, riuscì a tessere la tela e a raggiungere l'obiettivo. Quando fu annunciato il vertice di Rambouillet, l'ammissione dell'Italia fu una sorpresa per più di una cancelleria europea e destò il disappunto degli aspiranti esclusi. In verità bisogna comunque aggiungere che, per alcuni anni, il summit dei capi di Stato e di governo continuò a essere preceduto da un G-5 dei ministri finanziari (senza Italia e Canada). Anzi, accadde perfino che una di queste riunioni (Portorico 1976) servisse a discutere su come reagire di fronte all'eventuale ingresso dei comunisti nel Governo italiano.
Martedì 15 novembre alle ore 18 l'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano (via Clerici, 5), in occasione del 30° anniversario del vertice di Rambouillet, ospita una tavola rotonda sulle grandi potenze nell'economia globale alla quale interverranno Boris Biancheri, presidente Ispi, Alberto Martinelli, ordinario di scienza della politica dell'università statale di Milano e Fabrizio Onida, ordinario di economia internazionale alla Bocconi. Per l'ambasciatore Biancheri, che faceva parte dello staff di Manzini come capo della sua segreteria, l’ingresso dell’Italia nel club dei Grandi – come ha anticipato al «Sole 24 Ore online» –- «è un episodio singolare della nostra politica estera: con l'eccezione di qualche storico e, in particolare, di L. V. Ferraris che lo ha incluso argutamente tra gli esempi dell'arte del fai da te, è stato spesso e, a torto, sottovalutato. E tuttavia è significativo per il tempo e il modo in cui fu raggiunto: si trattò, infatti, di un caso in cui il risultato fu ottenuto non attraverso una manifestazione di forza, ma di debolezza, confermando il giudizio che 40 anni prima aveva dato Harold Nicholson (intellettuale e politico britannico della prima metà del secolo scorso,
ndr) e cioè che, a differenza della Germania che basa la sua diplomazia sulla forza, l’Italia in politica estera basa la sua forza sulla diplomazia».
L'importanza di questo successo, scrive Enrico Serra («Professione: ambasciatore d'Italia», volume secondo, Franco Angeli editore, 2001), fu scoperta dalla stampa e dall'opinione pubblica con anni di ritardo, tanto che nel 1992 Bettino Craxi cercò di arrogarsene il merito con una lettera al «Corriere della Sera». In una rettifica sullo stesso giornale, l'ambasciatore Manzini ribadì invece che «il nostro Paese fu presente al primo vertice G-6 del 1975, otto anni prima del suo insediamento a Palazzo Chigi ».