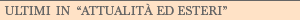Anche il Montenegro se ne va: nel referendum di domenica 21 maggio gli elettori si sono pronunciati con il 55,4% dei voti a favore della separazione dalla Serbia e per l'indipendenza.
L'affluenza è stata elevata: l'86,3 per cento degli aventi diritto. I montenegrini erano chiamati alle urne per dire la parola finale sul destino dell'unione tra la più piccola Repubblica ex jugoslava e la Serbia, sua incombente sorella maggiore ortodossa: ultimo retaggio di quella che fu la Federazione di Tito. A favore dell'indipendenza è schierata compatta la nomenklatura del governo locale di Podgorica (già Titograd). In testa ai partigiani della sovranità c'è l'uomo forte della Repubblica: quel Milo Djukanovic, premier ancora nel mirino della magistratura di Bari per traffici di sigarette. Malgrado queste "vecchie storie" però, il primo ministro può contare su un sostegno quasi incondizionato sul fronte interno e su un sistema di potere ben strutturato. E grazie a numerosi viaggi diplomatici e con la benedizione dell'ex segretario di Stato Usa, Madeleine Albright, "Milo" è riconosciuto oggi anche come un valido interlocutore da diverse cancellerie occidentali.
Josip Broz, più conosciuto con il nome di battaglia di Maresciallo Tito, morì il 4 maggio 1980 in un centro clinico a Lubiana (Slovenia). Al suo funerale parteciparono moltissimi capi di Stato o di governo, con le due importanti eccezioni di Jimmy Carter, presidente statunitense e di Valéry Giscard d’Estaing, presidente francese. Pochi mesi prima Tito, sofferente di gravi problemi di circolazione dovette subire l’amputazione di una gamba; nei primi giorni dopo l'intervento chirurgico la sua foto in ospedale accanto alla moglie Jovanka fece il giro del mondo e sembrò indurre all'ottimismo, ma già molto avanti negli anni (88) non riuscì poi a riprendersi.
Tito aveva saputo tenere unito il Paese, limitando le tensioni nazionaliste, non senza disdegnare l'uso della forza, tramilte i servizi segreti e la polizia politica. Dopo la rottura con Stalin nel 1948, sviluppò una "via jugoslava" al socialismo con risvolti specifici come la cogestione economica e una particolare attenzione alla disponibilità dei servizi sociali. In politica estera nel 1961 Tito fu, con l'egiziano Gamal Abd el-Nasser e l'indiano Jawaharlal Nehru, tra i promotori del Movimento dei non-allineati ossia un'allenza di Stati che non erano membri né della Nato né del Patto di Varsavia. La morte di Tito sollevò seri dubbi sulla possibilità che i suoi successori mantenessero l'unità della Jugoslavia: dieci anni dopo le Repubbliche che formavano la federazione decisero a maggioranza di sciogliere l'unione federale. La decisione non fu accettata dalla Serbia di Slobodan Milosevic e fu l'inizio di una lunga e sanguinosa guerra civile.
Eccone le tappe principali:
Slovenia. Collocata all'estremo nord dell'ex Jugoslavia e ancorata da secoli a tradizioni mitteleuropee, questa piccola e benestante Repubblica alpina fu la prima a proclamarsi indipendente, sulla scia di un referendum - coronato dall'88% di sì - celebratosi il 23 dicembre 1990. Un passo che aprì le porte a una sorta di effetto domino, ma che fu ingoiato a tutta prima dal regime jugoslavo di Belgrado, allora dominato dal serbo Slobodan Milosevic, in modo sostanzialmente pacifico malgrado l'iniziale intervento delle truppe federali, conclusosi peraltro come una scaramuccia nel giro di dieci giorni nell'estate 1991. Per lasciare spazio già nel gennaio 1992 al pieno riconoscimento internazionale di Lubiana.
Croazia. Seconda repubblica federata per dimensioni dopo la Serbia, la Croazia fu seconda - ma dopo la Slovenia - anche nella corsa alla secessione. Uno sbocco preparato dall'ascesa al potere a Zagabria dell'ex generale e ideologo nazionalista Franjo Tudjman (maggio 1990) e da una serie di modifiche legislative, contestate come discriminatorie dalla minoranza dei serbi di Croazia (allora pari a oltre il 12% della popolazione locale). Ma suggellato soltanto nel maggio del 1991 da un altro referendum, boicottato dai serbi, nel quale i sì all' indipendenza furono il 92%. Un risultato avallato anch'esso dai Paesi occidentali, ma destinato a scatenare scontri ben più sanguinosi di quelli della vicina Slovenia. Sino all'avvio di una guerra aperta durata fino al 1995, con iniziale prevalenza delle forze serbo-jugoslave e riscossa finale del nuovo esercito croato grazie alla cosiddetta operazione Tempesta, condotta nell'estate '95 sotto tutela statunitense.
Bosnia-Erzegovina. Vero fulcro della tragedia jugoslava, questo Paese etnicamente composito - 40% di bosniaco-musulmani, 35% di serbo-ortodossi, 20% di croato-cattolici - fu il terzo a dichiarasi sovrano. Lo fece con voto parlamentare il 15 ottobre 1991. Un passaggio seguito dalla cantonalizzazione etnica strappata a Lisbona dalla comunità internazionale al presidente Alija Izetbegovic (musulmano), ma da questi poi denunciata a favore di un referendum indipendentista svoltosi il 29 febbraio 1992, nonostante il boicottaggio della comunità serba locale. Referendum approvato dal 62,8% dei votanti e riconosciuto in aprile ancora una volta da Usa e Paesi della Ue, ma annientato immediatamente dallo scatenarsi di un conflitto atroce innescato dalle milizie serbo-bosniache di Radovan Karadzic e Ratko Mladic - armate e finanziate dal regime di Belgrado - con l'assedio di Sarajevo. Un accerchiamento destinato a durare tre anni, in un panorama punteggiato da eccidi, devastazioni, lager e stupri etnici, fra vaghi tentativi negoziali europei e trame di ipotetiche spartizioni della Bosnia attribuite sotto banco agli arci-rivali Milosevic e Tudjman. Fino ai raid Nato contro le forze serbo-bosniache e agli accordi imposti dagli Usa a Dayton nel novembre 1995 - tuttora in vigore - sanciti dal riconoscimento dell'indipendenza di Sarajevo, ma anche da parte di Belgrado: accordi precari, ma tali da mettere almeno fine a una mattanza pagata da 200mila morti (8mila solo nel famigerato massacro di civili di Srebrenica) e da moltitudini di profughi.
Macedonia. Altro mosaico etnico (macedoni, bulgari, serbi, albanesi), ma confinato alla frontiera sud dell'ex Jugoslavia, la Macedonia fu quella che giunse all'indipendenza sotto la guida della meno nazionalista delle leadership balcaniche degli anni '90. Presieduta dall'astuto Kiro Gligorov, veterano della nomenklatura tardo-titina, si proclamò a sua volta sovrana - quasi per forza d'inerzia - nel settembre 91. Con un plebiscito pilotato (95% di sì), ma senza versare - in quel frangente drammatico - neppure una goccia di sangue.
Serbia. La Serbia «conserverà buone relazioni di vicinato» con il Montenegro ha assicura da Londra l'attuale ministro serbo delle Finanze Mjladjan Dinkic, nel corso di una riunione dei governatori della Berd (Banca europea della ricostruzione e dello sviluppo), che dovrebbe aprire prossimamente un ufficio in Montenegro. «Il referendum è stato democratico e abbiamo grande rispetto per la volontà degli abitanti del Montenegro, perché, secondo le norme dell'Unione europea, hanno ottenuto una chiara maggioranza a favore dell'indipendenza - ha affermato Dinkic, attuale governatore per la Serbia Montenegro della Berd. Fra l'altro dopo l'indipendenza del Montenegro il ministro degli Esteri serbo Vuk Draskovic ha auspicato che la Serbia diventi una monarchia costituzionale con a capo il principe Aleksandar Karadjodjevic. Draskovic, che è anche presidente del partito per il rinnovamento serbo (Spo, monarchico e clericale), ha sostenuto che una "scorciatoia" per l'ingresso della Serbia nell'Unioneeuropea e nella Nato sarebbe un nuovo assetto statale per la Serbia stessa.
Montenegro. «Con la decisione della maggioranza dei cittadini del Montenegro, l'indipendenza del Paese è stata ristabilita», ha detto alla folla festante che lo acclamava il primo ministro montenegrino Milo Djukanovic, ricordando l'indipendenza di cui il Paese aveva goduto per l'ultima volta nel 1918 e celebrando il coronamento di una battaglia durata dieci anni. Riemerso come repubblica federale, nel 1945, nella neonata Jugoslavia socialista del maresciallo Tito, il Montenegro è rimasto associato alla Serbia - dopo un primo tentativo referendario fallito - anche negli anni '90, mentre Slovenia, Croazia, Bosnia e Macedonia proclamavano l'indipendenza da Belgrado e dall'allora regime di Slobodan Milosevic (montenegrino di ascendenza) sullo sfondo di una devastante stagione di guerre e violenze interetniche.
Kosovo. L'indipendenza del Montenegro si è festeggiata anche in Kosovo, quasi come fosse la propria. Un traguardo che a Pristina nseguono da 17 anni, essendo stati i primi tra i popoli dell'ex federazione jugoslava a chiedere un referendum sull'autodeterminazione. Tutta la leadership albanese del Kosovo si è espressa con toni entusiastici per il risultato raggiunto da Podgorica. Di sapore naturalmente opposto le reazioni della minoranza serba che ha considerato quel voto «un autentico tradimento». La separazione del Montenegro dall'unione con la Serbia decida con il referendum del 21 maggio, «fa cadere anche l'ultimo alibi che ci negava il diritto all'indipendenza» spiega un analista di Pristina. Il riferimento è alla risoluzione 1244 delle Nazioni Unite che nel 1999 indicò le regole da seguire dopo la fine del conflitto fra Belgrado e la Nato, e che fissava un Kosovo come «parte della federazione jugoslava», quindi non indipendente. Ma con la piena sovranità riconosciuta ora al Montenegro, la federazione non esiste più. Anche Pristina tentò di staccarsi da Belgrado con un voto popolare: era il 1989, la consultazione non autorizzata dal governo serbo si concluse con il 100% dei voti a favore della secessione, ma il risultato non venne riconosciuto da nessuno Stato. Fu l'inizio della repressione da parte della Serbia, cui seguì la resistenza (prima pacifica, poi armata) sostenuta poi dai bombardamenti della Nato e rimpiazzata infine da un protettorato internazionale, che va avanti da sette anni e che nei prossimi mesi potrebbe concludersi con la proclamazione dell'agognata indipendenza. Non più attraverso un referendum, come accaduto per i montenegrini, ma tramite un negoziato che va faticosamente avanti fra Pristina e Belgrado e con la mediazione della comunità internazionale.