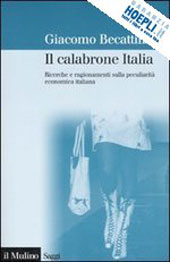 In base alle leggi della fisica il calabrone non dovrebbe volare: le sue ali, infatti, sono troppo piccole in rapporto al suo peso corporeo. L'insetto nero, invece, riesce a farlo. Con buona pace di fisici ed entomologi. Allo stesso modo, in base alle leggi dell'economia, l'Italia non dovrebbe figurare fra i paesi più industrializzati del mondo non disponendo di materie prime e di industrie di grandi dimensioni. E invece fra i paesi più industrializzati l'Italia ci figura eccome. Riuscendo, anzi, a volare con successo nel cielo dell'economia mondiale. A cosa è dovuto questo prodigio? Cosa c'è alla base dell'irresistibile sviluppo del ‘calabrone Italia'? Giacomo Becattini, uno dei nostri economisti più autorevoli, non ha dubbi: la vitalità dei nostri distretti industriali e la loro capacità di innovazione. La tesi è esposta in questa raccolta di saggi, mandata in libreria dall'editore Il Mulino, che già nel titolo usa la metafora coniata dall'economista canadese John Kenneth Galbraith (naturalizzato cittadino americano nel 1937, a 29 anni) e poi ripresa più volte nel corso degli anni (nel 1998 anche da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi con ‘Il volo del Calabrone. Breve storia dell'economia italiana nel Novecento')
In base alle leggi della fisica il calabrone non dovrebbe volare: le sue ali, infatti, sono troppo piccole in rapporto al suo peso corporeo. L'insetto nero, invece, riesce a farlo. Con buona pace di fisici ed entomologi. Allo stesso modo, in base alle leggi dell'economia, l'Italia non dovrebbe figurare fra i paesi più industrializzati del mondo non disponendo di materie prime e di industrie di grandi dimensioni. E invece fra i paesi più industrializzati l'Italia ci figura eccome. Riuscendo, anzi, a volare con successo nel cielo dell'economia mondiale. A cosa è dovuto questo prodigio? Cosa c'è alla base dell'irresistibile sviluppo del ‘calabrone Italia'? Giacomo Becattini, uno dei nostri economisti più autorevoli, non ha dubbi: la vitalità dei nostri distretti industriali e la loro capacità di innovazione. La tesi è esposta in questa raccolta di saggi, mandata in libreria dall'editore Il Mulino, che già nel titolo usa la metafora coniata dall'economista canadese John Kenneth Galbraith (naturalizzato cittadino americano nel 1937, a 29 anni) e poi ripresa più volte nel corso degli anni (nel 1998 anche da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi con ‘Il volo del Calabrone. Breve storia dell'economia italiana nel Novecento')
Il nostro maggior limite e la nostra arma segreta
Una raccolta - quella proposta da Giacomo Becattini - che ha un ‘bersaglio' preciso e manifesto: smentire - dati alla mano - quanti affermano che "non può che finir male una popolazione di imprese bonsai in un mondo di baobab". L'economia italiana, in altre parole, è forte non a dispetto delle modeste dimensioni della maggior parte delle sue imprese, ma proprio grazie a ciò. La sua forza sta nella ‘diversità' che la caratterizza rispetto ad altre economie sviluppate: diversità nel modello di specializzazione industriale ("la struttura manifatturiera del nostro paese non è dominata da settori industriali tecnologicamente impegnativi e/o intensivi di capitale come molti si aspetterebbero da uno dei sette paesi più industrializzati de mondo"), diversità nella massiccia redislocazione territoriale dell'industria manifatturiera che ha avuto luogo dopo la fine della seconda guerra mondiale, diversità per l'abbondanza di sistemi locali manifatturieri di piccola e/o medio piccola impresa ("più di 200 alla fine del 1991). "L'ampia escursione dei caratteri ‘regionali' - sostiene il docente di Economia politica, già presidente della Società italiana degli economisti - è a mio avviso il nostro maggior limite e, insieme, la nostra arma segreta".
La forza della nostra economia sta dunque nei distretti e nella modesta dimensione delle nostre imprese. Come, del resto, testimoniano i dati: prendendo a riferimento i soli settori di punta dell'export italiano - il cosiddetto "made in Italy", ossia i settori del "sistema moda", dell'alimentazione, dei prodotti per la casa e l'arredo, ma anche del macchinario strumentale - la percentuale di occupati presso imprese con meno di 200 addetti risultava nel 1991 pari addirittura all'84% del totale.
Un libro gremito di numeri, grafici e tabelle "certamente indispensabili per determinare almeno la direzione di certi fenomeni, oltre che per dare un peso agli argomenti". Ricco, già nel titolo, di metafore capaci di sintetizzare fenomeni estremamente complessi, come il dimensionamento di un'industria e la sua capacità di relazionarsi con il mercato globale (si veda, ad esempio, a pagina 141, il paragrafo ‘Forti pigmei e deboli watussi').
Un testo rigoroso e allo stesso tempo di agevole lettura anche per quanti non possono vantare una laurea in Economia. Con, in chiusura, un utile ‘abbecedario dello sviluppo italiano' che riassume in tredici voci altrettanti aspetti cruciali della realtà del nostro paese.
(Giacomo Beccattini, Il calabrone Italia, Il Mulino, pagg 272-euro 22)