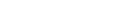di Angela Vettese
C'è stato un tempo in cui la matematica era un sapere d'obbligo per l'artista. Quando creava sfondamenti prospettici, come pittore, o quando, come scultore e produttore di monumenti, doveva fare attenzione al calcolo dei pesi. Si trattava però, soprattutto, di un uso strumentale dei "conti"; solo alcuni tra gli artisti hanno iniziato, dal Quattrocento in poi, a fare proprio il lato spirituale e poetico della matematica. Su questo tema verte la mostra aperta al Mumok di Vienna «Exact and Different».
Il titolo è ambizioso e vorrebbe portarci nel percorso di numerosi secoli, da Albrecht Dürer a Sol LeWitt; in verità non c'è nulla di coerente in questo viaggio alla ricerca del numero ma anche dello spazio infinitesimale che sta tra una quantità e la successiva. Alcune opere di cubisti come Juan Gris ed Henri Laurens ci mostrano un primo tentativo di fuga da geometrie e aritmetiche semplici. Giacomo Balla usa il colore come campo di infinite trasformazioni di una medesima qualità che, dopo essersi prestata a deviazioni appunto infinitesimali, finisce per darsi a noi come l'opposto del suo apparire iniziale.
I Futuristi, in generale, hanno affrontato il tema non di un proporsi statico della quantità ma del suo variare dinamico, così difficile da trasformare in immagine senza potere usare il movimento. Un colore degrada, ma degrada anche una forma, un segno che si fa sempre più piccolo o più blando, alla ricerca di quei vettori di forze che sono le linee di fuga. Peraltro qui si iniziano a intravedere le vere difficoltà: la matematica sta prendendo strade troppo difficili, così come la fisica, perché gli artisti possano capirle e applicarle. Così fanno soltanto da eco alla "quarta dimensione" o ad altri concetti della seconda rivoluzione scientifica.
Così De Stjil, con Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Georges Vantongerloo, usano la matematica soprattutto nei termini di una semplificazione che ha a che fare con la mistica e addirittura con la teosofia. Il rapporto rimane tra colore e geometrie non complesse, sorrette dal desiderio di una essenzialità incontaminata e mai dal desiderio di decorazione. Già, perché molta parte dell'arte nella quale compare il numero è di natura decorativa e basa appunto sulla ripetizione di quadrati, volute, angoli la sua presa sul pubblico. Qui invece, ai primi anni del XX secolo, si tratta proprio di indagare il senso del numero a prescindere dal suo ruolo nell'ornamento.
I curatori, Wolfgang Drechsler con Gabriele Werner e Dieter Bogner, hanno poi seguito la strada che conduce all'arte minimalista e concettuale: dalle mille maniere di concepire un cubo – disegnato su carta o nello spazio da un tratto nero o da un segmento di legno laccato bianco – messe in scena da Sol LeWitt; alla circumnavigazioni «in an exaggerated manner» di Bruce Nauman attorno al perimetri di un quadrato disegnato per terra (1967).
Per chi desidera perdersi nel gioco mentale le cose più affascinanti da guardare sono però quelle che oggi vanno meno di moda, come il passaggio – uno dentro l'altro – di un poligono a uno più semplice a un quadrato a un triangolo di Max Bill, o come il dispiegarsi dello spettro cromatico in quadrati accostati in molti modi diversi da Lohse.
Tra gli anni cinquanta e sessanta, come reazione alla brutale emozionalità dell'Informale e di tutta l'arte ottenuta con gesti non misurati, è emersa la tendenza a tralasciare qualsiasi elemento soggettivo per concentrarsi sulla pura oggettività, applicata anche a elementi come il colore che per secoli erano stati letti dalla cultura occidentale come fattori soggettivi e "qualità" opposte in quanto tali alle "quantità". Josef Albers ha imparato questa lezione al Bauhaus, e la porta in America nella sua seconda vita d'artista. I suoi "omaggi al quadrato" sono omaggi in realtà a ogni forma di ritmo calcolato, sia esso letto dal punto di vista del colore, della superficie o del colore.
Se a un certo punto Julio Le Parc vinse un Gran Premio a Venezia, testa di ponte di una generazione fatta da Rafael Soto, Victor Vasarely e molti altri pittori dell'"esatto", lo si dovette proprio alla reazione verso qualsiasi mitologia dell'artista come genio e sregolatezza.
Alla generazione più giovane la mostra riserva alcuni incunaboli di quella che oggi chiamiamo arte digitale e che, se oggi ha molto a che fare con la rete e pochissimo a che fare con i numeri, proprio in quanto si fonda sull'uso del calcolatore riposa sempre su di un letto di logica e sulla riproduzione artificiale di una qualche forma di intelligenza logica. D'altra parte è proprio quanto accade in rete, in quel fiorire incontrollato di pulsioni tra l'erotico e l'emotivo, che ha la sua ragion d'essere questa mostra.
1 «Exact and different. Art and Mathematic
from Dürer to Sol LeWitt», Vienna, Mumok
fino al 28 maggio.
© Riproduzione riservata