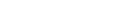I primi a comprare arte futurista sono i grandi collezionisti americani giunti in Italia all'inizio degli anni 50. Lydia Wiston Malbin fa shopping a Roma, Milano e Verona. Qui incontra Amalia Boccioni e da lei compra tutto il fondo dei disegni del fratello Umberto, circa un centinaio, tra cui un'unica bellissima tempera colorata, importante studio preparatorio per «Il bevitore» (1914) oggi nelle Raccolte civiche di Milano, rivenduto poi all'asta nel 1990 a New York a 605mila dollari. Intanto Gino Severini vive a Parigi e introduce i collezionisti d'Oltreoceano come i Rothschild e gli Slifka negli atelier dei suoi compagni, mentre i direttori dei musei visitano le case degli eredi.
Alfred Barr, ad esempio, mitico direttore del MoMa di New York, acquistò la «Lampada ad arco» (1909/1910) di Balla e il «Il Footboller» di Boccioni direttamente dai Marinetti, mentre il primo proprietario de «La città che sale» (1912) di Boccioni, oggi al MoMa di New York, fu il musicista Ferruccio Busoni, a conferma che le opere futuriste ebbero entusiasti estimatori prima di tutto tra gli artisti. Piero Dorazio, ad esempio, possedeva alcune opere di Giacomo Balla che sono passate di mano il 24 novembre 2008 da Christie's Milano.
Patria dell'arte futurista, l'Italia ne è, però, il Paese più sguarnito. Come mai? Amalia Boccioni, prima di cedere alle lusinghe dello straniero, aveva offerto al Governo italiano l'acquisto del fondo delle opere di Umberto, ma Giulio Carlo Argan, all'epoca funzionario dei musei statali, non favorì l'acquisto giudicando il movimento troppo colluso con il fascismo. Che dire? Boccioni era morto nel 1916, cioè in tempi non sospetti, ma tant'è.
Lo sdoganamento del mercato dei Futuristi avviene 20 anni fa, favorito da due eventi di risonanza mondiale: la grande mostra «Futurismo & Futurismi» a Palazzo Grassi di Venezia (1986) e la vendita all'asta Sotheby's di New York (1990) della collezione Lydia Winston Malbin. In quell'occasione la tela di Balla «Scala degli addii (salutando)» del 1908 fu acquistata dalla famiglia Agnelli a 4,4 milioni di dollari. Da allora le opere futuriste riscuotono l'interesse di un sempre maggior numero di collezionisti, musei e fondazioni, mentre le quotazioni registrano un lento e costante apprezzamento, allineato ai valori odierni delle avanguardie storiche europee. Nella classifica dei record la palma va a Severini con 29,6 milioni di dollari battuti da Sotheby's Londra, il 25 giugno 2008, per «Danseuse» (1915); lo insegue con molto distacco Balla con 2.931.200 di euro, aggiudicati per «Velocità d'automobile + luci» (1913) da Sotheby's New York, l'8 maggio 2007, tallonato dai 1.866.950 di euro di Boccioni totalizzati per «Studio per Footballer» (1913) da Christie's Milano, il 27 novembre 2007 e da Carlo Carrà con 858mila euro esitati per «Stella del Caffè Chantant» (1915-1916) da Farsetti arte di Prato, il 26 maggio 2007.
Ma chi sono oggi i grandi collezionisti di Futurismo?
«Sarebbe più corretto dire chi erano» precisa Massimo Carpi, dell'Associazione Futur-ism, elencando le raccolte di Ausonio Canavese, Carlo Grassi, Riccardo e Magda Jucker (acquisita poi da Brera) e Gianni Mattioli, attualmente la più importante raccolta di Futurismo in Italia e nel mondo, data in deposito al Museo Peggy Guggenheim di Venezia dalla figlia Laura, storica d'arte. A cento anni dalla nascita le piazze più vivaci per il mercato di arte futurista sono italiane (vedi articoli pagine seguenti), ma a movimentare gli scambi nel primo decennio del 900 erano Parigi, Londra, Berlino e negli anni 90 New York.
© Riproduzione riservata