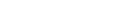di Angela Vettese
Non c'è aereo privato che, anche in tempi di crisi, sarebbe in grado di portare a vedere tutte le biennali d'arte contemporanea che si organizzano nel globo. La Vestale di Venezia cammina ormai col bastone della vecchiaia, ma la formula non si è mai ammalata. Si è anzi riprodotta in mille modi. Però, la formula di un'esposizione periodica d'arte contemporanea – nata al tempo in cui la pratica del Salon parigino si innestò con quella della fiera campionaria e delle esposizioni universali – pone molti problemi.
Anzitutto, la stessa scadenza fissa parla di una necessità di aggiornamento che reca implicita una certa idea di moderno o addirittura di moda: è come dire che l'arte visiva ha continuamente dietro le spalle una vocina che chiede «che c'è di nuovo?», quasi che il vecchio potesse o dovesse perdere attualità e pregnanza. Inoltre, in questa spasmodica ricerca dell'aggiornamento è chiaro anche un presupposto relativo alla nuova forma di committenza: invece di commissionarla, l'arte del XXI secolo (e in buona parte quella dei secoli immediatamente precedenti) la si compera già fatta. Le Biennali sono anche vetrine dove si vede cosa scegliere e dove si impara come.
I committenti, del resto, non sono solo coloro che pagano in denaro: sono anche chi adotta un autore, un'opera, una corrente per farne oggetto di un articolo su una rivista o per cercare di far donare qualcosa da un certo artista a un museo. Per questo, critici e curatori girano le biennali avidamente in cerca di aggiornamento e ispirazione. Nel tempo, poi, le mostre periodiche sono diventate anche luoghi di uno statement politico: grazie soprattutto alla guida di chi le coordina, si tratta di fraseggi composti da opere coordinate. Chi ricordi quella di Achille Bonito Oliva nel 1993, non può non notare come sia stata la prima in cui il narcisismo del curatore unico veniva al contempo affermato e negato dal coinvolgimento di centinaia di critici a cui sono state delegate parti più piccole del grande insieme, operazione ritentata poi da Francesco Bonami. La Biennale di Johannesburg del 1997 introdusse il tema della mostra fatta in un territorio problematico, laddove, fino a quel momento, in fondo si erano sempre portate le opere d'arte contemporanea in territori senza tensioni sociali troppo gravi. Nel 1995, dopo l'abolizione della sezione «Aperto» a Venezia, una delle novità più importanti fu Manifesta, la Biennale itinerante che avrebbe dovuto toccare i centri più sensibili dell'Europa. Operazione parzialmente fallita e anche su questo si potrebbe riflettere: perché Rotterdam, Lussemburgo, Francoforte, una Lubiana già ricca, San Sebastian non povera e un Alto Adige ancor più agiato tra le tappe del suo nomadismo? È evidente che portare una Biennale, che so, a Sarajevo nel suo difficile dopoguerra avrebbe presentato più asperità.
E ancora. Che beneficio ha un'opera dall'essere presentata in mezzo a tante altre? Da una parte infatti è evidente che il contesto l'aiuta. Funge da pedigree compattato. Ma la visibilità è spesso scarsa e quello stesso contesto la opprime, la fa percepire in modo spesso inesatto, la immette in un sistema di significati che potrebbe risultare forzato. Per l'autore il discorso è un po' diverso: sicuramente non gode dei privilegi di chi ha un museo a disposizione, ma essere invitato a una festa internazionale e riconosciuta è un modo per potere avere altri inviti e per potersi, forse, proporre altrove in un secondo momento. Ma questo accade solo se la manifestazione ha davvero raggiunto un suo prestigio, e non accade così spesso. Chi lavora Venezia sa con quale stolidità altissimi sponsor vogliono essere presenti in quel momento e non in altri, spesso senza capire che la goccia che metteranno in quel mare difficilmente sarà notata da molti. Questo indica che, anche se vecchia, Nostra Signora delle Polemiche funziona.
E funzionano mostre come Kassel in Germania, quella del Whitney a New York, di Yokohama in Giappone, di Istanbul in Turchia e alcune altre che, magari solo per un'edizione, diventano dei biglietti da visita. Ma mille altre non fanno notizia nonostante l'impegno profuso. Lione è un centro così difficile che, per esempio, quest'anno ha cambiato in corsa direttore e dopo l'abbandono di Catherine David vedrà al timone il cinese Hou Hanrou.
Nomi come questi ci portano a un altro gioco pericoloso, quello dei quattro cantoni: alla fine chi cura queste manifestazioni sono sempre gli stessi nomi, sganciati dal territorio, quasi che se il museo nasce in un certo luogo, la mostra periodica si sganci invece da terra per diventare un satellite apolide. Forse è giusto così, forse no...
Su questo e altro vale la pena studiare, come da tempo stanno facendo studiosi come Reesa Greenberg, Sandy Nairne, Bruce Altshuler e molti giovani degli atenei di Venezia. Di questo e altro vale la pena di parlare con i protagonisti di una simile, inarrestabile fioritura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gli appuntamenti
Protagonisti
al Festival
Dal 17 al 19 aprile, la città di Faenza ospita la seconda edizione del Festival dell'Arte Contemporanea. Ideato e diretto da C. Basualdo,
P. L. Sacco e Angela Vettese, il festival si intitola quest'anno «On biennials/ Tutto sulle biennali» e affronta questo tema reso attuale dalla 53esima edizione della Biennale di Venezia e dalle importanti trasformazioni che il sistema dell'arte contemporanea sta vivendo.
A Faenza sarà presente Daniel Birnbaum, che aprirà il festival
con Angela Vettese guidando
il pubblico in anteprima alla scoperta della la sua Biannale di Venezia. Sempre guardando a Venezia, Luca Beatrice e Beatrice Buscaroli racconteranno il loro progetto per il nuovo Padiglione Italia, e Monique Veaute svelerà in anteprima i contenuti del Museo di Punta della Dogana, voluto dal collezionista Francois Pinault.
L'orizzonte si sposterà più avanti nel tempo con Francesco Bonami e le anteprime sulla sua Biennale del Whitney Museum di New York, che aprirà al pubblico nel 2010, mentre Carolyn Christov - Bakargiev, direttrice del Castello di Rivoli, ci condurrà nella sua Documenta, la quinquennale di Kassel prevista
per il 2012, uno degli eventi più amati dal mondo dell'arte contemporanea.
Ad Angela Vettese abbiamo chiesto di presentare i contenuti del fastival. Tutti gli appuntamenti sul programma della seconda edizione saranno comunicati sul sito: www.festivalartecontemporanea.it.
© Riproduzione riservata