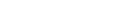di Marco Carminati
La più antica immagine di una maschera si trova nelle grotte di Lascaux in Francia e stiamo parlando di 15 mila anni prima di Cristo. La più recente si trova sull'autobus sotto casa e stiamo parlando di oggi. Salite sui mezzi pubblici e potrete incappare in una donna col burqa seduta accanto a una col viso ridisegnato dal chirurgo plastico. Perché l'umanità ha sempre sentito l'esigenza di alterare il proprio volto o di sostituirlo con un volto artificiale? E perché in Occidente il concetto di maschera suona sostanzialmente negativo in quanto contrapposto a quello di verità?
Chi vive contorcendosi in questi interrogativi e chi, più semplicemente, è alla ricerca di una mostra originale e divertente per l'estate troverà le sue risposte a Vienna. Il Museo Etnologico della capitale austriaca ha allestito una rassegna di rara bellezza dedicata al tema della maschera in tutte le civiltà umane, dall'Egitto al Tirolo, dall'Oceania alla Mesoamerica, dall'Africa all'Asia, dai vasi greci a Daniel Spoerri, passando per Ghirlandaio, Bernini, Rubens, Poussin, Guardi, Tiepolo, Ensor, Nolde e Picasso.
Un guazzabuglio? Ma nemmeno per sogno. La rassegna indica percorsi tematici così chiari e rigorosi che è possibile seguire il filo della narrazione senza bisogno di giungere preparati e senza neppure leggere i cartellini: qui le maschere si smascherano da sole.
Il primo incontro è con un quadro intrigante, un tempo attribuito a Raffaello e oggi a Ghirlandaio: si tratta di un "coperto" di ritratto (cioè di una tavola che serviva per celare e proteggere il quadro vero e proprio) che illustra una maschera accompagnata dall'iscrizione latina «Sua Cuique Persona» («A ciascuno la sua maschera»): è il forte richiamo al ruolo che ognuno di noi recita, anche oggi, nel teatro della società.
E dopo il richiamo si entra nel vivo della narrazione. Un teschio trasformato in maschera risalente a settemila anni prima di Cristo ci annuncia che gli uomini avvertirono l'esigenza di creare maschere innanzitutto per combattere l'oblio della morte. Un colpo occhio nella prima sala ci offre la simultanea visione di volti di faraoni e tavole del Fayum che ricoprivano le mummie dei defunti e di maschere in gesso calcate direttamente sui volti dei trapassati destinate a perpetuarne le vere sembianze. In rassegna osserviamo esempi di ritrattistica romana, medievale e rinascimentale evidentemente cavati dalle maschere funebri: in particolare, il ritratto di Lorenzo de' Medici dipinto da Vasari è esposto accanto all'impressionante calco in gesso originale del volto del Magnifico. In una teca possiamo osservare i volti di Mahler, Schiele, Liszt e Loos nel sonno della morte. Vivissimi ci appaiono invece gli spettacolari ritratti in cera di Ferdinando IV e Maria Carolina di Napoli che dialogano con maschere funebri precolombiane e altre provenienti da Africa, Asia e Oceania. In quanto a inquietudine, però, il primato spetta a un dipinto rinascimentale tedesco: vi si scorgono due coniugi che osservano i loro volti in uno specchio, il quale però non riflette i loro visi bensì i loro teschi! È un gran bel "memento": il nostro vero volto è quello del destino mortale; il resto è maschera. Alle maschere gli uomini assegnarono anche il compito di protezione dai pericoli e di salvaguardia della privacy. Al centro della seconda sezione troneggia la Testa della Medusa di Gian Lorenzo Bernini, sulla parete accanto c'è la versione del mito interpretato da Rubens. In questa sezione sono esposti gli elmi appartenuti a Carlo V e quelli indossati dai protagonisti di Guerre stellari, ci sono maschere per la scherma e per i vigili del fuoco; e poi ci sono i burqa mostrati accanto alle immagini della «virgo veneta», una curiosa mise che voleva le donne di Venezia completamente velate dalla testa ai piedi ad eccezione del seno, generosamente ostentato.
Imponente è la sezione dedicata al rapporto tra le maschere e il teatro in ogni civiltà. Da non perdere sono i colossali mascheroni provenienti dalle terme di Diocleziano e i delicati rilievi romani che illustrano Menandro mentre cerca l'ispirazione osservando le maschere. Bellissimo è il cratere greco proveniente da Napoli che raffigura tutte le maschere del teatro antico. Immancabili le maschere del teatro No e quelle della Commedia dell'arte, che Carlo Goldoni licenziò dal suo teatro ma che Pirandello e Brecht riportarono in auge.
Le feste furono sempre occasione per grandi mascherate, ad esempio alla corte degli Asburgo (bellissime incisioni in mostra illustrano quelle di Massimiliano I) o nella città di Venezia, patria del carnevale, dove grazie alla "bautta" e ai tabarri uomini e donne potevano tutelare la loro privacy girando sempre mascherati, eccetto che in Quaresima. I quadri di Francesco Guardi e di Pietro Longhi sono il documento vivente di questa singolare usanza veneziana di vita in maschera.
E che dire del mondo popolare? Maschere tribali mostruose e comiche, polimateriche ed estrose riempiono un'intera sala del percorso, portandoci in un lampo dalle Alpi tirolesi alle savane africane tra esplosioni di allegria e colpi di spavento. Ma quando la maschera diventa un simbolo negativo? Tutta colpa dei Padri della Chiesa che detestavano il teatro classico e il suo corollario di maschere e mascheramenti. L'umanesimo recupera il teatro antico e riconsidera le maschere le quali, però, dal Cinquecento in avanti assurgono a simboli della frode e dell'inganno: Cesare Ripa nella sua Iconologia ne enumera ben 20 varianti. Con significati sinistri le maschere compaiono sulle tombe medicee di Michelangelo e nei quadri dei Manieristi; e in età barocca diventano uno dei simboli della dissimulazione e della pittura, come documentano in mostra le affascinanti tele di Lorenzo Lippi e Francesco Furini. Mascheroni sempre più bizzarri ed elaborati conquistano progressivamente le facciate di ville e palazzi in ogni città d'Europa, fino alle soglie del Modernismo.
Poi arriva Freud e divide l'Io, il SuperIo e Es. La maschera perde il connotato negativo e torna al centro del dibattito intellettuale come simbolo della ricerca di una nuova identità. È qui che il visitatore si imbatte nelle tele di Ensor e Nolde, nei bizzarri autoritratti in collage di Picasso, nelle foto di Man Ray e Cindy Sherman e le performance di Orlan, l'artista francese che cambia i suoi connotati ricorrendo a continui lifting. Prima di uscire, smascheriamo un arcano. Ideata da Sylvia Ferino Padgen (la bravissima curatrice dei dipinti italiani del Kunsthistorisches Museum di Vienna), questa mostra era stata progettata per avere anche una tappa italiana, a Cremona. In bilico per le elezioni comunali, l'ammistrazione uscente (e perdente) ha preferito rimangiarsi gli accordi presi. Cremona ha fatto una brutta figura con Vienna, ma forse qualche altra città italiana potrebbe cogliere la palla al balzo e ospitare questa rassegna strepitosa. Mostre così spettacolari e originali – credete – in giro ne vedono poche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
1 «Wir sind Maske», Vienna, Museum für Völkerkunde, fino al 29 settembre. Catalogo Silvana Editoriale. Info: www.khm.at
© Riproduzione riservata