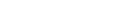L'occasione è davvero da non perdere. Jean-Marc de La Sablière, ambasciatore di Francia in Italia, ha deciso di fare un bellissimo regalo urbi et orbi: spalancherà a tutti, per quattro mesi, le porte della sua casa romana. Attenzione, non stiamo parlando di una casa qualsiasi: stiamo parlando del palazzo rinascimentale più spettacolare e inaccessibile di Roma. Parliamo di Palazzo Farnese.
La circostanza di questa lunga apertura straordinaria è legata a un felice genetliaco: i cento anni di acquisizione da parte della Francia del palazzo romano (1911-2011), immobile che venne poi venduto all'Italia nel 1936 rimanendo sede dell'ambasciata francese.
Per onorare l'italianità del palazzo – costruito e decorato per una famiglia italiana da architetti e pittori italiani (Sangallo, Michelangelo, Vignola, Salviati, Zuccari, Carracci) – l'ambasciatore de La Sablière non si è limitato ad aprire il portone. Ha voluto organizzare una mostra unica e irripetibile (curata da Roberto Cecchi e Francesco Buranelli e organizzata da Civita), chiamando a raccolta 150 capolavori tra dipinti, sculture, disegni, monete, cammei, arazzi e mobili per raccontare i fasti del celebre (e oggi disperso) Museum Farnesianum e narrare la storia del palazzo romano dalla sua fondazione all'istituzione del l'ambasciata.
Il deux ex machina di Palazzo Farnese fu un uomo dall'intelligenza e dalla spregiudicatezza fuori dal comune. Al secolo si chiamava Alessandro Farnese ma alla storia è passato col nome da papa: Paolo III. Nato da una stirpe di piccolo cabotaggio originaria di Farnese nel Lazio settentrionale ma fermamente intenzionato a sollevare la propria schiatta al pari delle grandi casate romane, Paolo III Farnese usò ogni mezzo per raggiungere il suo scopo, abbondando coi mezzi illeciti. Non esitò, ad esempio, a gettare tra le braccia del cardinale Rodrigo Borgia la sua avvenente sorella Giulia, una delle donne più belle del suo tempo. E quando il Borgia venne eletto papa con il nome di Alessandro VI (1493), il Farnese divenne automaticamente segretario apostolico, protonotario, tesoriere pontificio, cardinale diacono e arcivescovo di Benevento. Non era la carriera ecclesiastica, tuttavia, ad assillare il cardinale. Accortosi che la sua famiglia rischiava d'estinguersi a causa di morti premature e matrimoni sterili, il cardinal Farnese prese energicamente in mano l'iniziativa. Trovò un'amante calda e affettuosa (Silvia Ruffini) e con lei procreò quattro piccoli Farnese, tre maschietti (Pier Luigi, Paolo, Ranuccio) e una femminuccia (Costanza).
Padre modello, pensò subito all'avvenire dei figli. Nel cuore di Roma comperò un vecchio palazzotto e alcune aree annesse e qui, nel 1514, gettò le fondamenta di un nuovo colossale palazzo a forma di dado destinato a diventare un condominio: il figlio Pier Luigi avrebbe abitato la parte anteriore, il figlio Ranuccio quella posteriore. E il figlio Paolo? Niente, perché era morto in fasce.
Inizialmente, i lavori andarono un po' per le lunghe e si interruppero con il sacco di Roma (1528). Ma nel 1534 le sorti si capovolsero. Alessandro Farnese diventa papa e sceglie il nome di Paolo per ricordare il figlio morto. In quindici anni d'assidui lavori Palazzo Farnese viene tirato in piedi grazie all'impegno del Sangallo e di Michelangelo. All'interno, il Salviati, gli Zuccari e Daniele da Volterra ammantano sale e camerini con affreschi che celebrano i fasti della casata. E in contemporanea arrivano quadri e arredi: dipinti di Tiziano, arazzi, mobili e soprattutto statue antiche, che i Farnese trovano soprattutto nelle Terme di Caracalla. Paolo III è infatti riuscito a impossessarsi delle possenti rovine delle terme per farne cave di marmi da destinare al palazzo. E scavando emergono gruppi colossali come il Toro Farnese che viene portato a palazzo e posto accanto ad altre statue quali l'Ercole Farnese, la Flora Farnese, l'Atlante Farnese, la Venere Callipige (cioè «dal bel sedere»), tutte collocate nei sottarchi dei cortili o pensate per decorare i giardini retrostanti. Nel palazzo si accumulano anche inestimabili tesori come i cammei appartenuti a Lorenzo il Magnifico, tra i quali spicca il cammeo più celebre di tutta l'antichità: la Tazza Farnese.
Alla morte del papa (1549), i cardinali Alessandro, Ranuccio e Odoardo continuano ad arricchire il palazzo fino alle soglie del Seicento, quando Annibale Carracci viene chiamato a decorare la galleria verso il giardino e realizza il più bel ciclo d'affreschi profani che ci è dato di ammirare in Roma.
Ma, quando a metà Settecento Elisabetta Farnese – ultima erede della casata – sposa un Borbone di Spagna, le collezioni di famiglia passano alla nuova dinastia. E inizia la dispersione degli arredi: il grosso delle statue e i quadri partono per la Napoli borbonica, il resto viene sparso ai quattro venti. I Borboni si tengono stretta la proprietà del palazzo romano fino al 1911 quando vendono l'immobile alla Francia che ne fa sede della propria ambasciata in Italia. Nel '36 il nostro Paese compra Palazzo Farnese lasciando invariata la sua destinazione diplomatica.
Adesso Palazzo Farnese ci aspetta. La mostra in arrivo inizierà dal cortile, dove le sagome delle più celebri statue farnesiane (Ercole, Flora e Toro) troveranno posto nei punti in cui erano state collocate in antico. Ai piani nobili – dove ci stupirà l'imponenza degli ambienti e la bellezza degli affreschi – le nicchie si ripopoleranno di statue (i Daci e l'Apollo di Napoli), le gallerie di busti di imperatori e di sapienti, le pareti di arazzi e di mobili (come il colossale monetiere di Fulvio Orsini, bibliotecario dei Farnese). Nei camerini troveranno posto cammei, monete e medaglie mentre nel Gran Salone si potranno ammirare progetti e disegni architettonici legati alla fabbrica del palazzo. Nella Galleria dei Carracci saranno invece riuniti, in spettacolare sequenza, i disegni e gli studi preparatori legati alle pitture soprastanti.
Infine, ci saranno i quadri, distribuiti lungo tutte le gallerie. Tra questi spiccherà il ritratto del padrone di casa, Paolo III Farnese, immortalato da Tiziano. Il pittore aveva ritratto il vecchio e sospettoso pontefice dopo alcune pose. Narra il Vasari che il maestro era solito porre i suoi dipinti davanti alle finestre per farli asciugare meglio. In questo caso, l'abitudine generò un gustoso equivoco: i cortigiani che transitavano davanti al palazzo papale, vedendo il pontefice affacciato alla finestra e scambiandolo per quello vero, cominciarono ad inchinarsi e scappellarsi con filiale riverenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
da leggere sul tema catalogo farnese
Firenze
Giunti
Da leggere è naturalmente il catalogo della mostra, curato da Francesco Buranelli e Roberto Cecchi
sculture farnese
Milano
Electa
Eccezionale catalogo scientifico delle statue appartenute ai Farnese e ora conservate nel Museo archeologico nazionale di Napoli
Studi di glittica
Roma
Erma di Bretschneider
Gli studi più aggiornati sui cammei antichi in un libro promosso dalla Fondazione Santarelli di Roma
Souvenir
Bari-Roma
Laterza
Antonio Pinelli racconta l'industria dell'antico e il Grand Tour a Roma
palazzo farn(è)se. le collezioniRoma, Palazzo Farnesedal 17 dicembre 2010 al 27 aprile 2011www.palazzofarnese.it (prenotazione obbligatoria)
© Riproduzione riservata