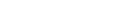Da quando ho scritto il libro Il David in carrozza – pubblicato da Longanesi due anni orsono e dedicato alle avventure di viaggio delle opere d'arte – mi sono stati segnalati numerosi e rocamboleschi trasporti d'arte.
Uno di questi credo valga la pena di essere raccontato perché riguarda nientemeno che il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, un manoscritto d'appunti e disegni d'inestimabile valore conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano.
Protagonista del "trasporto speciale" è stato Arturo Aletti – oggi stimato professionista ed esponente di una famiglia lombarda attiva nelle banche e nella Borsa – che all'epoca dei fatti, la primavera del 1972, era un giovanotto di belle speranze, più appassionato d'auto e di discoteche che di libri e manoscritti antichi. Ciò che accadde – confessa ancor'oggi Aletti – «fu l'avventura più importante della mia vita». Per questo ha accettato di rievocarla.
Occorre però iniziare dall'antefatto. Nel 1968 il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, allora rilegato in un unico grande volume, venne portato da Milano all'Abbazia di Grottaferrata presso Roma per essere smontato, restaurato e rilegato di nuovo. Non conosciamo le modalità del trasporto d'andata, ma possiamo intuire che avvenne nella massima discrezione e in forma privata, cioè senza ricorrere a ditte di trasporti, mezzi speciali o scorte armate.
Quando nel 1972 il restauro venne completato, la Biblioteca Ambrosiana dovette pensare al viaggio di ritorno. Non era cosa da poco, perché se nel viaggio d'andata gli oltre mille fogli del codice si trovavano incollati dentro un unico libro, dopo il restauro a Grottaferrata i fogli di Leonardo erano stati separati e rimontati in dodici, imponenti volumi, sontuosamente rilegati in pelle.
Il "carico", insomma, s'era fatto davvero ingombrante e bisognava trovare qualcuno in grado di affrontare bene la nuova incombenza. A organizzare il viaggio di rientro vennero allora chiamati due fidatissimi parroci milanesi, don Giuseppe Lattanzio e don Luigi Michelini, i quali optarono, ancora una volta, per una "soluzione" strettamente privata. Nonostante l'ingombro del carico, si pensò di riportare a Milano il Codice Atlantico di nuovo in incognito usando una comune automobile. Ci voleva però un mezzo abbastanza capiente, soprattutto dotato di ampio bagagliaio: un'auto "familiare" sarebbe stata l'ideale. Don Michelini si mosse e trovò la soluzione. Chiese a un suo parrocchiano di fiducia, l'ingegner Franco Pavesi, di mettere a disposizione per una "missione segreta" la sua Peugeot 504 Giardinetta. L'ingegnere non solo accettò di prestare l'auto, ma indicò come abile autista (e all'accorrenza aitante guardiaspalle) il suo giovane nipote ventenne, Arturo Aletti, il protagonista della nostra storia.
«Sì, era la primavera del 1972 – ricorda Aletti –. Mio zio Franco venne a chiedermi di guidare la sua Peugeot Giardinetta per accompagnare a Roma due prelati che dovevano prelevare qualcosa di molto importante e di riportarli il giorno dopo a Milano. Mi disse di portare con me un abito scuro, una camicia bianca e una cravatta. Non aggiunse altro. Io, senza far domande, accettai all'istante: allora ero sempre pronto ad andare in giro e, nonostante dovessi scarrozzarmi due preti, mi allettava l'idea di poter dormire a casa di mia nonna Maria Pavesi, che viveva in un mitico superattico nel centro di Roma, e soprattutto di poter trascorrere una nottata di divertimento al Piper, la discoteca allora più in voga della Capitale».
Dunque, col pensiero rivolto al Piper, il giovane Aletti si mise senza indugio al volante.
«Partimmo una mattina di maggio del 1972. Durante il viaggio in autostrada mi annoiai a morte perché i due sacerdoti che non fecero altro che citare e commentare con eccezionale puntigliosità ogni singolo monastero, pieve e luogo sacro che potessero scorgere lungo il percorso. Solo quando chiesi che cosa stavamo andando a prendere di così importante a Roma, i due si fecero improvvisamente vaghi ed elusivi, sviando il discorso e chiedendomi, invece, se avessi portato con me l'abito blu e la cravatta nera come raccomandato dallo zio. Io li rassicurai».
Nel tardo pomeriggio il terzetto giunse a Roma. Don Lattanzio e don Michelini si fecero lasciare dietro Santa Maria Maggiore (dove esisteva un convitto di preti lombardi) e raccomandarono al giovane Aletti di passare a prenderli l'indomani mattina alle otto precise.
«Finalmente libero, andai a casa di mia nonna Maria, dove le feci compagnia fino al calar della sera. Quindi mi preparai per la nottata romana con destinazione Piper. Naturalmente feci le tre del mattino».
Il risveglio fu, ovviamente, un po' difficoltoso.
«Beh, sì, mi svegliai con un bel cerchio alla testa. Comunque alle otto precise, nel mio completo blu, mi presentai con la Peugeot Giardinetta a prelevare i due prelati. Che mi svelarono la nostra prossima meta: il Vaticano».
La Peugeot Giardinetta entrò dalla Porta di Sant'Anna. A questo punto – e solo a questo punto – i due sacerdoti spiegarono al giovane "autista" l'alta natura della loro missione.
«Mi dissero, con mia somma sorpresa, che saremmo andati da papa Paolo VI, il quale ci avrebbe ricevuti nei suoi appartamenti per una udienza privata, organizzata per salutare il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, che era stato sottoposto a un importante restauro nel Monastero di Grottaferrata e che ora andava riportato a Milano. Confesso che io, allora, ignoravo che cosa fosse questo Codice Atlantico, ma strabiliai al sentir pronunciare il nome di Leonardo».
Aletti cadde in preda all'agitazione. Chiese ai due sacerdoti se ritenessero sicuro portare in macchina a Milano un capolavoro simile. Ma i sacerdoti lo tranquillizzarono dicendo che la sicurezza del Codice era garantita dal fatto che sarebbe giunto a Milano totalmente in incognito.
«Io non mi tranquillizzai affatto. Don Lattanzio e don Michelini non sapevano che avevo fatto le ore piccole al Piper! E soprattutto non sapevano che mia nonna Maria, ovviamente ignara dell'altro "trasporto", mi aveva caricato in macchina un grosso aspirapolvere guasto da far riparare a Milano!».
In Vaticano la Peugeot Giardinetta parcheggiò dapprima nei pressi dello Ior. I due preti, accompagnati da Aletti, varcarono la porta dell'Istituto e dopo qualche minuto si presentò nientemeno che monsignor Marcinkus. Espletate alcune formalità (forse i pagamenti del restauro), il terzetto uscì dallo Ior e si diresse verso il Palazzo Pontificio.
«L'attesa dell'arrivo di Sua Santità – ricorda Aletti – fu abbastanza lunga ma avvenne in una splendida sala dove su alcuni tavoli erano stati sistemati dei grandi volumi rilegati in pelle: il Codice Atlantico era lì. Lo sfogliai e colsi l'interessantissima presenza di un anziano e carismatico frate con barba bianca che scoprii essere l'Archimandrita di Grottaferrata, il responsabile dei lavori di restauro».
L'attesa venne riempita da interessanti spiegazioni. Oltre a sfogliare pagine e pagine di disegni originali di Leonardo, Aletti venne estasiato da incredibili racconti su come erano ridotti i disegni prima del restauro e su come fosse stato possibile risanarli e recuperarli.
«Poi, apparve Sua Santità, un'esile figura ammantata di bianco che mi colpì ed emozionò moltissimo, nonostante la mia natura di giovane un po' anticlericale. Quando il Papa fu davanti a me, mi sprofondai in un inchino, cosa che fino a un attimo prima avevo pensato di non fare. Ma fu davvero inevitabile».
Dopo le strette di mano e la benedizione, don Lattanzio, don Michelini e il giovane "autista" Aletti si congedarono dal Papa. I dodici volumi di Leonardo vennero caricati nel grande bagaglio della Peugeot Giardinetta e accanto a essi venne trovato posto anche per l'aspirapolvere rotto della nonna che, alla fine, servì per mimetizzare meglio il preziosissimo "carico". La macchina partì alla volta di Milano.
«Durante il viaggio chiesi ai due sacerdoti se per caso avessero previsto di farci scortare da un'auto civetta per questioni di sicurezza. Ma loro mi risposero che avevano ritenuto meglio di fare una cosa che desse nell'occhio il meno possibile. La sola precauzione prevista era che uno di noi, a turno, sostasse sempre nella Peugeot a guardia del "carico", soprattutto nel caso di... soste fisiologiche negli autogrill dell'autostrada».
Nel tardo pomeriggio la Peugeot 504 Giardinetta entrò a marcia indietro nel cortile dell'Ambrosiana. I volumi di Leonardo vennero scaricati e finirono nei forzieri climatizzati della Biblioteca, dai quali oggi fuoriescono a rotazione per le mostre. Sul destino dell'aspirapolvere rotto della nonna, invece, non si hanno più notizie.
Arturo Aletti sorride e, dopo quarant'anni, ancora si emoziona: «Le confesso che dopo la mia famiglia e miei figli questo "trasporto speciale" è stata la cosa più importante della mia vita».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IN MOSTRA A MILANO
All'Ambrosiana i fogli a rotazione
Oggi pochi condividerebbero le modalità di viaggio raccontate qui accanto, ma è indubbio che gli spostamenti "privati" del Codice Atlantico avvenuti quarant'anni orsono raggiunsero il loro obiettivo: far rientrare in fretta, incolumi e con poca spesa gli appunti e i disegni di Leonardo nella sede naturale, la Biblioteca Ambrosiana. Da allora sino a oggi l'antica istituzione milanese ha cercato di valorizzare al massimo questo suo patrimonio leonardesco, in passato attraverso grandi mostre, più di recente attraverso il progetto d'esposizione tematica e a rotazione dei fogli del Codice. Fino all'11 settembre, nella Sala Federiciana della Biblioteca Ambrosiana e nella Sagrestia del Bramante, sarà possibile ammirare l'ottava mostra di questa serie, dedicata a «Leonardo: studi sul moto», a cura di Pietro C. Marani e Juliana Barone (Catalogo De Agostini). La rassegna si colloca all'interno del progetto culturale promosso dalla Biblioteca Ambrosiana di offrire fino al 2015 la visione completa del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. In questa occasione s'è puntato sugli studi e gli scritti dedicati al tema del moto: in natura, nell'uomo, negli animali e nella meccanica.
© Riproduzione riservata