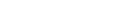Vienna 1968. Una ragazza con un bel cappottino porta al guinzaglio un uomo a quattro zampe. È Valie Export, star della performance femminista, insieme a quel Peter Weibel che sarebbe poi diventato un teorico dei new media. Quell'immagine può essere assunta come simbolo dello spartiacque tra un prima e un dopo, tra un tempo in cui la provocazione a sfondo erotico aveva caratteri progressivi e un tempo, il nostro, in cui l'esibizione del sesso è diventata quasi sempre un sintomo regressivo, legato al lucro della pornografia. Questo passaggio è al centro di un ampio volume appena uscito, Whatever Happened to Sex in Scandinavia, a cura di Marta Kuzma e Pablo Lafuente: un libro autonomo ma anche il catalogo a posteriori di una mostra tenutasi lo scorso anno a Oslo, presso l'Office for Contemporary Art.
La rassegna si apriva con un Vampiro di Edvard Munch del 1895: l'artista ha sempre visto la donna come un meraviglioso pericolo; nella terra dove d'inverno la luce appare circa tre ore al giorno, l'esame dell'interiorità e anche dell'erotismo era più avanzata che altrove, come anche la ricerca di una struttura sociale rasserenante. La Norvegia, non a caso, è stata la prima Nazione in Europa a dare il voto alle donne e il suffragio universale: loro nel 1913, noi nel 1947. In effetti, tutta la Scandinavia è stata terra di comportamenti rivoluzionari sul piano della coppia e della famiglia. Ma poi, cosa è successo al sesso nei Paesi nordici e nel resto del mondo occidentale?
Negli anni Sessanta "la svedese" era un mito: quella bellissima e che per di più ci sta. Dietro a questo stereotipo c'erano stati, dall'inizio del Novecento, decenni di ricerca sulla necessità di svincolare il sesso dalle nascite, sulla possibilità di considerare l'aborto una decisione libera della donna, sull'opportunità di una condivisione del potere tra maschi e femmine, sull'accettazione dell'omosessualità. Nel libro troviamo raccolti tutti i testi che hanno tessuto questa trama corale, spesso di incredibile modernità.
La differenza tra l'apertura mentale scandinava e certo moralismo americano fu palpabile quando, nel 1968, il film svedese I Am Curious-Yellow di Vilgot Sjoman fu bandito negli Stati Uniti: di contenuto politico, il suo potenziale eversivo fu considerato tanto più temibile in quanto conteneva scene di nudità frontale anche maschile. Alla radice dei cambiamenti in corso, dunque anche di quel film e dello scandalo che suscitò, stavano la disgregazione della famiglia rurale, il ruolo crescente delle donne nel lavoro e la diminuzione e il controllo della prole. Sul piano teorico, furono fondamentali i testi degli psicoanalisti del dopo-Freud, da La Rivoluzione sessuale di Wilhelm Reich (1936) ed Eros e Civiltà (1955) di Herbert Marcuse. La rivista «Evergreen Review», organo intellettuale del mondo beat e hippie, sfidava continuamente il pubblico con immagini di nudità e amore libero commiste a saggi dotti e a testi classici censurati.
L'arte contemporanea aveva toccato il tema del rapporto tra corporeità e politica con performance come un'orgia simulata di Carolee Schneemann con persone, cose e animali, i disegni di Lee Lozano che alludono a parti anatomiche in stile cartoon, le performance con corpi nudi e disegnati in modo clownesco di Yayoi Kusama. E con un grande contributo da parte della cinematografia sperimentale: in prima fila Andy Warhol, capace anche di produrre film sia per il mondo chiuso delle galleria sia per le sale commerciali come Trash di Paul Morrissey. Ma il libro ci spinge a riscoprire anche registi meno noti. Paul Sharitz montò un loop in cui un mandala colorato artificialmente mostra immagini rotanti e allucinogene di una bocca, di un pene, di una mano che taglia l'altra con una lametta (Razor Blades, 1965-68). Stan Brakhage girò nel 1961 un film senza trama, Dog Star Man, in cui la fisicità dell'uomo è messa in relazione con la natura e con ideali di pace, amore e pensiero. Lo stesso artista, però, dovette in seguito prendere le distanze da una lettura semplificata del suo lavoro, visto come un inno a quel "Peace&Love" che venne avvicinato a un più superficiale "Drug&Sex". E non fu il solo a essere mal compreso.
La Scandinavia era avamposto naturale per le tematiche della liberazione, già da quegli anni Trenta in cui Oslo era diventata una possibile via di fuga culturale dall'Europa del totalitarismo; similmente, Vienna era stata abituata alle tematiche del corpo dal movimento azionista e da un Novecento artistico fatto da ribelli come Klimt, Kokoschka o quell'Egon Schiele che chiedeva a giovani prostitute di stare ore in pose mortificanti; l'America era meno preparata a sopportare l'urto di un certo immaginario e quando questo divenne di massa – Woodstock è un buon esempio – iniziò a reagire in due modi: con la censura, da un lato, fatta di dossier dei Servizi di Stato, e dall'altro usando la libertà che avanzava come un mezzo per nutrire la società dello spettacolo. Cinema, pubblicità, gadget iniziarono a usare l'eros e non hanno più smesso.
Paradossale ma vero, i movimenti di liberazione sessuale sono stati condotti al risultato opposto: una nuova prigione, i valori della seduzione come mezzo per vendere. Già nel 1973 il filosofo Jean François Lyotard ha usato il termine svedese posering come sinonimo di mostrare il corpo (a questo punto solo femminile) come un oggetto di consumo. Dieci anni dopo il regista Harun Farocki ha prodotto un film in cui ha ricostruito il backstage di un set pornografico per «Playboy». Ancora oggi la sessualità è un campo di battaglia con cui gli artisti , come noi tutti, facciamo costantemente i conti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Marta Kutzuma-Pablo Lafuente, Whatever Happened to Sex in Scandinavia, Koenig Books, London e Oslo, pagg. 530, € 37,25
© Riproduzione riservata