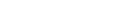Palazzo Reale regala in questi mesi una delle mostre più intense e sconvolgenti degli ultimi anni: un percorso di durissima denuncia che fa riflettere, e spesso rabbrividire, pur conservando sempre un assoluto controllo formale e un'alta qualità poetica. Complici la curatela di Francesca Alfano Miglietti, di cui si avverte a ogni passo l'emozionata partecipazione, e l'allestimento sobrio, privo degli "effetti speciali" oggi così alla moda, l'arte di Fabio Mauri (1926-2009) ritrova in questa retrospettiva, accompagnata da un bellissimo catalogo Skira e realizzata con lo Studio Fabio Mauri di Roma, tutta la forza del suo messaggio di dolore e di vergogna. Lo stesso dolore e la stessa vergogna che nella sua generazione hanno marchiato chiunque portasse in sé un seme di senso morale ma che in lui hanno scavato una voragine, tanto da imporre, a guerra finita, il ricovero in una casa di cura per malattie mentali, dove sarebbe stato sottoposto all'unica, terribile terapia allora conosciuta, l'elettrochoc (ne avrebbe subiti 33).
Lui che non era ebreo, degli ebrei condivise infatti, seppure idealmente, la tragedia con tanta intensità da cadere nella malattia: «Mi sento ebreo ogni volta che posso, e patisco ingiusta discriminazione» ripeteva. Ed Ebrea, 1971, è non a caso l'opera più angosciosa dell'intera mostra: una grande, pausata installazione, fatta di oggetti banali (una poltroncina, una consolle anni 40, delle saponette, degli sci, un piccolo "gioiello") disposti intorno a un cavallo bardato. L'allarme scatta se si spinge lo sguardo alla parete più lontana, dove su uno specchio è tracciata una stella di Davide. Ci si avvicina e si scopre che è fatta di ciocche di capelli e che proprio accanto c'è una di quelle macchinette con cui nei campi di sterminio si rasavano brutalmente i capelli ai nuovi arrivati. Si leggono allora le didascalie di ogni opera e si scopre che il "gioiello" è formato da denti umani montati su oro, che le pelli da sci sono (citiamo) «eseguite con Oswald e Mirta Rohn catturati a Davos», che ogni sapone porta il nome di un campo di sterminio e che la sedia è in «pelle ebrea» così come i finimenti del cavallo. Scattano allora, immediatamente, un angoscioso sentimento di sacralità violata della vita e un invincibile istinto di fuga, accompagnati da un profondo, appiccicoso senso di vergogna. Eppure queste emozioni non sono generate da scene cruente, né dalle orribili fotografie dei campi di sterminio che ci inseguono dalla fine della guerra, bensì da una sorta di campionario di oggetti apparentemente neutri, che solo a uno sguardo più ravvicinato rivelano l'orrore di cui sono impregnati: la «banalità del male» di Hannah Arendt. Del male lui del resto sapeva di essere, suo malgrado, un grande intenditore: «La mia arte sottolinea il male, per il quale ho un certo occhio», amava ripetere.
Presentando questo lavoro alla galleria romana La Salita, nel 1971, Mauri spiegò che «in Ebrea l'operazione è fredda. E indelicatamente culturale. Ricompio con pazienza, con le mie mani, l'esperienza del turpe. Ne esploro le possibilità mentali». Ed è un esercizio che lui, artista visivo, drammaturgo e fine intellettuale, compie in tutte le sue opere, servendosi di sofisticati strumenti concettuali, tutt'altro che afasici però, capaci anzi di "risuonare" in ognuno di noi. Con essi procede nella ricerca di ciò che definisce la «moralità dell'arte» e, conscio di non fare politica ma "coscienza", parla del mondo «come è, come è stato e come non avrebbe dovuto essere» (così Umberto Eco nella prefazione di Fabio Mauri. Ideologia e memoria, Bollati Boringhieri, 2012).
Anche più sottile e (freudianamente) "condensato" è Muro d'Europa, presentato in Biennale a Venezia nel 1993: valigie consunte e sformate, alcune di pelle lussuosa, altre di materiali poveri, composte in una sorta di muraglia che evoca il Muro del Pianto, unico frammento del tempio di Gerusalemme sopravvissuto alle legioni di Tito: il luogo più sacro d'Israele. Ma qui, per via delle valigie, simbolo anche delle partenze atterrite e convulse dei deportati di ogni classe sociale e delle peregrinazioni di un intero popolo che per millenni è stato costretto alla fuga.
Mauri è però anche un grande innovatore dei linguaggi dell'arte tanto che oggi il suo lavoro è più che mai attuale (straordinario il successo riscosso dalla performance Che cosa è la filosofia. Heidegger e la questione tedesca. Concerto da tavolo, 1989, voluta da Carolyn Christov-Bakargiev a Documenta 13). In mostra lo provano lavori come la performance Intellettuale. Il Vangelo secondo Matteo di/su Pier Paolo Pasolini, 1975, in cui proiettava il film sul torace del suo autore («una radiografia dello spirito» la definì Mauri); o Senza ideologia, 1975, proiezione del l'Alexander Nevskij di Eisenstein su un secchio di latte (impossibile non pensare al celebrato Tony Oursler). E lo ribadiscono gli Schermi, i precocissimi monocromi avviati già alla fine degli anni 50, poi abitati dalle parole Fine o The End, che alludono a un mondo inteso come «una grande, e solo parzialmente decifrata, proiezione», o gli zerbini traforati dalle lettere di enigmatici enunciati (proprio come nei sipari di Rosa Barba), in un'inseparabile fusione di forma e contenuto. E forse di questo suo dono profetico Mauri era consapevole, se lasciò scritto: «Non riesco a essere del mio tempo. O sono prima o sono dopo, contemporaneamente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Fabio Mauri. The End, Milano,
Palazzo Reale, fino al 23 settembre.
Ingresso gratuito. Catalogo Skira
© Riproduzione riservata