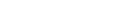A Bologna soffierà il vento dell'Est, quello del Baltico, della Russia e di una ventina di Paesi che al tempo del Patto di Varsavia erano "protetti" dall'Unione Sovietica e separati dal resto del mondo dalla cortina di ferro. A volere un focus sull'arte contemporanea dell'Est Europa è Giorgio Verzotti – direttore artistico della manifestazione – che ha chiamato uno specialista del calibro di Marco Scotini a curare sia la sezione in Fiera, con le gallerie di questa vasta area geografica riunite tutte in un settore specifico, sia la grande mostra che si aprirà al Museo Archeologico dal 24 gennaio al 16 marzo. Il titolo «Il Piedistallo vuoto. Fantasmi dall'Est Europa» mette un po' soggezione, ma la mostra è di quelle da non perdere perché Scotini – che segue gli artisti di questo spicchio del mondo da prima che cadesse il muro di Berlino (1989) – è riuscito in un piccolo miracolo. Costruire in Italia una mostra con 100 opere di 40 artisti da 18 Paesi dell'ex blocco sovietico provenienti da importanti collezioni private italiane. «È un'iniziativa inedita: una collaborazione fattiva e concreta fra una fiera d'arte e il mondo del collezionismo italiano», dichiara Duccio Campagnoli, presidente Bologna Fiere. «È un'importante occasione per fare il punto su una delle regioni più interessanti dell'arte contemporanea, dove i linguaggi si stanno innovando con rapidità pari agli assetti economici, socio-politici e quindi – marxianamente – culturali», gli fa eco Gianfranco Maraniello, direttore Istituzione Bologna Musei.
L'evento dimostra la vitalità, l'intelligenza e la lungimiranza dei collezionisti italiani e presenta una selezione di autori concettuali degli anni Settanta come i russi Ilya e Emilia Kabakov, la serba Marina Abramovic, il ceco Jiri Kovanda, fino ai più giovani e già noti in tutto il mondo come lo scultore polacco Pawel Althamer o gli albanesi Anri Sala e Adrian Paci. «Una mostra così articolata non si sarebbe potuta fare pescando nelle raccolte pubbliche» spiega Scotini, mentre la qualità dei prestiti privati conferma l'esistenza in Italia di uno straordinario talento collezionistico, che talora ha la rara capacità di individuare in anticipo e di leggere in profondità le espressioni artistiche che stanno delineando il futuro. Tra i prestatori non mancano Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Dmitry Gutov, Mircea Cantor, Janis Avotinš), Fondazione Nicola Trussardi (Pawel Althamer), Fondazione Morra-Greco di Napoli (Julius Koller), Enea Righi di Torino (Roman Ondák), La Gaia di Torino (Ion Grigorescu), Maramotti di Reggio Emilia (Thea Djordjadze, Tobias Putrih), Gemma Testa (Marina Abramovic), Collezione Unicredit, Collezione Consolandi, Collezione Agiverona di Giorgio Fasol, Collezione Cotroneo, Collezione Vittorio Gaddi, Fondazione Videoinsight, Collezione Together e altre che preferiscono l'anonimato.
«Ciò che chiamiamo Est è un museo della storia a cura dell'Ovest» ha scritto recentemente Boris Buden e Scotini – nei panni del demiurgo –, ci porta a dire che sì, forse è proprio così. Il suo racconto per immagini incomincia con un monumentale lampadario di tre metri con l'insegna luminosa «Enter the Ghost, exit the Ghost», è dell'albanese Armando Lulaj, classe 1980, che cita l'Amleto di Shakespeare; collocato nel cortile del palazzo ci introduce all'interno del museo archeologico, dove ci dà il benvenuto un celebre lavoro dello slovacco Roman Ondák, classe 1966. È Silence please, una modesta sedia vuota; è quella del custode del museo, lui non c'è, forse è evaporato come un fantasma lasciando soltanto la sua giacca di foggia demodé.
«"Il Piedistallo vuoto. Fantasmi dall'Est Europa" non è un'operazione nostalgica – ci tiene a sottolineare Scotini – ma una mostra che già dal titolo racconta potenzialità che si stanno ancora esprimendo». Come? Attraverso la tensione ideale del vivere l'arte come un valore d'uso e non un valore di scambio, suggerisce il curatore: il cadavere è caduto a terra, ma l'idea è rimasta in piedi. Il piedistallo appare dunque come il continuo bersaglio di un gioco in cui il fantasma non muore mai e ciascun potere di turno cerca di svuotare in anticipo il luogo sacro dell'idolo profano che l'ha preceduto. Lo fa capire l'artista kazako Yerbossyn Meldibekov nel progetto Family Album (2008), dove vengono messi a confronto dittici fotografici scattati in epoche diverse. Gli stessi nuclei familiari, secondo un identico carattere rituale, si ritrovano fotografati, a distanza di anni, di fronte allo stesso monumento. Il piedistallo contro cui posano e lo stesso, ma la statua risulta diversa, rimpiazzata. Nell'Asia Centrale post-sovietica, al posto di Lenin non si e sostituita nessuna effige dell'attuale rappresentanza politica, ma sono stati ricollocati simboli di un passato nazionale mitico e ideologizzato, come i busti di Tamerlano o di Ablai Khan. «Attraverso queste immagini – riflette Scotini – si ha l'impressione che la storia della regione venga riscritta ogni venti anni: dalla fase post-coloniale russa a quella sovietica, a quella infine attuale dell'indipendenza nazionale delle nuove oligarchie orientali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© Riproduzione riservata