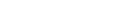Con l'importante mostra al Guggenheim di New York, il Futurismo italiano (a cent'anni dalla nascita) è stato finalmente reinstallato in America nel posto centrale dovuto a un'avanguardia che non solo ha riscritto i canoni estetici del XX secolo ma ha anche dettato alcuni dei temi attorno ai quali sta ruotando ancora la fine della modernità. C'è dunque da chiedersi quali tempi si meriti anche l'astrattismo italiano per essere riconosciuto come un fenomeno dai contorni originali e idiosincratici e non una semplice declinazione locale di fermenti e motivi espressivi elaborati altrove, in un' Europa scossa dai fremiti traumatici di due terribili guerre?
La domanda non è retorica e trova una risposta parziale nella bella mostra allestita al Mart di Rovereto sull'opera di uno dei maggiori esponenti dell'astrattismo, Mario Radice (1898-1987): curata da Giovanni Marzari, l'esposizione prende forza da un'ipotesi critica appassionata e dalla straordinaria mole (circa 1.700 pezzi) documentaria messa a disposizione dell'Archivio del 900 da parte delle figlie dell'artista e per la prima volta dispiegata in tutta la sua straordinaria evidenzia artistica e umana. Come scrive Federico Zanoner «l'archivio di Mario Radice al Mart ha tutte le caratteristiche della trama di un racconto d'avventura nel quale, prima o poi, la sovrapposizione di mappe conduce alla chiave del tesoro».
Questo è subito messo in chiaro invece da un efficace allestimento che dipana le stanze del museo come i capitoli di un racconto a trame aperte: con qualche colpo di scena tutt'altro che scontato in una mostra dedicata alla ricostruzione dell'universo del l'astrattismo. L'incipit infatti è una grande tela figurativa del 1933 – La partita di pallone – che se storicamente evidenzia che l'approccio di Radice al non-figurativo fu una scelta e non un punto di partenza, metaforicamente riassume l'intricata vicenda di un dibattito che vide molti luoghi – Milano e Como – e molti attori, Carlo Belli innanzitutto e Sartoris, che dell'astrattismo proposero visioni diverse e anzi contrastanti: neoplatonico, per quelli di stretta osservanza; spirituale e legato alla natura per Radice, «astraente, ma non astratto» come suggerisce in catalogo Francesca Bacci.
Radice nacque a Como che contribuì a far diventare, insieme ai suoi compagni di strada – artisti Manlio Rho, Aldo Galli, Carla Badiali e architetti come Giuseppe Terragni, Cesare Cattaneo e Alberto Sartoris – la capitale spirituale del razionalismo italiano, defilata e provinciale rispetto ai centri nevralgici come Parigi o Berlino, ma proprio per questo peculiare nei modi del suo svolgimento e nei caratteri del suo approccio al tema della non-figurazione. Parzialmente autodidatta, Radice dunque non nacque astrattista: come Mondrian o Kandisky, l'astrattismo fu un traguardo nella tenace ricerca di un'armonia fondata sulla disciplina delle «forme in quanto forme», dell'ordine della geometria, del culto della proporzione: quella stessa che Giuseppe Terragni, sempre a Como, anticipava audacemente in architettura, incarnandola nella sua opera-manifesto, la Casa del Fascio, nella cui decorazione coinvolse in maniera strutturale l'amico Radice accellerandone il salto dalla figura umana a quella geometrica.
La ricostruzione "astratta" della celebre sala del direttorio con l'immagine sospesa del "corpo" mistico del Duce è la scena forte dell'allestimento: il punto di fuga che dall'ingresso allude alla ricostruzione ideale di una prospettiva quasi rinascimentale, dove al posto delle statue di dei o eroi, troviamo le "virgole" armoniose di Melotti, gli angeli sfrontati di Licini o le irruenti forme plastiche di Fontana. Mai come in quest'occasione infatti l'allestimento di una mostra implica l'intelligenza critica della curatela e la suggestione della proposta comunicativa, in modo che la stessa disposizione – con gli accostamenti delle opere – prenda la forma di un discorso per immagini.
Dopo gli studi fondativi di Luciano Caramel, il percorso artistico di Radice viene riproposto nel confronto con i vari "astrattismi" di Soldati, Veronesi, Magnelli, Munari,eccetera e con le coinvolgenti collaborazioni con Terragni e Cattaneo (da cui nacque la nota Fontana di Camerlata), alla luce di materiali inediti: da quelli preparatori delle sue opere più famose alla serie sterminata di schizzi minuti sui quali l'artista annotava miriadi di iscrizioni e di numeri che rendono a volte ancora più ardua la datazione dei singoli lavori e simile a un labirinto con parecchie vie d'uscita il complesso dell'opera. Una di queste è poi il cuore segreto della mostra: un tabernacolo dalle pareti inclinate, dove sono esposti piccoli dipinti e disegni chiamati «Crolli», che Mario Radice realizzò negli anni cruciali fra il 1939 e il 1945 registrando in modo originale gli orrori e la tragedia della guerra, ma anche il presentimento della fine di una stagione artistica vissuta tra le "difficoltà politiche" del fascismo.
La sua vicenda biografica e artistica diventa così il filo rosso di una matassa più vasta, entro cui si tesse l'ingarbugliata storia del Paese, per le sue peculiari convergenze con l'architettura, per le sue inevitabili collisioni con le pretese totalizzanti della politica, per i suoi altalenanti rapporti, infine, con i grandi cantieri dell'astrattismo internazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Mario Radice. Architettura, numero, colore, a cura di Giovanni Marzari, Rovereto (Tn), Mart, fino all'8 giugno. Catalogo Electa.
Info: info@mart.trento.it
© Riproduzione riservata