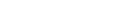«Galleria con vista» la definisce Luca Massimo Barbero, il suo direttore artistico. E in effetti la nuova Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, appena inaugurata a Verona in Palazzo della Ragione, «acciambellata» com'è intorno all'altissima torre medievale dei Lamberti, include nel percorso di visita anche questo vertiginoso punto d'osservazione sulla città. Prima tappa del recupero è stata la restituzione alla città del Palazzo, con la torre, i saloni del piano nobile che ospitano la Gam –di recente restaurati su progetto di Afra e Tobia Scarpa grazie a Fondazione Cariverona– e la riapertura dopo decenni dello scalone del '400. Dalla cui sommità, attraverso un nuovo «taglio» vetrato, si può vedere sin dall'esterno il dipinto-icona della Gam: la Meditazione di Hayez del 1851.
Affacciato da un lato sulla Piazza delle Erbe (il Foro della città romana), dall'altro su Piazza dei Signori, con il monumento a Dante, che trovò rifugio e onori alla corte scaligera, il palazzo, della fine del XII secolo ma più volte rimaneggiato, è da sempre l'architettura civile per eccellenza di Verona. E le 150 opere della Gam, selezionate nelle collezioni civiche (dono del primo '900 di Achille Forti) e nelle raccolte di Fondazione Cariverona e Fondazione Domus, si intrecciano qui con naturalezza con le vicende della città, grazie anche a un allestimento che nasconde il rigore dell'impianto scientifico sotto un racconto capace di narrare in modo coinvolgente cento anni di storia e di arte veronesi, dal 1840 al 1940.
Le scoperte non mancano, nell'800 come nel '900. L'indagine sulle glorie locali, spesso appannate dal tempo, ha portato alla luce tra le altre un'opera inattesa per il tema come per la qualità, che si rivela sin dalla sala d'ingresso, dove s'incunea la torre: è l'Orgia, 1851-1854, un marmo del dimenticato (morì a nemmeno 30 anni) ma eccezionalmente dotato Torquato Della Torre, che raffigura una donna nuda e ubriaca che calpesta il Vangelo, mentre intorno, in un carosello di invenzioni morbose e visionarie, si affacciano pipistrelli, serpi, teschi. Non stupisce che l'autore abbia dovuto esporla (anche qui con grande scandalo) a Firenze anziché nella sua città. E che questo artista sia uno dei frutti più succosi dello «scavo» condotto nelle collezioni civiche è provato poi dal suo gesso del Paolo Veronese e dal marmo del Gaddo dantesco, qui posto dirimpetto al Dante di Ugo Zannoni, piccola replica in bronzo del monumento che sta appena fuori. Il gioco di rispecchiamenti continua con le vedute ottocentesche del Palazzo della Ragione, affiancate da fotografie d'epoca che documentano il volto dell'edificio alla fine dell'800, prima dell'intervento «risanatore» di Camillo Boito. Mentre il passo cambia, per puntare sulla storia dell'arte, nella Sala Quadrata, dove entrano in scena le novità che sconvolgono i linguaggi artistici di fine secolo: con le forme liquide delle due cere-capolavoro di Medardo Rosso, ecco la luce del divisionismo del magnifico S'avanza di Angelo Morbelli e il simbolismo «addomesticato» di Alfredo Salvini, dimenticato ma oggi ben più interessante dell'allora celebratissimo Angelo Dall'Oca Bianca. Sono le premesse alle avanguardie, che occupano la successiva Sala Picta, dove si amministrava la giustizia. Ed è qui che ci si imbatte, tra gli altri, nei convulsi paesaggini giovanili di Arturo Tosi (nulla a che vedere con quelli, più noti ma più ovvi, che seguiranno) e in alcune autentiche gemme del giovane Felice Casorati, sensibile al vento secessionista che scendeva dall'Austria: il Ritratto di Teresa Madinelli, 1918-1919, la colta dama veronese che lo «adottò» al suo arrivo in città, con la prospettiva impercorribile del pavimento a scacchi e l'incarnato gessoso dalla donna, è un capolavoro del più puro gusto secessionista, al pari della klimtiana Preghiera (su panno: da vedere da vicino) che chiude la sala insieme al magnifico gesso di Wildt. Nel mezzo c'è l'avanguardia dei dissidenti di Cà Pesaro, con una sorta di personale del raro Gino Rossi, poi Semeghini, il giovane Boccioni, il sorprendente Guido Trentini – lui veronese – con la folgorante Pianta rossa, 1914. Loro guardavano a Nord ma non manca l'avanguardia «francofila» del giovane Giorgio Morandi (le splendide Bagnanti, 1915) e di Soffici e Severini cubo-futuristi. Passati per la Cappella dei Notai, rivestita di sfavillanti pitture del Sei-Settecento, il percorso si chiude con l'arte degli anni tra le due guerre. Anche qui si rincorrono opere fascinose dei protagonisti del tempo: de Pisis e Savinio, de Chirico e Donghi (queste di Unicredit), poi Cagnaccio di San Pietro con il suo glaciale realismo, fino alla superba Donna che nuota sott'acqua di Arturo Martini, 1940 (montata su uno specchio, rivela che l'autore la «decapitò»: erano gli anni della sua disillusione per la scultura) e al magnifico Cavallo e cavaliere in gesso di Marino Marini che, messo com'è a confronto con i cavalli roboanti del locale Pino Casarini, sembra voler evocare la parlata sobria e severa del monumento equestre a Cangrande.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© Riproduzione riservata