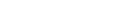Una delle meraviglie di Lombardia si trova nel Duomo di Monza, nella Cappella alla sinistra del presbiterio. Qui, in una teca, è conservato un gioiello celeberrimo, la Corona Ferrea, che serviva per incoronare i re d’Italia. Ma la meraviglia cui vogliamo alludere non è lo storico diadema bensì la rutilante decorazione sulle pareti della cappella. Si tratta di uno spettacolare ciclo di 500 metri quadri di pitture murali (non affreschi) realizzati dalla famiglia degli Zavattari, un clan di pittori lombardi imparentati tra loro che agirono qui tutti insieme negli anni Quaranta del Quattrocento. Ne sortì un ciclo di pitture dal tono fiabesco e in puro stile gotico cortese che racconta le storie della sovrana longobarda fondatrice del Duomo di Monza: la celebre regina Teodolinda.
La Cappella di Teodolinda è stata (per fortuna) risparmiata dai rifacimenti che trasformarono l’interno del Duomo dal Cinquecento al Settecento. Certo, non è potuta sfuggire ai maldestrissimi restauri che tra Settecento e Ottocento l’hanno molto danneggiata, ma nel complesso la cappella è resistita bene al maglio del tempo e dell’uomo.
L’ultimo restauro moderno era stato messo in campo nel 1960 e attorno al 1990 ci si era resi conto che la cappella iniziava, di nuovo, a dar segni di cedimento. Fu proprio in quella occasione che i coniugi-imprenditori Franco e Titti Gaiani cominciarono ad appassionarsi al tema. Titti Gaiani, allora presidente del Soroptimist, fece studiare a tappeto la cappella dal punto di vista storico e tecnico, e questo studio prese la forma di un libro prezioso (La Cappella di Teodelinda nel Duomo a cura di Roberto Cassanelli) che avrebbe offerto le conoscenze di base per il futuro restauro.
Nel frattempo, un altro ambizioso progetto si profilò all’orizzonte: quello dell’ampliamento del Museo di Duomo di Monza. Affiancato al vecchio museo – detto Serpero, dal suo fondatore – sarebbe sorto un nuovo, spettacolare museo ipogeo nel quale conservare il ricco patrimonio di tesori altomedievali, viscontei e sforzeschi legati alla plurisecolare storia del Duomo. Nel progetto del nuovo Museo del Duomo, i coniugi Gaiani – tramite la Fondazione che porta il loro nome – ebbero un ruolo davvero determinante. E in occasione del taglio del nastro nel 2007, loro stessi fecero annunciare attraverso un convegno quale sarebbe stato il passo successivo: era giunto il tempo di restaurare il ciclo degli Zavattari nella Cappella di Teodolinda.
Affrontare da soli un progetto del genere sarebbe stato impensabile. Così la Fondazione Gaiani si è presa l’onere di concertare l’impresa. Dapprima sono state reperite le risorse: il World Monuments Found ha donato 600mila euro, la Marignoli Foundation 50mila, la Regione Lombardia un milione di euro e la Fondazione Cariplo un altro milione di euro (il resto è giunto dalla Fondazione Gaiani). Poi, è stato individuato il restauratore, nella persona di Anna Lucchini, la quale ha condotto i lavori a stretto contatto con la Soprintendenza lombarda e l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, altresì supportata dalle indagini diagnostiche condotte dall’Enea e dal Cnr Inoa. Parallelamente ai lavori di restauro, sono state messe in campo tutte le più innovative soluzioni illuminotecniche da parte di Osram e di Consuline, in modo da garantire al ciclo monzese la miglior illuminazione possibile.
Nel 2009 sono stati alzati i ponteggi e sono cominciati i lavori. L’impegno era di consegnare il cantiere per la fine del 2014 e possiamo dire che i tempi sono stati rispettati quasi al millimetro.
L’inaugurazione della Cappella di Teodolinda e dei suoi mirabili dipinti restaurati avverrà a metà maggio per un motivo preciso: si è convenuto di lasciare alzati i ponteggi ancora per tre mesi per permettere al pubblico di salire e ammirare da vicino le abbaglianti pitture degli Zavattari. «Osserva tu che passi» dice una frase latina dipinta sulle pareti «come i volti appaiano vivi e quasi respirino...». Approfittare dei ponteggi è un obbligo.
Il recupero delle pitture ha del miracoloso. Prima del restauro, i dipinti degli Zavattari erano sporchi, e in alcuni punti risultavano illeggibili. Ma ancor più grave era il fatto che in molti punti intonaci e ori di fondo risultavano staccati dalla muratura. Con lavoro paziente, alternando tecniche di pulitura tradizionale a laser di ultima generazione, la restautrice Lucchini e le sue otto colleghe (per Teodolinda hanno lavorato solo donne!) sono riuscite a ridare vita alle storie della regina longobarda.
Salendo sui ponteggi veniamo travolti da un tripudio di ori, abiti, acconciature, armi, cavalieri, cavalcate, spettacoli, cacce, musiche e, soprattutto, matrimoni, con il loro corollario di cerimonie, banchetti e feste danzanti. Si ha l’impressione di essere dinnanzi a una pagina miniata di dimensioni colossali.
Inoltre, capire che cosa narrino le pitture non è – di primo acchito – molto facile. Le fonti letterarie delle storie sono due: Paolo Diacono, storico ufficiale dei Longobardi vissuto nell’VIII secolo, e Bonincontro Morigia, storico della chiesa di Monza vissuto nel XIV secolo. I 45 episodi del ciclo si leggono dall’alto verso il basso, partendo dalla parete sinistra, in senso orario. Dalla prima alla ventitreesima scena sono descritti i preliminari e le nozze tra Teodolinda, principessa bavarese, e Autari, re dei Longobardi, e la sequenza finisce con la morte del re. Dalla scena 24 alla scena 30 sono invece raffigurati i preliminari e le nozze della regina con il suo secondo marito Agilulfo. Dalla scena 31 alla scena 41 sono raffigurate le scene che raccontano la fondazione della basilica di Monza e la fabbricazione del suo tesoro. Seguono la morte di Agilulfo e la morte di Teodolinda, dipinta – guarda caso – in prossimità del sarcofago della regina, appoggiato sul fondo della cappella. Il ciclo si conclude con un apparente “fuori tema”: il tentativo fallito di riconquista dell’Italia da parte dell’imperatore bizantino Costante. Tale fallimento è legato a una “morale” ben precisa: l’Italia reggerà finché la Chiesa di Monza reggerà quale custode fedele delle insegne regali (leggi Corona Ferrea).
Il ciclo suscita molti interrogativi. Ad esempio, perché in una chiesa si inneggia smaccatamente a una regina invece che a una santa? E perché nelle pitture si insiste tanto sulle scene matrimoniali? Per rispondere bisogna rifarsi al contesto dell’epoca. Bisogna sapere che, nel Quattrocento, Teodolinda fu a un passo dall’essere beatificata, e che l’enorme spazio riservato a scene matrimoniali è un chiaro richiamo all’importanza del matrimonio che unì Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza: da quelle fatidiche nozze sarebbe scaturito il futuro assetto dinastico del Ducato di Milano.
Monza si prepara dunque all’Expo offrendo al mondo intero i suoi “gioielli”: la Cappella di Teodolinda restaurata e il Tesoro del Duomo, ai quali va aggiunta anche la Villa Reale, riportata agli splendori regali da un recente, spettacolare restauro, curato dai Fratelli Navarra. Adesso Monza vale davvero un viaggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
PER LA VISITA
La salita sui ponteggi della Cappella di Teodolinda nel Duomo di Monza - per vedere da vicino le storie della regina longobarda, dipinte dalla famiglia Zavattari - è un’occasione unica per ammirare a distanza privilegiata le bellissime pitture ora recuperate.
La salita è rigorosamente contingentata. Possono accedere gruppi di 15 persone alla volta, condotte da una guida esperta che spiegherà i dipinti. Per orari e prenotazioni è necessario telefonare (+39.039.326383) o scrivere (info@museoduomomonza.it) dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
© Riproduzione riservata