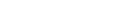È stato presentato lo scorso ottobre “La Cultura in Trasformazionei”, un libro curato da cheFare, l'associazione che si occupa di ricerca e analisi sulle trasformazioni del mondo culturale, ma che è maggiormente conosciuta per il suo omonimo premio. Il bando cheFare (dal 2012 al 2014 prodotto da doppiozero e divenuto poi una realtà a sé stante) ha vagliato in tre edizioni oltre 1.800 progetti di innovazione culturale e ha recentemente selezionato i tre vincitori della terza edizione per un contributo totale di 150.000 euro. Il libro è una raccolta di riflessioni sulle trasformazioni, avvenute negli ultimi 15 anni, del settore culturale di cui tutti i contributor sono stati attori - Alessandro Bollo, Roberto Casati, Paola Dubini, Vincenzo Latronico, Marco Liberatore, Gianfranco Marrone, Bertram Niessen, Ivana Pais, Christian Raimo, Jacopo Tondelli. A Bertram Niessen, direttore scientifico e presidente di cheFare, abbiamo chiesto cos'è cambiato nel mondo della cultura negli ultimi anni e quali sono le sue maggiori necessità.
Quali sono i principali cambiamenti che hanno caratterizzato il mondo culturale?
Sicuramente il primo grande cambiamento è la completa trasformazione dei mezzi di produzione e di fruizione del prodotto culturale. Sto parlando della rivoluzione digitale, soprattutto quella 2.0, che ha creato una situazione paradossale; da una parte ha reso i servizi culturali più accessibili, facendo del consumatore anche un produttore e curatore di contenuti culturali- il prosumer, ma dall'altra parte ha fatto crollare il valore unitario di molti contenuti. Questo da un punto di vista degli addetti al settore significa che il valore immateriale complessivo del prodotto culturale sta aumentando, ma la capacità di produrre reddito attraverso questi tipi di prodotti è diminuito drasticamente.
Conseguenze?
E' subentrata la necessità di reperire fondi a seguito del continuo taglio degli stanziamenti pubblici alla cultura; si è cercato quindi di entrare in un dialogo più strutturato con il mercato. Il problema è che molti operatori culturali, totalmente estranei alle dinamiche del mercato e senza le competenze necessarie, si sono costituiti in ‘impresa', che però non rappresenta la chiave di volta di tutti i problemi del settore. Logica spinta a volte troppo in avanti, esasperandola, fino a pensare all'azione culturale quasi esclusivamente entro logiche di consumo culturale. Ma, anche grazie a questa trasformazione, si sono consolidate nuove professionalità come quella del manager culturale. E si stanno inziando a vedere nuove modalità di interazione tra soggetti privati e cultura sui territori.
Quali sono, invece, i problemi principali che continuano ad affliggere questo settore?
Credo che di base ce ne siano due; uno di tipo puramente culturale, mentre l'altro è generazionale. Esiste un vero e proprio deficit culturale in Italia che pensa troppo spesso alla ‘cultura' esclusivamente come conservazione del patrimonio artistico, limitando gli investimenti al mantenimento di ciò che è “dato”, senza investire sulla promozione, sul contemporaneo e sulle dinamiche culturali partecipative che altrove sono sempre più al centro dei discorsi e delle pratiche.
E poi il problema generazionale?
Sì il grande problema, che non affligge solo il mondo della cultura, è quello della scarsa mobilità professionale intragenerazionale. C'è una classe dirigente del mondo della cultura, legata a dinamiche tradizionali e novecentesche che non riesce a pensare nei termini della trasformazione che sta avvenendo e a porre l'attenzione sui bisogni di sostenibilità economica e sociale del settore. Ovviamente quello dell'aggiornamento delle competenze e dell'apertura al cambiamento è un problema che, poi, si riversa a cascata su tutti gli altri operatori culturali.
Quali sono le principali necessità su cui lavorare per il prossimo futuro?
Negli ultimi anni si è cercato di recuperare il ritardo rispetto al resto del mondo, spesso comprimendo i problemi del sistema culturale, ricerca, musica, arte, editoria, spettacolo dal vivo, cinema ecc., in un unico grande contenitore. Sebbene questa possa sembrare una forzatura, essa ha portato a un continuo scambio tra settori che avrebbero dialogato più difficilmente; credo sia importante quindi continuare ad andare in questa direzione, lavorando alla costruzione di gruppi di pressione che ragionino nella direzione di un welfare integrativo e per un'agevolazione fiscale, ovviamente secondo parametri di performance da definire, per gli operatori del settore.
Infine, credo che per crescere ci sia bisogno di allargare la domanda di mercato e che questo si possa fare solo grazie a delle politiche pubbliche mirate. Bisogna creare una visione di trasformazione culturale condivisa, sviluppando sia l'impegno del pubblico nelle pratiche culturali partecipative e contemporanee sia la possibilità di nuove forme di iniziativa privata.
© Riproduzione riservata