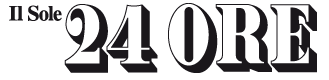
22 luglio 2011
Keith Jarrett a Milano ha suonato la sua autobiografia istantanea, ecco come
di Franco Fayenz
Il superdivo Keith Jarrett è tornato a Milano, questa volta al Teatro degli Arcimboldi con il suo celebre Standards Jazz Trio (Jarrett pianoforte, Gary Peacock contrabbasso, Jack Dejohnette batteria). Tre giorni prima i tre maestri avevano suonato al Teatro San Carlo di Napoli, e chi ha ascoltato entrambi i concerti assicura che nulla è stato ripetuto, salvo la camicia rossa e i discutibili calzoni neri del pianista.
Non ci sono dubbi. Jarrett, Peacock e Dejohnette lavorano insieme da 28 anni, pur avendo nello stesso tempo appuntamenti musicali diversi. Significa che suonano in simbiosi, e che a loro basta un sussurro, uno sguardo, e talvolta soltanto l'istinto o le vie misteriose dell'inconscio, per intendersi sulla strada da percorrere o da cambiare. Il pianoforte, il contrabbasso e la batteria sono fonti d'emissione di suoni stupendi e di uguale peso specifico, quello che oggi chiamiamo interplay. Oggi, in ciò che resta della grande musica per piccolo complesso che ancora, per intenderci, chiamiamo jazz, non si può fare niente di meglio. E' vero che tempo fa c'erano stati nel trio vaghi sentori di routine, ma sappiamo che si dovevano attribuire ad alcuni problemi di salute di Peacok e ai guai sentimentali di Jarrett, adesso metabolizzati con qualche residuo percepibile nei brani che propone.
Scelgono, i tre – ma soprattutto Jarrett e Peacock – dall'immenso patrimonio di temi sempreverdi, perlopiù americani, da cui il nome e lo scopo del trio riunito nel 1983. La struttura di ciascuna interpretazione creativa è piuttosto semplice: esposizione del tema, variazioni improvvisate, riesposizione tematica conclusiva non priva di nuove variazioni finali talvolta lasciate volutamente sospese. E' nella parte centrale che non di rado emerge l'emozione del capolavoro: qui l'improvvisazione è assoluta, supera i ricordi e le influenze ambientali; e chiunque può capire che, seppure in ipotesi uno stesso tema fosse ripreso, un'improvvisazione siffatta coincide con i sentimenti dei musicisti e con un qui e ora che mai più, e in nessun altro luogo, potrà essere ripetuto nello stesso modo. E' un'autobiografia istantanea, una dazione di sé che supera perfino la bellezza dei mezzi con cui si esprime: il tocco e il fraseggio aereo del pianoforte, la fantasia del contrabbasso, il vigore contenuto della batteria.
Si comincia con All Of You che Jarrett nobilita con una lunga prolusione pianistica. Ecco poi Summertime a tutti noto, Stars Fell On Alabama, G Blues e nella seconda parte (Jarrett ama l'intervallo) Answer Me My Love, All the Things You Are, Tennessee Waltz. Una diecina di brani in tutto, quelli citati sono i migliori. Ci sono anche due bis, l'ellingtoniano Things Ain't What They Used To Be e Once Upon A Time.
Questi ultimi, per quanto possa sembrare incredibile ai non iniziati, sono un premio per il pubblico (folto, ma con qualche vuoto qua e là): il pubblico, dicevo, che ha fatto il bravo e si è comportato secondo un decalogo di istruzioni per l'uso del concerto di Jarrett contenuto in un foglietto consegnato ad ogni spettatore e ripetuto da una voce femminile, per sua fortuna tra le quinte. Cari amatori della buona musica, Jarrett è così e non da oggi, ma così va accettato per quello che malgrado ciò sa donare, in solo o con gli altri due campioni. E' evidente che in questo modo intimidisce l'uditorio che per quasi mezzora non si arrischia nemmeno ad applaudire a scena aperta come si usa nel jazz. Qualche anno fa, nel Teatro La Fenice di Venezia riaperto da poco dopo l'incendio, durante un concerto solitario Jarrett fu costretto a fermarsi e a dire al pubblico: «Applaudite o fischiate, fate qualcosa, perché non capisco se sto suonando bene o male». Alla fine, ovviamente, arrivano anche agli Arcimboldi boati di applausi e la standing ovation.
C'è una novità, almeno per noi italiani. Jarrett ha deciso di porre il pianoforte in posizione tale da voltare le terga alla platea. La giustificazione ufficiale è che in questo modo non vede nessuno, nemmeno con la coda dell'occhio, e l'ispirazione resta integra. Sarà, ma non è carino. Tanto più che il nostro suona alzandosi più che mai in piedi, limita a se stesso l'uso dei pedali e fa vedere in questo modo una gestualità che richiama alla mente più un pipistrello che un virtuoso della tastiera.
Ma, ripeto, accettiamolo così, basta che non esageri come fece in modo imperdonabile (non ha mai chiesto scusa) a Perugia nel 2007. Ve lo dice un ascoltatore di lungo corso che lo apprezzò per la prima volta dal vivo a Bologna nel 1969 (Jarrett aveva 24 anni) e fu un trionfo. Era un'altra persona, allora. Timido (lo è anche adesso), affabile, gentile. Si poteva stare a tavola con lui davanti a un piatto di spaghetti, e sentirsi dire all'improvviso: «Sai, ho paura. Ho paura di quando sarò celebre, se mai lo sarò, perché potrei perdere il senso delle proporzioni». Lo perse per la prima volta qualche anno dopo in un teatro di New York. Il sottoscritto fu testimone oculare e auricolare.
22 luglio 2011
| P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati |