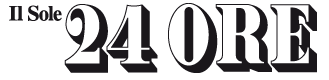
21 novembre 2013
Neolingua della politica italiana
di Guido Vitiello
Il linguaggio pubblico si è fatto più sudicio delle stalle di Augia, e non c'è Ercole che possa sobbarcarsi in un giorno la fatica delle pulizie, tanto l'aria è appestata da parole vane, sciocche, inutilmente astruse o anche soltanto brutte.
Un fiume purificatore dovrebbe spazzar via le mille locuzioni stereotipate (la schiena dritta, il ditino alzato), le parole svuotate da un uso inflazionistico (golpe, fascismo, comunismo), gli accoppiamenti pregiudiziosi (liberismo selvaggio, garantismo peloso), la partenogenesi dei neologismi (malpancista, doppiopesista). Ma queste non sono che mosche, per restare al mitologico letamaio. Perché a intasare le stalle nazionali sono parole ben più ingombranti, che ostruiscono il linguaggio ma soprattutto il pensiero, e che generano senza tregua malintesi, equivoci, ambiguità. Alcuni se ne servono con malizia, altri soggiacciono al loro incanto senza colpa. La confusione delle lingue, intanto, non fa che crescere.
Nel 1799, a Venezia, il gesuita Ignazio Lorenzo Thjulen pubblicò il Nuovo vocabolario filosofico-democratico, un pamphlet antigiacobino nel quale sosteneva che la Rivoluzione era stata più perniciosa del castigo di Babele, avendo confuso non solo le lingue ma anche le idee. La parte più consistente del dizionario si intitolava appunto «Vocaboli che hanno mutato senso, significazione ed idea», ed era un primo esperimento di Newspeak orwelliano, dove ogni termine finiva per designare il suo contrario: «Molti popoli, ingannati da falsi vocaboli e mal intesi, hanno corso dietro a tutto ciò che in realtà detestavano».
Qui non c'è stata nessuna rivoluzione, ma un po' di ordinaria pulizia non guasta.
Antipolitica. Quando questo ceto politico finirà sepolto sotto il peso della sua dabbenaggine, una parola dovrà essere scolpita a lettere d'oro sulla sua lapide, accanto alle date di nascita e di morte: antipolitica. E non perché a travolgerlo saranno le mille cose affastellate sotto questa insegna, ma precisamente perché, si dirà, non seppe trovare di meglio per etichettare il nemico e le sue armate imbelli. Antipolitica, è appena il caso di dirlo, è parola abissalmente stupida. Così stupida che perfino un avvistatore di scie chimiche, un ossessionato dal Bilderberg, un esperto di nanoparticelle annidate nelle merendine può svelarne il trucco e convincersi, con qualche ragione, di essere più illuminato del nemico. Più che una parola, antipolitica è un'attrezzatura masochistica che aziona due autolesionismi convergenti: per un verso dà l'immagine strategicamente suicida di un sistema assediato che si arrocca dietro torri merlate; per altro offre il più ingenuo degli assist, una comoda «alzata» per lo schiacciatore più schiappa. Che dirà: «Noi non siamo l'antipolitica, siamo contro questa politica. Siamo per un'altra politica». Vedete? Alla portata dello scemo del villaggio. E basta frugare un po' in rete per constatare che l'obiezione l'hanno fatta propria, appunto, villaggi interi di scemi del villaggio. Galvanizzati dall'occasione di ottenere, se non il warholiano quarto d'ora, un quarto di minuto d'intelligenza.
Bene comune. Non che la formula non abbia un senso, fin dai tempi di Tommaso d'Aquino. Il problema, semmai, è che ne ha troppi, che scivolano promiscuamente l'uno nell'altro. Ermanno Vitale, nel pamphlet Contro i beni comuni (Laterza), ha provato a mettere un po' d'ordine nel caos, ed è fatica erculea anche questa. Ribolle di tutto, in questo calderone ideologico e verbale: i vagheggiamenti di un inesistente Medioevo precapitalistico dove tutti si spartivano in armonia le ricchezze della Terra, i filosofemi fanta-marxisti di Toni Negri, i miraggi di qualche contrada esotica (la Bolivia di Evo Morales, il Chiapas del subcomandante Marcos), la sopravvalutazione allucinatoria di microsperimentazioni locali elevate a esempio generale, come il Teatro Valle occupato a Roma. Tutti i nodi vengono al pettine in un manifesto, Beni comuni del giurista Ugo Mattei, che Vitale smonta pezzo per pezzo, e da cui pesca brani immaginifici come questo, in puro stile Casaleggio Associati: «Si va imponendo sempre più una visione che vede Gaia come una comunità di comunità ecologiche, legate fra loro in una grande rete, un network di relazioni simbiotiche e mutualistiche, in cui ciascun individuo (umano o meno che sia) non può che esistere nel quadro di rapporti e relazioni diffusi, secondo modelli di reciprocità complessa». Umano o meno? Di sicuro c'è qualcosa di umano, troppo umano in certi usi del bene comune nel dibattito italiano.
Si può dire che è una delle varianti indigene di quella che Jean-François Revel chiamava la grande parade: la chiassosa e variopinta sfilata, ma anche parata in senso calcistico, che ha consentito a molti ex comunisti di aggirare con noncuranza il piccolo ostacolo del 1989. Rifoggiandosi, all'occasione, un'identità da benecomunisti. Ma il primo problema è che non si sa quali e quanti siano i beni comuni (l'acqua? la cultura? internet?) e a chi siano comuni (alle città? alle nazioni? all'umanità intera?). Leggiamo lo Statuto della Fondazione Teatro Valle: «Il bene comune non è dato, si manifesta attraverso l'agire condiviso, è il frutto di relazioni sociali tra pari». Che vuol dire, per esempio, nel caso dell'acqua? Che uno porta l'idrogeno e l'altro l'ossigeno? Ma al di là dell'autointossicazione gergale, la questione, in fin dei conti, è capire chi ha titolo per decidere cosa è bene comune e cosa non lo è. E quando si tratta di sottrarre un bene al comune (in senso amministrativo) e proclamarlo bene comune, la vaghezza della formula è d'aiuto. Potremmo quindi uscirne così: bene comune è ciò che i depositari del marchio Bene Comune™ designano come tale. E se non lo è, lo occupano.
Casta. Il termine più abusato degli ultimi anni nasce da un paradosso. Il libro di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo del 2007 aveva infatti per sottotitolo Così i politici italiani sono diventati intoccabili. E non occorreva certo avere studiato con Louis Dumont, conoscere il sanscrito o il tamil, possedere nozioni avanzate di indologia per sapere che gli intoccabili, i paria, sono per l'appunto i fuori casta, i reietti, il grado infimo della tradizionale gerarchia sociale indiana. La «casta degli intoccabili» è un po' come l'«aristocrazia dei pezzenti». Bisticci concettuali a parte, aver risciacquato i panni nel Gange anziché in Arno ha avuto le sue conseguenze. La più vistosa è che la parola arcaica ne ha eclissate altre, meno accattivanti ma più precise. Come corporazione. E già, perché in Italia ci siamo liberati dei fasci (forse) ma non delle corporazioni: e la parola casta era abbastanza vicina da farci sfiorare quella presa di coscienza, ma abbastanza lontana da precluderla. Così, sotto quella voce indianeggiante abbiamo ammucchiato tutti i babau del risentimento nazionale: le lobby e le logge, le cricche e le parrocchie, i palazzi e i salotti, i quartierini e le conventicole. E una primizia di rivoluzione liberale è finita in jacquerie plebea.
Fatto. «Niente di più misterioso di un fatto, nulla che rassomigli di più a quei sogni reali che empivano di spavento i gran sacerdoti di Babilonia». Ogni aspirante giornalista dovrebbe mandare a memoria il monito di Paul Valéry. Da qualche tempo, tuttavia, questa parola dall'aria innocua è diventata strumento di mille raggiri ideologici, ricatti morali, illusioni ottiche spacciate per fotografie: e così si chiamano fatti i rottami – in sé muti e indecifrabili – di storie vaste e complicate, e una volta raccolti questi rottami li si venera come feticci o li si punta come selci scheggiate al petto dell'interlocutore, per metterlo a tacere: «È un fatto!». E invece è spesso un brandello di vita essiccata, tagliato secondo le convenienze, o un'opinione corazzata in un esoscheletro di dati che nasconde così la sua natura. La mente umana subisce il fascino dell'alta definizione: riconosciamo a colpo d'occhio il qualunquista in chi urla un generico «Sono tutti ladri!», ma siamo ancora soggiogati da chi riporta la cifra, foss'anche inventata o gonfiata, dei parlamentari con procedimenti a carico. C'è in questo qualcosa di molto primitivo: ci agitano davanti un monile adorno di numeri e di verbali e di virgolettati, e restiamo impietriti. Come davanti al leggendario basilisco. L'unico modo per ucciderlo era metterlo allo specchio.
Legalità. Qualche anno fa Feltrinelli pubblicò un libro illustrato per l'infanzia, Le regole raccontate ai bambini, firmato da Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani pulite, e da Marina Morpurgo. Tra le illustrazioni di Ilaria Faccioli ce n'erano un paio che vale la pena descrivere: nella prima, dallo spiccato gusto maoista, un gruppo di bambini in festa mostra cartelli con scritto «Viva la legalità! Vogliamo legalità!»; nella seconda, un signore cattivo (guarda caso bruno, semicalvo e dal sorriso smagliante) è circondato da tv, radio e giornali che intonano all'unisono: «Vota lui!». Tanto basta per capire che legalità non è più una parola neutra e innocente, e si presta agli usi ideologici più vari. Specie quando circola in aggregati come «cultura della legalità» (formula vaga su cui prospera tutta un'antimafia khomeinista) o «controllo di legalità», l'idea che i magistrati siano non già applicatori della legge ma guardiani del gregge, preposti a vegliare perpetuamente sulla Nazione. Capita così che un Gian Carlo Caselli chiami «assalti alla legalità» quelli che sono, tutt'al più, assalti a Gian Carlo Caselli. Occorre quindi affinare l'udito quando si sente inneggiare alla legalità: sembrano inviti al rispetto della legge, e spesso sono appelli al tifo incondizionato per la magistratura inquirente. Le due cose, direbbe il santo Milarepa, «paiono uguali, ma sta attento a non confondere».
Moralismo. Chi abbia in testa i moralisti classici come La Rochefoucauld e La Bruyère, legherà questa parola a dei gentiluomini misantropi e coltissimi, per lo più slegati dalle cure e dalle contingenze terrene, che dal loro esilio volontario meditano sull'infinita monotonia del cuore umano. Ora, pensiamo a come il nostro bipolarismo patologico ha maltrattato la parola moralismo fino a renderla inservibile. Gli uni (sono quelli che deridono il «ditino alzato») la mettono in ridicolo, dando di moralista a chiunque abbia a eccepire su cose che spesso con la morale c'entrano poco; gli altri (sono quelli che vantano la «schiena dritta») la agitano come una clava contro il nemico politico e antropologico. L'effetto, si è visto, è stato quello di ottenere non già la moralizzazione della politica, ma la politicizzazione della morale. E ci vorrebbe un La Bruyère per compatire la triste, meccanica, nauseante ripetitività di queste pose gemelle.
Narrazione. La mamma chiede al bimbo accucciato sul vasino: «Stai facendo la cacca?». «No: la narrazione del mio defecare». Con la vignetta di Altan si potrebbe chiudere la partita, e farla finita con quest'altro assillo ventennale. Che si è esteso anche alle più inenarrabili regioni dello scibile umano. Tutto diventa affabulazione e storytelling, tutto è presentato sotto forma di racconto. A quanto pare, abbiamo dovuto scontare il crollo dei grands récits novecenteschi con la disseminazione imperialistica della forma-narrazione. E non è certo il solo Nichi Vendola a farsene megafono, e neppure l'allegra combriccola dei Wu Ming, divulgatori di una sorta di versione adolescenziale a fumetti del «mito politico» di Georges Sorel. Ormai senti parlare indifferentemente, e come se davvero significasse qualcosa, di narrazione del territorio, di narrazione del capitalismo, di narrazione del Pd, di narrazione del femminile. È il pendant del feticismo del fatto. Se quello rendeva tutto fossile, qui ogni cosa si fa fluida. Per capovolgere il motto del Parsifal, lo spazio qui diventa tempo, ed è tutto uno scorrere di storie, come fiumi in cerca di uno sbocco. Dove sfoceranno? Ecco, ci sono anche libri dedicati alla «narrazione del cibo». C'è da supporre che, superata la narrazione della digestione, il tutto finisca più o meno come nella vignetta di Altan.
Pancia. Parlare con la pancia è affare da ventriloqui, ascoltare la pancia è invece uno dei segnali del beato rincoglionimento dei futuri papà («Lo senti? Scalcia!»). Pare però che certi politici sappiano parlare alla pancia del paese, e che questo sia un vantaggio ma anche, tutto sommato, una cosa piuttosto ignobile. Ora, tutto sta a svelare i sottintesi e le implicazioni dell'antropomorfismo. A occhio e croce, la pancia del paese dovrebbe trovarsi all'altezza del basso Lazio, ma si direbbe che non è questo che intendono. «B. è la pancia del paese che parla» (Beppe Severgnini); «Grillo (…) fa leva sulla pancia del paese» (Andrea Scanzi); «La pancia del paese guarda alla tasca» (questa, più barocca, è di Bruno Vespa). Ricreiamo, a partire da queste indicazioni, un modellino anatomico: c'è una testa del paese (le élite colte che votano secondo valori e princìpi), c'è un cuore fatto di militanti appassionati (che palpitano per quei medesimi valori e princìpi), e infine c'è la pancia. Luogo di umori guasti e di riflussi, di spiriti animali e di rancori atavici, di meschinità e di calcolo, di avidità e di pericolosi rigurgiti. Ne consegue che le elezioni non sono lo scontro tra diversi modi di usare la testa, ma tra una testa e una pancia; e, in subordine, che gli interessi sono una cosa turpe e non già la materia prima di una democrazia liberale. Due conclusioni indegne di una testa pensante, frutto di cattiva digestione.
Territorio. «Buongiorno, siamo una piccola realtà operante sul territorio». Ah sì? E chi non lo è? A rigore, anche il mio aspirapolvere, il mio alluce e il mio criceto (se ne avessi uno) ricadono nella categoria «piccole realtà operanti sul territorio». Tutto ciò che soggiace alla legge di gravitazione è una realtà operante sul territorio. Che cos'è, dunque, il territorio, negli usi non tautologici? Lo si può considerare l'equivalente verbale di una zavorra, una parola che serve cioè a fornire l'illusione di un ancoraggio per le iniziative più aleatorie e volatili. Territorio è un bell'esemplare di quelli che potremmo chiamare i lemmi del «falso radicamento», come rete (e popolo della), movimenti, piazze, moltitudini, generazioni. Sono enti di fantasia che servono a stabilire un legame di tipo magico con la realtà. Meno generici e qualunquisti di «gente», hanno però una funzione simile: danno a chi li pronuncia (e auspicabilmente anche a chi li ascolta) l'impressione di avere alle spalle qualcosa di più che sé stessi o i propri quattro gatti. Si disse che Stefano Rodotà era il presidente della Repubblica voluto dalla rete e dai movimenti. Poi venne fuori che poteva contare sui quattromila gatti delle Quirinarie. Lui, un po' vanesio, replicò che un sito a suo sostegno aveva ottenuto un milione di clic. Ma una zavorra non bisogna cercarla, bisogna al contrario liberarsene; tanto più che comincia per zeta e in qualche modo dobbiamo metter fine al glossario.
21 novembre 2013
| P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati |