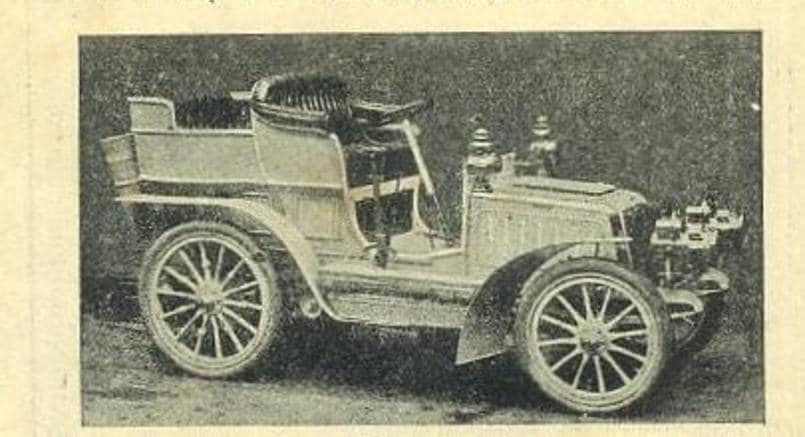
Al decollo industriale dell'Italia nel primo decennio del Novecento contribuirono vari fattori di ordine esterno e interno. Da un lato, un'alta congiuntura internazionale, sospinta dall'aumento dei prezzi, dalla scoperta di nuove risorse minerarie e da un più largo impiego del petrolio, dall'introduzione di nuove tecnologie e dal lancio di nuovi beni di consumo durevoli; dall'altro, il risanamento delle finanze pubbliche, l'utilizzo dell'elettricità, una maggiore produttività dell'agricoltura, la crescente urbanizzazione, l'allargamento del mercato interno e l'azione di nuove banche “miste” di deposito e di investimento, sorte con l'apporto anche di capitali tedeschi.
In questo contesto economico più robusto e dinamico, segnato in età giolittiana da un efficace impulso dello Stato, all'insegna di una prospettiva liberal-progressista, la classe imprenditoriale ebbe modo di svolgere un ruolo sempre più rilevante nell'incipiente modernizzazione del sistema-paese. A tal fine risultarono determinanti due circostanze: l'espansione dell'industria sulle direttrici di marcia strategiche della siderurgia, dell'elettrificazione, della chimica e del settore meccanico-automobilistico e quindi, a rendere possibile questa performance, furono le singolari attitudini che portarono alcuni imprenditori a cogliere le nuove opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica e dai mutamenti in corso nel mercato per creare alcuni complessi industriali orientati verso l'attività di progettazione e la razionalizzazione dell'assetto organizzativo e dei procedimenti operativi.
Se un certo spirito pionieristico e la capacità di lavorare duro costituivano il comune denominatore sia di chi si era fatto le ossa nella seconda metà dell'Ottocento sia di quanti stavano cimentandosi all'inizio del nuovo secolo, tuttavia quel che segnò uno stacco netto rispetto al passato fu una cultura d'impresa che si ispirava ai principi fondamentali dello sviluppo capitalistico: l'etica del profitto, un gusto pratico per le innovazioni, la convinzione che la fabbrica fosse il perno e la sede strategica dell'accumulazione economica e delle trasformazioni sociali. C'era in questo atteggiamento, la stessa fiducia nelle potenzialità della tecnologia che informava gli ambienti del mondo scientifico. Ma c'era anche qualcosa di peculiare che traeva origine sia dalle esperienze che alcuni imprenditori avevano compiuto all'estero, durante il loro apprendistato, sia da una reazione istintiva di insofferenza nei confronti di un establishment avvezzo per troppo tempo a vivere di rendita o ripiegato su se stesso.
Del resto, gente come Giovanni Agnelli, Camillo Olivetti, Giovanbattista Pirelli, Guido Donegani, Cesare Pesenti, Ettore Conti, gli Orlando, i Perrone, i Marzotto (per citare solo alcuni) aveva quale proprio modello di riferimento gli Stati Uniti, l'Inghilterra o la Germania. Tanto da far dire a Luigi Einaudi che stavano perciò formandosi «più fresche e solide energie», tali da far ben sperare per l'avvenir e del Paese. Tuttavia, se gli imprenditori erano altrettanto consapevoli delle loro prerogative che sicuri di sopravanzare gli esponenti della grande proprietà fondiaria e della vecchia aristocrazia finanziaria avevano continuato ad agire per lo più in ordine sparso. Occorreva perciò dar vita a un sodalizio a carattere nazionale, che rappresentasse le diverse componenti dell'universo imprenditoriale nei rapporti con le autorità di governo e con le organizzazioni dei lavoratori. Fu così la Lega industriale di Torino, fondata nel luglio 1906, a promuovere, di concerto con altre associazioni territoriali e di categoria lombarde e liguri, l'istituzione (il 5 maggio del 1910) nella capitale subalpina della Confederazione italiana dell'industria che annoverava 1.200 aziende, per un totale di 160mila dipendenti. Presto altre imprese , attive in tutti i settori industriali (salvo, per il momento, quelle del comparto idroelettrico) avrebbero ampliato la rappresentatività e il raggio d'azione della Confindustria.
© Riproduzione riservata