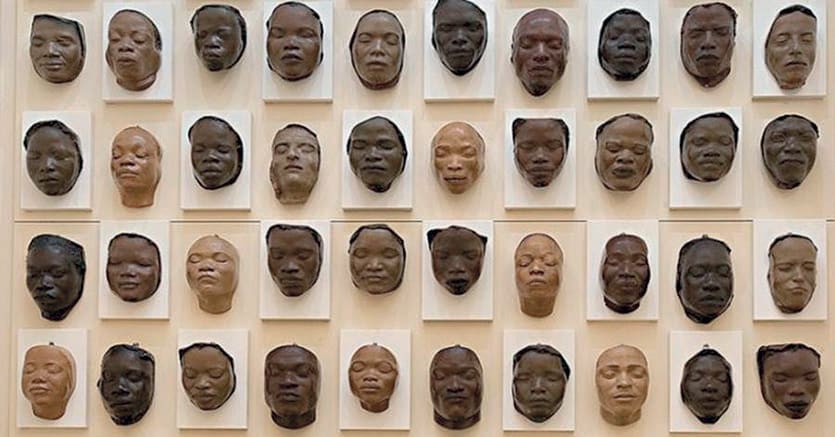
Pubblichiamo un intervento uscito sul Sole 24 Ore del 21 aprile 2005, a firma di Luigi Luca Cavalli Sforza, il grande genetista genovese scomparso a 96 anni.
Alcune settimane fa sul New York Times è comparso un articolo di Armand Marie Leroi che riporta a galla il problema delle
razze. L'autore si definisce un «evoluzionista biologo dello sviluppo» dell'Imperial College di Londra, cioè appartiene a
una nuova setta che sembra un sottogruppo di un'altra più nota, detta di “psicologi evoluzionisti” che ha raccolto l'eredità
della sociobiologia. Era questa una disciplina sorta come un fungo nel 1975, con il libro omonimo di Edward O.Wilson, un notissimo
ecologo e studioso degli insetti sociali (soprattutto api e formiche) che aveva trasferito un po' troppo violentemente alla
specie umana le sue conoscenze entomologiche sulla socialità. Che vi siano geni che possono influenzare il comportamento sociale
anche negli uomini non c'è dubbio, ma che la società umana abbia molte somiglianze con quella delle formiche è un po' ingenuo.
La sociobiologia ha ignorato il potere dell'evoluzione culturale, e dopo un breve successo ha perso rapidamente in popolarità,
continuando in modo meno violento sotto altri nomi.
L’origine del concetto di razza
Il concetto di razza ha due origini diverse. La prima: a partire dal '700, zoologi e botanici si sono occupati di classificare
tutte le specie di animali e piante, che oggi sono molti milioni. Una specie, così come quella umana, è l'insieme di individui
che possono proliferare fra loro senza limitazioni, che invece rendono impossibili, o limitano grandemente gli incroci fra
individui di specie diverse.
Continua a pag. 64
Quasi tutti sanno che gli ibridi fra due specie diverse come cavalli e asini sono sterili, quindi non possono continuare la
vita. Ma una specie, anche se chiaramente fatta di individui tutti interfecondi è tutt'altro che omogenea, e soprattutto studiandone
gruppi che vivono in luoghi lontani, si trovano differenze locali anche importanti. Sappiamo tutti riconoscere a occhio un
africano da un cinese. Quindi, si dice, le razze esistono.
Discontinuità rare e sottili
In realtà in molti non saprebbero distinguere un africano da un indiano del sud o da un abitante della Nuova Guinea, cioè
da molti altri che abitano vicino all'equatore. E in realtà già Darwin, quasi un secolo e mezzo fa, metteva in guardia sulle
razze: notando che vi è quasi sempre una sorta di continuità geografica della variazione fra i gruppi umani. Se andiamo da
un'estremità all'altra del mondo in qualunque direzione, si passa piuttosto gradualmente da un tipo ereditario a un altro
assai diverso. Le discontinuità sono rare e sottili, rendendo problematica la classificazione in razze. E infatti, aggiunge
Darwin, gli scienziati non riescono a mettersi d'accordo su quante razze esistono, e le proposte variano da 2 a più di 60.
E allora, esistono o no le razze? La situazione non è cambiata oggi; e se non sappiamo neppure quante sono, che diritto abbiamo di dire che esistono? Penso sia essenziale aggiungere: e se vogliamo a tutti i costi accettarne la validità anche nell'uomo, a che cosa servono?
Èquesta veramente la domanda più importante.
“La variazione genetica che si ritrova in “razze” diverse è molto piccola, mentre quella che si trova fra gli individui in ogni popolazione è molto più importante”
L’uso della parola razza per gli allevamenti
Veniamo così alla seconda origine e all'uso pratico della parola razza, quella degli allevatori. Non per nulla, la parola
razza sembra venire dal francese antico haraz (oggi haras), ove significa allevamento di stalloni, e forse prima ancora dall'arabo.
Quasi tutti gli allevatori e coltivatori sono interessati a creare razze diverse per usi diversi, e a migliorarne le prestazioni,
ma vogliono che ogni razza sia omogenea. Nel caso di cavalli, cani, gatti, topini e via dicendo, il campione della razza deve
avere certe caratteristiche e tutti gli altri futuri membri devono assomigliargli il più possibile. Ma la natura rifiuta di
creare eccessiva omogeneità, soprattutto tra i Mammiferi, e in genere i Vertebrati. La riproduzione vegetativa o clonazione,
che evita il sesso e con esso il rimescolamento radicale dei caratteri presenti nei due genitori, è facile in molte piante
ma non funziona tra gli animali più complessi, se non raramente (i gemelli identici ne sono un esempio nell'uomo) e anche
sperimentalmente non in modo facile: vedi il successo-fiasco della pecora Dolly. Senza clonazione gli allevatori riescono
a creare solo una omogeneità relativa dopo molti incroci fra parenti stretti, e solo per pochi caratteri esterni, o per attività
speciali, che sono più facili da controllare geneticamente.
La gran maggioranza dei caratteri ereditari che non si vedono, come molti gruppi sanguigni, restano tenacemente variabili
anche dopo dieci o venti generazioni di incroci fra fratello e sorella o genitori-figli, eseguiti dagli allevatori per ottenere
l'omogeneità desiderata. E comunque non si può fare allevamento nella specie umana, se non limitatamente a quei pochi tentativi
fatti da imperatori, duchi o tiranni che ci hanno provato per sfizio, e sempre su scala molto modesta.
Variazioni genetiche
Leroi asserisce che la dominanza del concetto di razza come costrutto sociale e non realtà biologica, è stata generata da
un articolo del 1972 di Richard Lewontin, ora a Harvard, responsabile di importanti scoperte di genetica di popolazioni nel
famoso moscerino della frutta. Ma non è vero, perché il concetto è stato affermato in modo perentorio in diverse dichiarazioni
ufficiali dell'Unesco negli anni immediatamente successivi alla guerra. Lewontin ha analizzato statisticamente dati genetici
raccolti su popolazioni umane, come gruppi sanguigni ed enzimi del sangue, e ha dimostrato che la variazione genetica che
si ritrova in “razze” diverse è molto piccola, ed è al più il 15% di tutta la variazione esistente nell'uomo, mentre quella
che si trova fra gli individui in ogni popolazione, cioè il residuo 85%, è molto più importante. Cioè, le razze non sono affatto
omogenee; al contrario, nascondono un'enorme variazione fra individui sotto un'apparente omogeneità. Perché, si è chiesto,
fare tanto chiasso sulle differenze fra le razze? In realtà è stato anche mostrato più tardi che quasi nessun altro mammifero
mostra una variazione tra “razze”, comunque definite, tanto piccola quanto quella osservata nell'uomo, e la nostra storia
evolutiva spiega bene il perché. E anch'essa, comunque si definiscano le razze, è scesa in un'ultima analisi con dati e metodi
più recenti e precisi, al 3-5 per cento.
“Quasi nessun altro mammifero mostra una variazione tra “razze” tanto piccola quanto quella osservata nell'uomo”
Luigi Cavalli Sforza
L’apprendimento
Perché allora insistere tanto sull'esistenza delle razze? Gli evoluzionisti psicologi sono loro stessi una razza (non biologica,
ma culturale, si intende!) che amano cercare geni responsabili di comportamenti psicologici: sono genetisti forse un po' fanatici.
Non ci sarebbe molto da temere, se non che purtroppo questa ricerca è assai complicata ed è facile pigliare cantonate. Il
comportamento umano è in gran parte imparato, e abbiamo pochi modi sicuri e faticosi per distinguere nell'uomo quello che
è appreso da quello che è innato (nel senso che è trasmesso dai geni), data l'impossibilità di condurre incroci sperimentali.
Questi sono possibili solo negli animali. Ma nessun animale ha, al pari di noi, la potenza di trasmissione culturale e quindi
di apprendimento resa possibile dal linguaggio. La conoscenza del genoma potrà aiutare in futuro in questa ricerca, e vi sono
certamente caratteri psicologici ereditari, ma a cominciare dal famoso quoziente di intelligenza, il QI, il loro determinismo
è praticamente senza eccezione estremamente complesso. Per il QI, il carattere psicologico più studiato ma purtroppo scientificamente
il meno interessante, la stima dell'importanza dei geni varia dal 30% all'80%, secondo il ricercatore che ascoltiamo. Le analisi
più sicure sono quelle che danno i valori più bassi.
La bellezza
Leroi propone anche di occuparsi della genetica della bellezza, (senza incroci sperimentali, per fortuna). Viene quasi il
dubbio: che ci sia magari un po' di quell'ansia dell'allevatore, di creare la razza perfetta? C'è forse anche un po' di quelle
spinte psicologiche interne, comunque le si voglia chiamare, per cui quasi ciascuno ha almeno una squadra sportiva del cuore
che è diventata una parte di se stesso? Sotto queste spinte, l'io diventa noi, e ci rende partecipi della gioia della vittoria
di quei campioni che abbiamo scelto a rappresentare il nostro io: non solo la nostra squadra di calcio, anche la nostra città,
la nostra nazione, la nostra gente, la nostra razza, che naturalmente sono sempre migliori di tutte le altre. Una psicologia
semplice suggerisce che questa è una delle strade che conducono più o meno inconsciamente al razzismo. Signori psicologi evoluzionisti
e affini, forse dovreste diventare genetisti un po' meno ardenti e prestare più attenzione alla psicologia spicciola.
“Le “razze” che veramente contano per la medicina sono delle “popolazioni” cento, mille volte più piccole di quelle che vengono chiamate razze nel discorso comune”
La medicina
Leroi afferma, inoltre, che la razza è importante per la medicina. C'è una vaga verità in questa affermazione, ma io devo
considerare un errore il modo in cui l'ha espressa, perché non si è rivolto alle “razze” giuste. Quelle importanti per la
medicina non sono certo le cinque proposte dal fondatore dell'antropologia fisica alla fine del Settecento, Johann Friedrich
Blumenbach, che tutti conoscono e che corrispondono più o meno ai cinque continenti. È vero che queste razze hanno qualche
realtà, anche se modesta, e per una ragione semplicissima. La massima causa di differenza genetica in una specie come quella
umana, abbiamo recentemente dimostrato, è la distanza geografica fra due popolazioni. La chiarezza della relazione tra differenze
genetiche e distanza geografica è veramente straordinaria. È ovvio che, malgrado le complicazioni dei contorni continentali,
le popolazioni di continenti diversi sono in media le più distanti fra loro di tutte le altre, per semplici ragioni di geometria
geografica. Perciò le popolazioni di continenti diversi mostrano le massime differenze genetiche, anche a occhio, che però
sono così grossolane da non poter venire direttamente utilizzate dal punto di vista medico.
La realtà è che le “razze” che veramente contano per la medicina sono delle “popolazioni” cento, mille volte più piccole di quelle che vengono di solito chiamate razze nel discorso comune. Sono formate da discendenti di individui vissuti trecento, mille, più di rado migliaia di anni fa, che portavano uno o alcuni rari cambiamenti genetici (mutazioni) responsabili di certe malattie precise. Ma non ha molto senso chiamarle razze, e per essere sufficientemente chiaro l'argomento richiede un discorso speciale, centrato sulla storia delle espansioni umane, sulla genealogia e sull'ecologia.
© Riproduzione riservata






