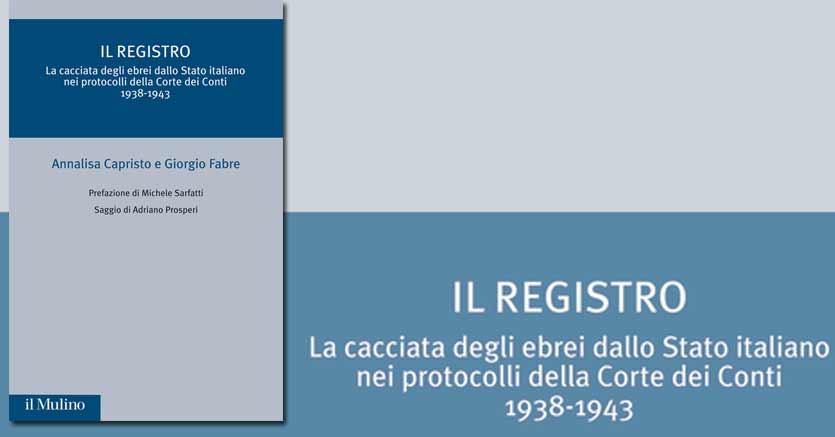
Che interesse potranno mai suscitare i protocolli dei «riposi civili» nei quali un tempo la Corte dei Conti registrava il pensionamento o il ritiro dal lavoro dei dipendenti dello Stato? Di norma, nessuno. Se però tali registri risalgono al periodo 1939-43, l’occhio cade su oltre settecento nomi brutalmente evidenziati in rosso. Sono i dipendenti ebrei espulsi. Questa scoperta, presso l’Archivio Centrale dello Stato, ha permesso ad Annalisa Capristo e Giorgio Fabre di ricostruire a ottant’anni di distanza un primo elenco completo degli statali epurati in quanto «appartenenti alla razza ebraica». Una cinquantina di loro finirà deportata e uccisa nei campi di sterminio.
Nel presente registro, certo, ci sono personaggi già noti, come Paolo Vita-Finzi, all’epoca console generale a Sydney e poi protagonista nel dopoguerra di una brillante carriera diplomatica; Tullio Ascarelli, ordinario di Diritto commerciale a Bologna e maestro di Bruno Visentini; Giuseppe Levi, cattedratico di Anatomia a Torino, che allevò ben tre futuri premi Nobel (Rita Levi-Montalcini, Renato Dulbecco e Salvador Luria). Ma dagli scartafacci ingialliti della Corte dei Conti emergono soprattutto le tante esistenze anonime, senza medaglie, di maestri elementari, professori di scuola media, ingegneri, chimici, operai della Zecca, postini, ragionieri, interpreti, pretori, uscieri: in genere illustri sconosciuti, per la prima volta riscattati da questa capillare ricerca.
Ad esempio, Adolfo Fellus, ex archivista coloniale, vincitore di concorso come ufficiale postale di prima classe e destinato il 16 maggio 1938 in Libia, alla vigilia della campagna antiebraica. Ugo Levi, l’unico impiegato del Consiglio di Stato «che non risulta di razza italiana». Oreste Bracci, operaio nelle Manifatture dei Tabacchi. Dante Almansi, Giacomo Cameo, Umberto Cividali, rispettivamente consigliere, archivista e revisore principale della Corte dei Conti.
E Guido Cammeo, commissario di polizia cacciato dal corpo e dal ministero dell’Interno il 5 settembre 1938 con un decreto firmato da Mussolini. Il quale doveva avere il dente particolarmente avvelenato nei suoi confronti, visto che il 26 settembre 1921 Cammeo era a capo del drappello di guardie regie e poliziotti che avevano aperto il fuoco contro un manipolo di fascisti all’assalto della Camera del Lavoro di Modena, uccidendone otto. Assolto due anni più tardi in tribunale, con grande scandalo delle camicie nere, Cammeo sarà epurato soltanto grazie alle leggi «razziali». La sua vicenda fu particolarmente penosa perché, vedovo con sette figli, non avendo raggiunto il massimo del servizio poté usufruire di una pensione molto modesta.
Gli effetti economici delle leggi antiebraiche non furono meno devastanti di quelli psicologici. Le espulsioni dal lavoro crearono infatti «un vero inferno di bisogno», che colpì soprattutto quanti non ricevettero neppure una pensione, bensì una semplice indennità, spesso risibile. Ma anche gli altri, soprattutto se prepensionati con un limitato numero di anni lavorativi, subirono un drammatico dissolvimento del proprio reddito. Come nota Michele Sarfatti nella prefazione, «la loro capacità di acquisto di cibo, medicine, legna e vestiti non era problema di Mussolini». In una situazione ancora peggiore si trovarono i dipendenti pubblici precari, licenziati senza alcuna tutela pensionistica o risarcimento, di cui ancora oggi non sappiamo pressoché nulla, se non che in molti casi precipitarono nella «pura indigenza».
Questo libro, osserva Adriano Prosperi nella postfazione, non documenta soltanto un indicibile dramma umano, ma anche una «grande tragedia normativa», ossia la «caduta senza rumore dello Stato italiano» nel crepuscolo del 1938. Una caduta nel silenzio delle sue vittime, ma pure dei suoi tanti, impersonali carnefici, impegnati ad annientarle a suon di carte bollate. Angelo Ventura, autore di alcuni pionieristici e magistrali studi sulla persecuzione antiebraica sotto il fascismo, invitava a ragionar su un paradosso: in un Paese da sempre avvezzo, anche sotto la scure del duce, a non osservare scrupolosamente le leggi, «poche leggi furono applicate con tanto zelo come quelle che perseguitavano gli ebrei». Ed è quanto appunto succede pure nel demi-monde burocratico svelato dai protocolli della Corte dei Conti. Da garante del diritto e della comunità nazionale, lo Stato assunse il ghigno feroce di un caporeparto che mette arbitrariamente alla porta i suoi sottoposti. Forse anche perché le leggi del ’38 non furono un fulmine a ciel sereno, bensì lo sviluppo logico di un antisemitismo littorio latente sin dagli anni Venti.
Non tutti gli ebrei epurati erano antifascisti. Alcuni di loro erano stati nazionalisti, interventisti e infine mussoliniani. Sicché Vittorio Emanuele III, firmando le leggi «razziali» e preoccupandosi soltanto di garantire un’esenzione al proprio medico israelita, sconfessò il Risorgimento, che aveva segnato la piena integrazione della minoranza ebraica nello Stato italiano.
Il registro. La cacciata degli ebrei dallo Stato Italiano nei protocolli della Corte dei Conti 1938-43, Annalisa Capristo e Giorgio Fabre, prefaz. di Michele Sarfatti, con un saggio di Adriano Prosperi, il Mulino, Bologna, pagg. 340, € 26
© Riproduzione riservata





