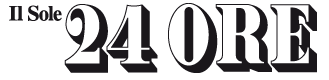
2 marzo 2011
E Mirafiori lasciò il Duce da solo sotto la pioggia
di Alessandro Barbero
Il 15 maggio 1939, davanti a un'immensa folla operaia, Mussolini inaugurava a Torino il nuovo stabilimento della Fiat Mirafiori. Era la seconda grande fabbrica che Giovanni Agnelli creava nel capoluogo piemontese, dopo l'avveniristico stabilimento del Lingotto, aperto nel 1922. In quell'occasione, a celebrare i fasti della Fiat e sancire la sua alleanza con lo Stato era venuto il re, ma stavolta fu deciso che a inaugurare Mirafiori sarebbe venuto il Duce in persona: quello che a Torino, quando non c'erano troppe orecchie in ascolto, chiamavano in dialetto Monssù Cerutti («Ch'a lu fica 'n cül a tüti», e forse non c'è bisogno di traduzione).
Non era ovvio che Mussolini quel giorno venisse a Torino, anzi non era ovvio per niente che nell'Italia fascista fosse sorta una fabbrica come Mirafiori, capace di impiegare su due turni 22mila operai. Una retorica oggi dominante pretende che nell'Italia degli anni Trenta il consenso al regime fosse pressoché universale; basta leggere le informative di polizia che ogni giorno arrivavano sul tavolo di Mussolini per sapere che non era così, e che fra le concentrazioni operaie delle grandi città del Nord l'ostilità al fascismo e l'adesione a ideali socialisti e comunisti erano largamente diffuse. Perciò il Duce non amava le grandi fabbriche, così vulnerabili, oltretutto, ai bombardamenti aerei, di cui già allora si prevedeva la spaventosa efficacia.
Mussolini avrebbe preferito che l'industria italiana decentrasse la produzione; ma Agnelli voleva Mirafiori e dopo una serrata trattativa strappò il consenso alla costruzione del nuovo, colossale stabilimento, in cambio dell'impegno a costruire diverse altre fabbriche fra Marche e Toscana.
Così quel 15 maggio 1939 Mussolini era a Torino, o meglio fuori Torino, perché l'area dove Mirafiori era venuta su dal nulla non era ancora urbanizzata, e si stendeva fra prati e gerbidi, non lontano dalla palazzina sabauda di Stupinigi.
In omaggio alla politica sociale del regime, c'era accanto alle officine un grandioso dopolavoro, con piscina, campi da pallavolo e cento campi da bocce; c'era la mensa aziendale da 11mila posti, anch'essa una novità imposta dal Duce, perché «l'operaio che mangia in fretta e furia vicino alla macchina non è di questo tempo fascista»; c'era la rimessa per le 10mila biciclette con cui si prevedeva che gli operai sarebbero venuti al lavoro, e c'era, inevitabile, il rifugio antiaereo per l'intera manodopera, giacché Mussolini sapeva bene che la guerra sarebbe venuta, ed era deciso a non restarne fuori.
Era insomma, come dichiarò lo stesso Duce, «la fabbrica perfetta del tempo fascista»; eppure Mussolini non era sicuro dell'accoglienza che avrebbe ricevuto. Era stato in visita ufficiale in Piemonte per la prima volta sedici anni prima, nel 1923, e prevedibilmente aveva esaltato tanto la tradizione militare piemontese (i «magnifici battaglioni») quanto «le mille ciminiere dei vostri stabilimenti», «questa vostra splendida città del lavoro» da cui si diceva frastornato e abbagliato.
Il silenzio con cui lo avevano accolto gli operai non l'aveva smontato più di tanto: «Se in dodici mesi sono riuscito a farmi ascoltare, l'anno prossimo mi applaudiranno», dichiarò andando via. Però in occasione della sua seconda visita, nel 1925, aveva sentito il bisogno di dichiarare: «Si dice che il Piemonte è freddo. Non è vero. Il Piemonte è serio. La differenza è sostanziale!», e, in tono ancor più rivelatore di una malcelata insicurezza, «Si è detto che il Piemonte non è fascista. Altro errore!». Dopodiché non si era più fatto vedere per ben sette anni: tornò soltanto in quelli che altrove in Italia erano davvero gli anni del consenso, nel '32, nel '34, e per la quinta volta appunto nel '39.
Tornava; ma i rapporti di polizia non erano incoraggianti. «Nella massa lavoratrice si riscontra sempre un ambiente decisamente avverso alle istituzioni del regime», scrivevano gli informatori nel dicembre 1937. La crisi economica e i provvedimenti per l'autarchia «hanno creato una ostilità latente per il regime, ostilità che pubblicamente non si manifesta per paura ma che può essere provata e sentita da tutti», si rincarava nel dicembre 1938. Le leggi razziali erano state accolte gelidamente, in particolare dagli ambienti cattolici, che a Torino e in Piemonte non erano - e non sono - così protagonisti della vita collettiva come avviene ad esempio a Milano e in Lombardia, ma avevano una loro discreta influenza: «Perdura l'incertezza o il malcontento di tutti», confessava la polizia, e precisava: «Negli ambienti cattolici si biasima apertamente la politica antiebraica».
Quanto all'ipotesi della guerra, e di una guerra contro la Francia e al fianco dei tedeschi, che in quella primavera del 1939 aleggiava già oscuramente nell'aria, il giudizio era ancora più netto: «Lo stato d'animo della popolazione torinese nel presente momento è chiaramente avvertito da chiunque: esso è nettamente contro ogni guerra e contro la Germania». «Udendo discorsi che qui si fanno ovunque, si ha la sensazione di trovarsi in una città che non è fascista», concludeva sgomenta la Questura torinese.
Perciò la visita del Duce fu preparata con misure eccezionali. Come si faceva sempre in questi casi, si provvide a mettere in guardina un certo numero di oppositori e sovversivi. Ma fu soprattutto la Fiat, che non voleva incidenti, a pianificare con cura la partecipazione delle masse. Tutti i dipendenti ricevettero l'ordine di presentarsi a Mirafiori la mattina del 15 maggio, con un cartellino che bisognava timbrare prima delle otto. Perciò, fin dalle prime ore del mattino decine di migliaia di persone si accalcavano davanti al palco costruito accanto all'officina principale, mentre gli operatori dell'Istituto Luce armeggiavano per riprendere le sequenze del documentario che avrebbe testimoniato l'abbraccio tra il Duce dell'Italia fascista e le masse dei lavoratori.
Mussolini non ebbe fortuna: quel mattino diluviava. Chi ebbe fortuna furono le autorità locali, cui non parve vero di poter attribuire alle ore di attesa sotto la pioggia l'esito catastrofico della giornata. Quando Mussolini arrivò a Mirafiori, fra le cinquantamila persone (tante, almeno, secondo la Questura) assiepate ad attenderlo gli applausi furono radi e svogliati. La direzione Fiat aveva dato istruzioni precise, di battere le mani al suo arrivo e ad ogni pausa del discorso, «invece nessuno ha fatto niente di tutto questo», ricorda, forse con un po' di ottimismo, un'operaia. Gli applausi e le grida di Duce! Duce! vennero soprattutto dalle prime file, dov'erano gli impiegati e i membri del partito in uniforme. E in camicia nera era anche il settantatreenne Giovanni Agnelli, ex ufficiale di cavalleria e senatore del Regno, che quarant'anni prima aveva fondato la Fiat e che ora saliva sul palco accanto al Duce.
«Camerati operai!» cominciò Mussolini, rivolgendosi ai cinquantamila zuppi di pioggia. Procedette poi, con qualche fatica, a spiegare quant'era importante che lui fosse lì, e che loro fossero venuti ad ascoltarlo, per disperdere le voci malevole secondo cui in Piemonte, e soprattutto fra gli operai, allignava la mala pianta dell'antifascismo. «Il Piemonte è fascista al cento per cento. E questo sia detto una volta per sempre, onde fare tramontare certe ridicole illusioni» dichiarò, da quel grande attore che era, benché non ci credesse nemmeno un po'. Esaltò, e non aveva neanche tutti i torti, le provvidenze che il Regime aveva introdotto per i lavoratori, e di cui le meraviglie del nuovo stabilimento erano la prova tangibile.
Poi, sconcertato perché gli applausi erano sempre pochi, sbagliò, come gli capitava di rado di sbagliare dal palco: si vede che trovarsi lì non lo ispirava. In un discorso di cinque anni prima, a Milano, dove era abituato a trovare folle ben più entusiaste, aveva promesso agli operai salari equi, case e lavoro, e addirittura una partecipazione alla gestione delle fabbriche, non si sa con quanta soddisfazione di Agnelli e degli altri industriali. Ma invece di ripetere queste promesse, si limitò a dichiarare agli operai che erano sempre valide, proprio come le aveva formulate nel discorso di Milano.
Nessuno sapeva di cosa stesse parlando, e gli applausi, tanto per cambiare, furono tiepidi. Irritato, Mussolini sbagliò ancora: chiese alla folla se non ricordava il discorso di Milano. I più zelanti, per non sbagliare, gridarono di sì; ma erano pochi. Allora al Duce saltarono i nervi. Strillò: «Se non lo ricordate, leggetelo!», e si voltò per andarsene. Agnelli, costernato, gli corse dietro, lo prese per le spalle e lo costrinse letteralmente a tornare indietro per salutare la folla; Mussolini tornò ad affacciarsi, fece il saluto romano, poi se ne andò davvero senza aggiungere altro. A Torino non sarebbe più venuto; ma si ricordava certamente di questa spiacevole esperienza, e nel ricordo accomunava, forse non a torto, il monarchico Agnelli e i suoi operai comunisti, quando tuonava da Salò, nel giugno 1944, alla notizia degli scioperi che paralizzavano Mirafiori: «Il centro della Vandea monarchica, reazionaria, bolscevica è il Piemonte».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
2 marzo 2011
| P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati |