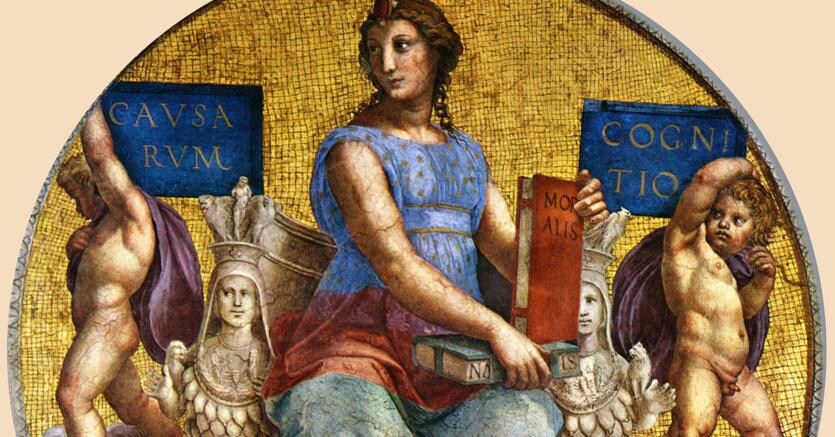
Nell’elisio degli intellettuali ottocenteschi il basileese Jacob Burckhardt (1818-1897) è colui che ha imposto il concetto di Rinascimento. Ne trattò in vari scritti preliminari, ma lo approfondì nello splendido saggio La cultura del Rinascimento in Italia, pubblicato nel 1860, guarda caso l’anno dell’unificazione. Il termine circolava da decenni, se non da secoli. Lo storico francese Jules Michelet gli aveva dato una prima teorizzazione, e a lui Burckhardt lo strappava, definendone la sostanza in alcuni tratti imperituri: l’individualismo, l’arte del governo, l’amore dell’antico. Se Michelet aveva eletto Leonardo a simbolo, Burckhardt riconosceva un campione in Alberti, universale nel suo eclettismo artistico e letterario, perfino nella sua eccellenza fisica (a proposito, segnalo la recente pubblicazione dell’ottima monografia Leon Battista Alberti. La vita, l’umanesimo, le opere letterarie dello studioso oxoniense Martin McLaughlin, Olschki, 2016).
Dopo il saggio di Burckhardt il rinascimento italiano è divenuto una coordinata della storia culturale europea e perfino un periodo, disgregazione del medioevo e inizio della cosiddetta modernità. In ambito accademico è stato applicato ad altre nazioni e ad altre epoche, per cui si è cominciato a parlare di un rinascimento francese e di un rinascimento inglese. Le deformazioni continuano ancor oggi. Da cultura alta delle corti il cosiddetto rinascimento si vede abbassato alle piazze e spintonato fin dentro i monasteri, e tra i suoi rappresentanti troviamo chiunque, compresi artigiani e giocolieri. Rinascimentale è, per qualcuno, già Dante. Per non parlare di chi, in ambito anglosassone, è arrivato a rifiutare il termine e pretende che si usi il più “corretto” early modern. Altri, invece, il termine lo preferiscono al plurale e lo disseminano all’indietro nel tempo e ovunque per il pianeta. Si è arrivati all’assurdo di rimproverare a Burckhardt, che il rinascimento l’ha inventato, miopia ideologica, pregiudizi contro il medioevo, mancanza di senso storico. Insomma, è pratica comune costringere Burckhardt entro il letto di Procuste di quel suo pur brillante e tuttavia irrinunciabile libro, mettendo in ombra tutto il resto.
La cultura del Rinascimento in Italia, infatti, è momento di una vasta e dinamica opera; e neppure momento in sé concluso. Nel ricchissimo studio Le stanchezze della modernità. Una biografia intellettuale di Jacob Burckhardt Maurizio Ghelardi, uno dei maggiori esperti di Burckhardt, impegnato anche nell’edizione critica dei suoi scritti, mostra che l’idea del Rinascimento occupa le riflessioni di Burckhardt ben oltre l’uscita della Cultura. Categoria puramente stilistica in certi scritti iniziali, si amplia in paradigma di tutta una civiltà politica e letteraria nel libro del 1860 e da ultimo rientra nuovamente nel campo specifico dell’arte, aprendosi però alla trattazione dei generi, che consentono di studiare le trasformazioni non tanto di un “che cosa” ma di un “come”. Un libro sull’arte italiana del rinascimento, ideale complemento della Cultura, rimane inedito, come molte altre cose.
Della monografia di Ghelardi si sentiva un gran bisogno. Le osservazioni sul rinascimento si inseriscono in una ricostruzione storico-biografica che segue passo passo le molteplici, infaticabili attività e scritture del protagonista, su un arco di vari decenni, mettendo in evidenza nessi tra parti anche lontane e ancora sommerse, rapporti con maestri, letture decisive, e attingendo spunti per interpretazioni più esatte da materiali inediti, comprese le lezioni universitarie, come quelle sul medioevo (che da sole basterebbero a demolire l’immagine di un Bruckhardt antimedievista). Ghelardi ci restituisce un Burckhardt deburckhardtizzato, liberato dalla camicia di forza che l’accademia gli ha costruito addosso; giudice sofferente del suo tempo, che non si risparmia occasioni di studio, passando dalla Grecia arcaica alla rivoluzione francese, dall’epoca di Costantino a Rubens, dall’arte italiana (della quale compilò perfino una guida per il viaggiatore) a quella di Hans Holbein il Giovane, dalla riflessione teorica all’osservazione diretta del dato.
Decisivo il viaggio in Italia del 1846. Il 28 febbraio Burckhardt scrive a Hermann Schauenburg da Roma: «Voi non fate che sfidare con sempre maggior audacia questa epoca indegna. Io, invece, sto in totale silenzio, e ho reciso ogni legame con essa. Perciò mi dileguo nell’indolente e piacevole Sud, morto alla storia che (…) mi dovrà rinfrancare delle stanchezze della modernità con il suo diluvio di antichità». E il 5 marzo: «credo di leggere nei tuoi occhi un muto rimprovero poiché cedo con tanta sconsideratezza ai piaceri del Sud, vale a dire all’arte e all’Antichità, mentre il mondo ha le doglie. (…) non posso certo cambiare la situazione prima che irrompa la barbarie generale (…) soccombere può capitare a tutti, ma io voglio almeno scegliere per cosa, e questa cosa è la civiltà della vecchia Europa».
Il Burckhardt di Ghelardi si è formato contestando gli effetti della rivoluzione francese, ovvero la nascita – secondo lui – di uno statalismo che ha finito per reprimere le forze creative dell’individuo e diffuso il falso mito dell’uguaglianza. Ecco da dove prende avvio uno dei fili d’oro della Cultura del rinascimento: dall’idea che la storia umana sia lo spazio in cui si esprimono le “pulsioni” (termine di Herder), in cui il genio dei singoli si fa strada a qualunque costo (qui si avverte l’insegnamento di Schopenhauer) e determina sistemi di immagini in un flusso inarrestabile. La storia è cultura, e viceversa; e nella cultura qualcosa di originario continua a tornare in sempre nuove configurazioni. Per questo la storia alla Burckhardt sconfina nell’etica o perfino nell’utopia: proposta di un modello di uomo, un esemplare vero e proprio di umanità, che sovrasta i tempi e in fondo è contemporaneo di simili eccellenti venuti prima o, nonostante le inevitabili decadenze, venturi. Non a caso, prima di giungere ad Alberti, Burckhardt, come Nietzsche, si è soffermato sugli eroi di Esiodo e, ancor di più, su quelli di Pindaro. L’eccellenza, infatti, nasce dalla competizione, dall’agone, e la civiltà greca intera è lì a dimostrarlo in modo emblematico.
Tanta aristocraticità, tanto anti-modernismo non hanno favorito una serena accettazione di Burckhardt pensatore. Fin troppo facile è fraintenderlo, ridurlo a nostalgico classista e, come si è visto, a mitografo del Quattro-Cinquecento italiano. Pur quando se ne comprendano le ragioni profonde e la struggente, leopardiana malinconia, si fatica ad accettarne la corrosività. A Burckhardt, però, occorre tornare, a tutto Burckhardt; e con mente serena, illuminati da studi come questo di Ghelardi, indicare in lui un maestro della continuità storica. In tempi di disgregazione e di oblio come questi il suo esempio può esortarci a rintracciare la persistenza di certi paradigmi e, certo, le loro modificazioni correnti. Se, come Burckhardt stesso sostiene, ogni epoca ha una sua propria identità ed è tale perché vi si possono isolare sistemi di forze e controforze, resta che la storia non conosce vere partizioni. Come dichiarò nel maggio del 1871 in uno dei Frammenti storici, «il nostro interesse si volge a quel passato che è chiaramente connesso con il presente e con il futuro. L’idea che ci guida è il procedere della civiltà, la successione delle fasi di cultura presso i vari popoli o in seno agli stessi singoli popoli».
© Riproduzione riservata






