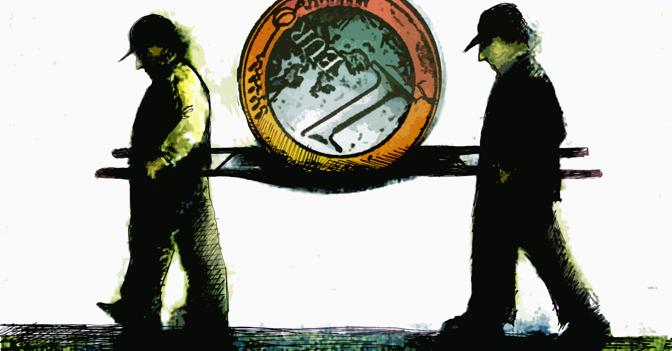
È diventato ormai un luogo comune paragonare la crisi di oggi a quella del 1929, ossia alla più grave crisi delle economie capitalistiche prima dell’attuale. E tuttavia, nel decimo anno dall’inizio della crisi ( 2007), forse sta diventando più chiaro che i tratti distintivi della crisi attuale sono assai diversi da quelli del ’29.
Il primo tratto è il suo profilo temporale. La crisi attuale non è stata né a V (crollo e rapida ripresa), né a U (caduta e lenta ripresa), né a L (caduta seguita da stagnazione), e forse neppure a W (double dip, ossia caduta, finta ripresa, nuova caduta), come credevamo fino a un anno fa, quando ci si illudeva di essere all’inizio di un nuovo periodo di crescita. A giudicare dai segnali di rallentamento degli ultimi trimestri, la W (doppia V) potrebbe tramutarsi in tripla V (triple-dip, con terzo tuffo tra il 2016 e il 2017), come qualche economista aveva profeticamente congetturato fin dal 2013-2014.
Il secondo tratto distintivo è la dinamica dei prezzi, che dopo un primo periodo altalenante (2007-11), dal 2012 non ha fatto che rallentare, ed ora sta entrando in regione negativa, a dispetto di tutte le politiche messe in atto per creare inflazione.
Se riflettiamo su questi due tratti distintivi è facile rendersi conto quanto sia fuorviante il confronto con la crisi del 1929. Quella del 1929 fu una “grande” crisi, quella attuale è innanzitutto una “lunga” crisi: allora la ripresa impiegò 4-5 anni a manifestarsi, secondo il classico schema della crisi a U, oggi non sappiamo neppure se quella attuale è una vera ripresa, che prelude a un nuovo periodo di crescita, o se stiamo sperimentando la terza falsa ripartenza, dopo quelle del 2010 e del 2013, secondo l’inedito schema di un triple-dip, o crisi a tripla V. Quanto alla dinamica dei prezzi, quella di oggi pare l’immagine speculare di quella di ieri: nella “grande” crisi del 1929 i prezzi scesero all’inizio per poi riprendere la loro corsa, nella “lunga” crisi 2007-2016 i prezzi sono saliti all’inizio (ricordate il petrolio a 150 dollari il barile?), salvo iniziare una lunga stagione di raffreddamento dopo il secondo “tuffo”, quello del 2011-2012. Se proprio vogliamo trovare qualcosa di vagamente simile nel passato, più che alla grande crisi del 1929 dovremmo rivolgerci alle lunghe crisi del 1873-1895 e al “decennio perduto” del Giappone dopo il 1990.
Storie ovviamente diverse, ma con due tratti in comune con la nostra vicenda attuale: la persistenza nel tempo, e la tendenza al raffreddamento dei prezzi. Sono questi due aspetti, a mio parere, che meriterebbero oggi una riflessione disincantata. Perché la politica di espansione monetaria non funziona? Perché la crisi dura così a lungo? E soprattutto: esiste una via di uscita realistica? Sul primo punto vorrei fare una contro-domanda: siamo sicuri che l’inflazione non sia ripartita?
Certo, se ci ostiniamo a guardare solo i prezzi al consumo, o la cosiddetta core inflation, è chiaro che i prezzi sono sostanzialmente fermi. Ma basta allargare lo sguardo a tutti i beni, compresi gli asset finanziari e reali (titoli e immobili), per rendersi conto che la politica dei bassi tassi di interesse produce precisamente gli effetti che ci si possono attendere quando mancano stimoli reali: in questi anni gli indici azionari dei principali mercati borsistici sono cresciuti a un ritmo ampiamente superiore a quello degli anni pre-crisi; e persino i prezzi delle case, da qualche tempo, stanno rialzando la testa in paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania. Forse la domanda giusta non è se la politica monetaria riesca a spingere i prezzi, ma se non stia spingendo i prezzi sbagliati, con il rischio di provocare nuove bolle speculative.
Quanto alla durata della crisi e ai modi per lasciarcela alle spalle, forse non sarebbe inutile, anche qui, provare a cambiare la domanda. Siamo sicuri che abbia senso sperare in un ritorno ai ritmi di crescita del passato? E se una crescita del 2% o del 3% fosse l’obbiettivo massimo che un’economia matura può realisticamente porsi? Non dovremmo allora prendere atto che la crisi è finita da tempo in almeno la metà delle società avanzate, e il problema riguarda le altre, quasi tutte interne alla zona euro?
Può darsi che, come spesso mi succede, io pecchi di pessimismo, ma temo che il regime di stagnazione, o di lenta crescita, che si profila all’orizzonte, con l’inedito cocktail di prezzi e produzione entrambe stagnanti, non abbia le sue radici ultime in errori macroscopici ed evidenti (che pure ci sono stati) da parte delle autorità che governano le nostre economie ma sia, per così dire, cablato nelle scelte di fondo delle nostre moderne società “arrivate”.
È opinione abbastanza condivisa che, se l’economia non riparte, è soprattutto perché c’è un deficit di domanda interna, e che è ingenuo aspettarsi assunzioni e investimenti finché il portafoglio-ordini delle imprese piange. Meno condivisa o meno accetta è la spiegazione del perché la domanda interna ristagna, e soprattutto del perché le autorità monetarie e i governi non siano in grado di stimolarla. Eppure è questo che fa la differenza con tutte le crisi del passato, comprese le due che più assomigliano alla nostra attuale (la crisi di fine ’800 e la crisi giapponese degli anni ’90). Il nocciolo della questione è che tutti – governi, imprese, famiglie – dipendiamo dai mercati finanziari per operare, ma nessuno è nella condizione di indebitarsi ulteriormente senza scatenare una tempesta finanziaria globale. E questo per un motivo assai semplice: il debito di ciascuno di questi tre soggetti, che molto era cresciuto prima del 2007, non solo non si è ridotto negli anni della crisi, ma è cresciuto ancora, a un ritmo molto superiore a quello del Pil. Secondo un rapporto McKinsey questo aumento dell’indebitamento, prima ancora che le imprese e gli Stati, ha riguardato le famiglie consumatrici, i cui debiti (a livello mondiale) sono passati da 33 a 58mila miliardi di dollari nel giro di appena 7 anni, dal 2007 al 2014. Ecco perché non ci si può stupire che i bonus elargiti dai governi non si traducano facilmente in consumi: debiti del passato e incertezze sul futuro sono sufficienti a indurre le famiglie a risparmiare anziché a spendere.
A questo problema di fondo, che riguarda il mondo nel suo insieme, si aggiungono, nelle società avanzate, due altri ostacoli formidabili. Il primo è che molti paesi (primi fra tutti i Pigs mediterranei) continuano ad avere cattivi fondamentali, e in questi anni di crisi hanno fatto troppo poco per modificarli. Il secondo, forse più importante, è che il benessere già raggiunto ha gravemente ridotto l’offerta potenziale di molti paesi. Se non può indebitarsi ulteriormente, l’unica strada che un paese ha a disposizione per aumentare la domanda interna è produrre di più. Peccato che la spinta a produrre di più richieda o governi che abbassano drasticamente i costi del produrre (con buone infrastrutture, poca burocrazia, basse imposte), o popolazioni disponibili a lunghi anni di sacrifici per migliorare la propria condizione. Questi presupposti, per molti versi tipici degli anni ’50 e ’60, oggi sono presenti solo in pochi paesi, o in particolari gruppi sociali (penso agli immigrati) all’interno di ogni paese. A distruggerle non è stata solo la crisi, ma la prosperità raggiunta dalle nostre società, che ci ha resi cittadini diversi dai nostri padri e dai nostri nonni. Il livello cui pretendiamo di vivere, ovvero la (modesta) quantità di lavoro e abnegazione che siamo disposti a mettere in campo in cambio di maggiori consumi, è la prima ragione che non ci permette di aumentare il livello di benessere che abbiamo già raggiunto.
© Riproduzione riservata





