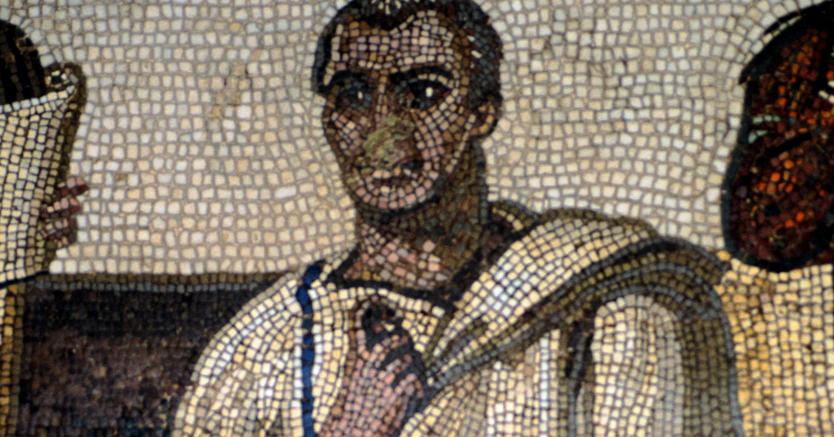
Nell’eventualità di una catastrofe totale l’Eneide sarebbe il libro da salvare, perché è l’anticipazione di molti altri libri, ed è una condensazione dell’Odissea e dell’Iliade, i libri più antichi della civiltà occidentale. Quando sant’Agostino, nel De civitate dei, cerca argomenti per affermare la superiorità della nuova religione cristiana, proprio dall’Eneide trae esempi per screditare tutto il paganesimo, perché l’Eneide era assurta a testo di tutta una civiltà, era davvero l’altro vangelo.
L’estinzione, comunque, l’Eneide non l’ha mai rischiata, a parte quando Virgilio stesso, in punto di morte, non avendo potuto dare l’ultima mano, chiese agli amici di bruciarla. Ma gli amici disobbedirono, e dei classici antichi l’Eneide è quello che ha ricevuto la più prolungata e regolare lettura. Nessuna epoca è rimasta senza l’Eneide. Nessuna epoca l’ha dovuta riscoprire – come, invece, si sono dovuti riscoprire Lucrezio, Catullo e molti altri. Neppure l’opposizione cristiana, tanto efficace in certi casi, è bastata. E si arriva al tempo in cui il poeta cristiano per eccellenza, Dante, fa di Virgilio addirittura il suo maestro. Così Petrarca, l’altro capostipite della letteratura italiana, altro cristiano, a Virgilio rivolge un culto tutto personale.
La fortuna di Virgilio sta prima di tutto nella bellezza della sua lingua. Nessun altro poeta antico, neppure il bravissimo Orazio, gli è pari. Nessuno dice come dice lui; nessuno convince come convince lui; nessuno rappresenta come rappresenta lui; nessuno commuove come commuove lui. Nella storia del latino letterario Virgilio sta alla poesia come Cicerone sta alla prosa. Questa proporzione è uno dei miti portanti dall’umanesimo, ma riflette una realtà storica. Virgilio ha rifondato la lingua poetica di Roma e ne ha fatto un lascito intramontabile. Una certa dipendenza dai predecessori (Ennio, Lucrezio, Catullo), nel lessico e in certe immagini, è senz’altro riscontrabile, ma il latino virgiliano vive tutto al di fuori delle costrizioni tradizionali: assimila e riordina, non subisce.
Tanto eccelle Lucrezio nella riforma del lessico quanto Virgilio nella ristrutturazione della sintassi: sia nella misura del breve sintagma, della iunctura, sia nell’ordine della frase e nel rapporto, sempre dialettico, tra frase e verso. Nessuna traccia di schematismo o di prefabbricato. Lucrezio mostra e definisce, Virgilio movimenta e drammatizza. Lucrezio tende a contenere in un singolo verso un’unità sintattica compiuta. Virgilio, se anche crea versi che coincidono con frasi finite, di principio spinge la frase oltre la misura del singolo verso (come, certo, vuole la natura narrativa del suo poema); e, in questo modo, crea enjambement, il tratto più distintivo della sua lingua, direi addirittura la struttura più profonda della sua mente. Assai spesso nell’Eneide la prima parola del verso che segue è il verbo di quello che precede. Il verbo arriva, così, di sorpresa, in aggetto; e, siccome viene a coincidere con un’unità metrica di notevole importanza strutturale, l’inizio del verso, la frase di cui lo stesso verbo è parte riceve una specie di scossa, riparte nel momento stesso in cui si sta concludendo. Qualunque inerzia risulta azzerata. In enjambement – va da sé – si può trovare anche un aggettivo, anche un avverbio, insomma qualunque parte del discorso: e anche in questi casi il senso della parola si intensifica, un brivido solleva la pelle della frase, se così posso dire.
La semantica, dunque, in Virgilio, acquista pienezza di senso e si riverbera nel discorso non a partire da una aprioristica assegnazione di significato – il caso di Lucrezio, puntiglioso lessicografo –, ma dalla posizione che la parola si ritrova a occupare nella frase. Virgilio è davvero un maestro dell’ordo verborum. Leggendo l’Eneide, si avverte una libertà, una fluidità che Lucrezio non comunica; e con questa libertà, però, si percepisce anche l’esattezza, il controllo perfetto di tutti i movimenti dell’ingranaggio: ciascuno, lavorando per sé, di fatto lavora per l’insieme, perché l’equilibrio del sistema non sia menomato e perché, allo stesso tempo, all’interno del sistema quel flusso armonizzante, che tutto trascina in una sola direzione, non impedisca a certi picchi di uscire, come isole in un mare.
Un altro tratto tipico, che informa temi e stile: la memoria. Ancora, in fondo, una questione di “ordine”, di “collocazione”. Enea ricorda, Didone ricorda. Tutto e tutti hanno l’anima piena di passato. Questo poema è già una “ricerca del tempo perduto”. Si dirà che l’Odissea lo è ancor prima. L’Odissea, in verità, è un canto sul ritorno. Odisseo ricorda una patria e lì, a un certo punto, effettivamente ritorna. Il tempo ritrovato dell’Eneide, invece, non è un ritorno, ma un’illusione, un recupero vicario, perché avviene in un altrove: nel Lazio, non certo a Troia, che è distrutta. Ha, dunque, sempre qualcosa del rimpianto; è indistinguibile dal pensiero dell’irrevocabile.
E Virgilio è così nostalgico, così devotamente rivolto al ricordo che non solo crea personaggi che ricordano e che più non vorrebbero farlo, ma ci fa vedere in vere e proprie epifanie come le cose invecchiano e perdono il loro senso originario, e perfino diventano segni e strumenti di morte. Gli oggetti dell’Eneide! Stanno lì per dirci che un mondo è finito, per confondere oggi e ieri e domani. Prendiamo il momento che precede il suicidio di Didone, momento davvero esemplare. Il narratore sottolinea che la spada è un dono del troiano Enea. Ma no, non è il narratore: quell’osservazione è nella mente della stessa Didone; è un discorso riportato. La spada sguainata è, letteralmente, un “ricordo”. La grammatica stessa inscena, nel giro di un solo periodo, il convergere di passato presente e futuro nei tre participi: “coeptis” (l’azione appena intrapresa), “futura” (l’imminenza ineludibile della fine), “quaesitum” (l’evento originario, la richiesta del dono/pegno). “Morte futura”, crudele ossimoro, rincara la dose; l’essere e il non essere fatti concordare.
© Riproduzione riservata





