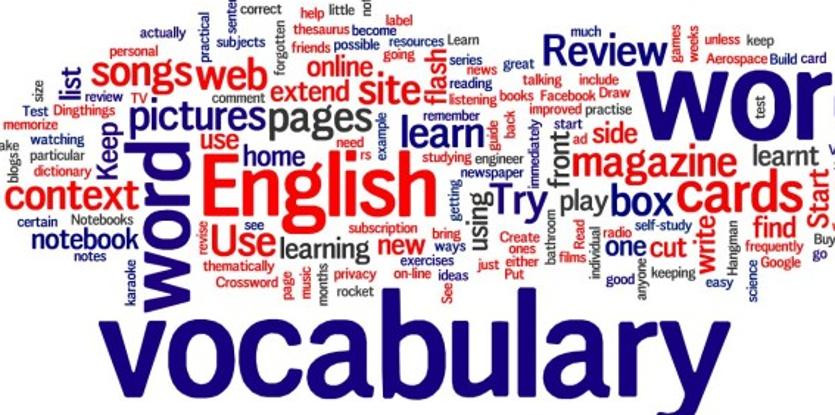
Hotspot, voluntary disclosure, smart working. Ancora: bail-in, stepchild adoption, whistleblower. E, poi, home restaurant, caregiver, in house providing. Anno dopo anno, comma dopo comma, la resistenza delle nostre leggi all’invasione di termini stranieri (i cosiddetti «forestierismi») sta lentamente crollando. Anzi, probabilmente le barriere sono già saltate.
A fotografare il fenomeno è uno studio, appena pubblicato, del Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato. Venti pagine che raccontano come le nostre norme abbiano diversi livelli di permeabilità, ben individuati: se i testi di legge hanno un grado di resistenza maggiore, provvedimenti attuativi e relazioni illustrative viaggiano su binari diversi e sono, così, pieni di anglismi.
«Il fenomeno - spiega Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale e ispiratore nel 1993 di un codice di stile delle comunicazioni scritte a uso delle Pa - va avanti da almeno vent’anni. È da tanto che l’attenzione alla scrittura delle leggi è minore, soprattutto per pigrizia. La tendenza è a ripetere parole che sono entrate nell’uso comune».
Gli esempi sono moltissimi. La legge di Bilancio del 2018, al comma 255 dell’articolo 1, parla di «caregiver familiare». La manovra correttiva (Dl 50 del 2017) cita la «voluntary disclosure». Il decreto legislativo 180 del 2015, invece, disciplina il bail-in, ripetendo il termine ben 73 volte, in tutte le sue declinazioni: passività escluse dal bail-in, finalità del bail-in, importo del bail-in. Senza dimenticare le molte correzioni del Comitato per la legislazione della Camera, organo che ha proprio il compito di esprimere pareri sulla qualità dei testi e che ha bocciato nel tempo decine di parole (si veda la scheda).
Sono, però, i provvedimenti attuativi a utilizzare la lingua in maniera più disinvolta. Qui i casi aumentano a dismisura. Basti pensare al termine «hotspot», utilizzato dal ministero dell’Interno con grande abbondanza nelle sue procedure di gestione della crisi migratoria. O della parola «whistleblower», tradotta dalla legge come «dipendente pubblico che segnala illeciti», ma usata dall’Autorità anticorruzione con frequenza.
Proprio su questa espressione, Cassese fa un’osservazione: «Bisogna evitare che questo utilizzo derivi da un vezzo piuttosto che da un bisogno. In molti casi non c’è una parola italiana corrispondente e, allora, il termine straniero è accettabile. Penso proprio a whistleblower, una parola che non ha una traduzione e che viene comunemente usata negli standard internazionali».
A monitorare il fenomeno c’è anche l’Accademia della Crusca, che nel 2015 ha creato il gruppo «Incipit» per controllare in modo sistematico il linguaggio delle leggi e della comunicazione sociale pubblica italiana, alla ricerca di neologismi provenienti da lingue straniere. Ne parla il presidente dell’Accademia, Claudio Marazzini: «Il nostro scopo è la ricerca della chiarezza, raggiunta attraverso sostituti trasparenti e italiani, comprensibili a tutti». Se pensiamo alle leggi, infatti, «l’effetto è la scarsa trasparenza, che va contro gli interessi del cittadino». Perché, come dice Cassese con una battuta, «la norma deve essere chiara a tutti, come un comando di un generale all’esercito. Se non viene compreso, si perde la guerra».
Quali sono i fenomeni più preoccupanti? Per Marazzini «sono relativi a tutti gli interventi in cui ci siamo impegnati, fin dal primo giorno, contro gli hotspot, e fino all’ultimo, in cui si stigmatizza quell’incredibile documento distribuito nelle scuole dal ministero della Pubblica istruzione».
Il riferimento è a un documento programmatico pensato per promuovere l’educazione all’imprenditorialità: qui, per il gruppo Incipit, «l’adozione di termini ed espressioni anglicizzanti non è più occasionale» ma diventa «programmatica». L’intero documento ministeriale, così, «era da gettare nel cestino».
© Riproduzione riservata





