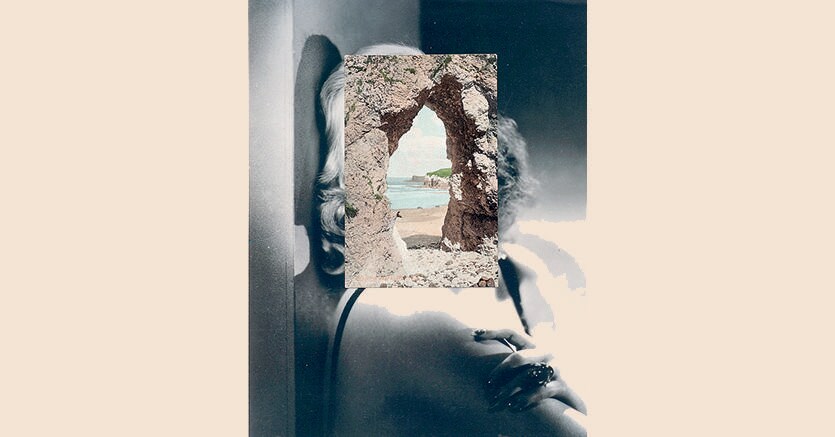
Se Artissima è il luogo di ricerca del contemporaneo e Artefiera la destinazione per il moderno, Miart – a Milano dal 31 marzo al 2 aprile – vuole coprire tutto il Novecento e sottolineare la continuità tra le due anime con sezioni curate che fanno da ponte. È il caso di “Generations”, decisa dal nuovo direttore Alessandro Rabottini (vice-direttore durante la gestione De Bellis) sulla falsariga di ThenNOW, che poneva in dialogo un artista storico e uno contemporaneo. Ora lo scarto temporale tra gli artisti si è accorciato per l’accelerazione degli input che viviamo nel mondo attuale. Ecco allora che, ieri come oggi, diversi artisti – analizzati nella pagina a fianco – utilizzano materiali “poveri” della quotidianità. «Le opere di Jessica Stockholder (1959) e Barbara Kasten (1936) condividono la stessa sensibilità, per quanto il prodotto finito di Kasten siano fotografie e quello di Stockholder sculture» commenta Douglas Fogle, curatore della sezione con Nicola Lees. «In altre coppie, come Sheila Hicks (1934) e Fernanda Gomes (1960), c’è un approccio simile nella creazione di forme astratte con materiali umili (fibre per Hicks e legno e materiali da costruzione per Gomes). Si crea un forte nesso tra questi artisti e l’eredità di movimenti come l’Arte Povera».
La coppia Ruth Wolf-Rehfeldt (1932) e Anna-Bella Papp (1988) enfatizza, invece, la relazione tra linguaggio e scultura, la prima con disegni e poesie concrete degli anni ’60-’70 (2.800-9.000 euro da Chert-Lüdde, Berlino), la seconda con delicati rilievi architettonici in argilla, ora in mostra anche alla Fondazione Arnaldo Pomodoro. «Altri artisti condividono l’interesse per la narratività – continua Fogle – come Bas Jan Ader (1942-1975), morto in una performance cercando di attraversare l’Atlantico in barca a vela (30-225.000 dollari da Meliksetian Briggs, Los Angeles) e la tedesca Andrea Büttner, che indaga la storia della povertà». Nella stessa sezione, Henri Michaux (1899-1984) e Riccardo Baruzzi (1976, prezzi 3.000-15.000 euro da P420, Bologna), uniti da una forte gestualità che si esprime in disegni tra l’astratto e il figurativo e poi John Stezaker (1949, prezzi 5-15.000 sterline da The approach, Londra), di cui sono esposti collage e manichini che rimandano agli scenari metafisici di de Chirico (1888-1978).
Un’altra sezione che fa da ponte tra moderno e contemporaneo è “Decades”, con nove stand dedicati ciascuno a un decennio del ’900. Una sezione che amplia l’orizzonte temporale e costituisce un’operazione di riscoperta che sul mercato secondario è in corso da qualche anno.
Ma quali sono i decenni sottovalutati su cui puntare? «Non ce n’è uno più sottovalutato di altri» risponde il curatore Alberto Salvadori, «ma c’è un problema di conoscenza degli artisti italiani da parte di pubblico e collezionisti. Pensiamo a Wildt, fondamentale per la formazione del linguaggio di Fontana e Melotti, o Alberto Magnelli (1888-1971, prezzi 60-500.000 euro da Lorenzelli Arte). L’arte italiana ha avuto nel ’900 un ruolo internazionale strepitoso che dobbiamo riportare alla luce grazie all’aiuto dei nostri mercanti e dei loro magazzini». A proposito di Magnelli, il gallerista Matteo Lorenzelli lamenta che il mercato è in fase involutiva e l’artista è molto sottovalutato: «soprattutto se si pensa che intorno agli anni ’40-’50 nell’Astrazione era un artista di punta, il pittore più pagato in Italia. Costava poco meno di Picasso». Il motivo? «La critica oggi si rivolge al passato “pescando” in aree temporali recenti, assecondando il mood culturale e trascurando correnti che sono state la sorgente di linguaggi tuttora stancamente declinati. Magnelli è penalizzato dall’estrema rarità di opere». Ma la rivalutazione sembra essere in atto, visto che lo storico dell’arte francese Daniel Abadie, deus ex machina della costituenda Fondazione Magnelli, sta completando il catalogo generale delle opere e preparando una serie di importanti mostre in diversi musei e gallerie d’Europa.
«C’è anche da dire che il mercato dell’arte italiana è penalizzato dal sistema normativo» aggiunge Salvadori, «la notifica è un grande limite. In molti casi è impossibile lavorare sui lasciti. E il nostro sistema museale, per problemi di governance e budget, fatica a contribuire alla valorizzazione». I decenni ora gettonati sono, si sa, gli anni ’60-’70 con Zero, la Pittura Analitica e i Poveristi, ma secondo Salvadori: «sono in crescita Scarpitta (molti anni fa il direttore di un museo italiano, con grande intelligenza, acquistò un’importante opera dell’artista per qualche centinaio di milioni di lire; fu molto criticato, ma guardando i suoi valori ora, fece un bell’affare), Melotti, Mauri, Dorazio, le ceramiche di Leoncillo e il poetico e geniale Agnetti». Il record di Scarpitta ora è 1,8 milioni di sterline.
Ripescati, invece, dai decenni più vicini, i dipinti di Cucchi da Zero e le opere di Gregor Schneider (1969) da Guido Costa Projects (5-300.000 euro). «Nei primi anni 2000 e dopo la vittoria del Leone d’oro a Venezia nel 2001, il suo mercato ha registrato un boom» commenta Costa. «Negli ultimi anni si è stabilizzato. Si tratta, però, di un artista “non facile”, le cui opere sono adatte a un mercato “radicale”, con pochi passaggi in asta, ma in fermento nelle istituzioni. Data l’importanza è destinato, nell’immediato futuro, a una nuova crescita».
© Riproduzione riservata





