
Un fondo miliardario per erogare crediti alle piccole e medie imprese e tassi bassi per facilitare l’accesso delle famiglie alle risorse finanziarie. Anche così Erdogan cerca di guadagnare consensi in vista del referendum costituzionale di domani.
Il domatore ha schioccato la frusta e le Tigri dell’Anatolia hanno ruggito di soddisfazione per inghiottire l’equivalente di 30 miliardi di dollari in lire turche di fondi e prestiti destinati alle piccole e medie imprese. Funziona così il Turkish Credit Guarantee Fund: è anche con questa novità che Tayyip Erdogan punta a vincere il referendum sui pieni poteri presidenziali, un voto ancora in bilico nonostante la martellante propaganda del governo dell’Akp per il sì. Domani può essere il suo trionfo o l’inizio del declino.
Dalla sua parte Erdogan ha ancora la borghesia musulmana e conservatrice che alla fine degli anni Ottanta ha iniziato la sua corsa con la presidenza di Turgut Ozal. Le Tigri anatoliche sono state la chiave del consenso di Erdogan.
Il suo “enrichissez-vous” alla Guizot ha avuto come risultato quello di dare rappresentanza politica alla classe media della Turchia sensibile al richiamo dei minareti, per 70 anni esclusa dai kemalisti, eredi di Ataturk, dalle leve del potere. L’Akp e Erdogan, vincitori di tutte le elezioni degli ultimi 15 anni, hanno liberato le forze sociali ed economiche alla base del boom della Turchia anatolica, una classe imprenditoriale di stampo quasi calvinista.
(*) Proiezioni del Fondo monetario internazionale
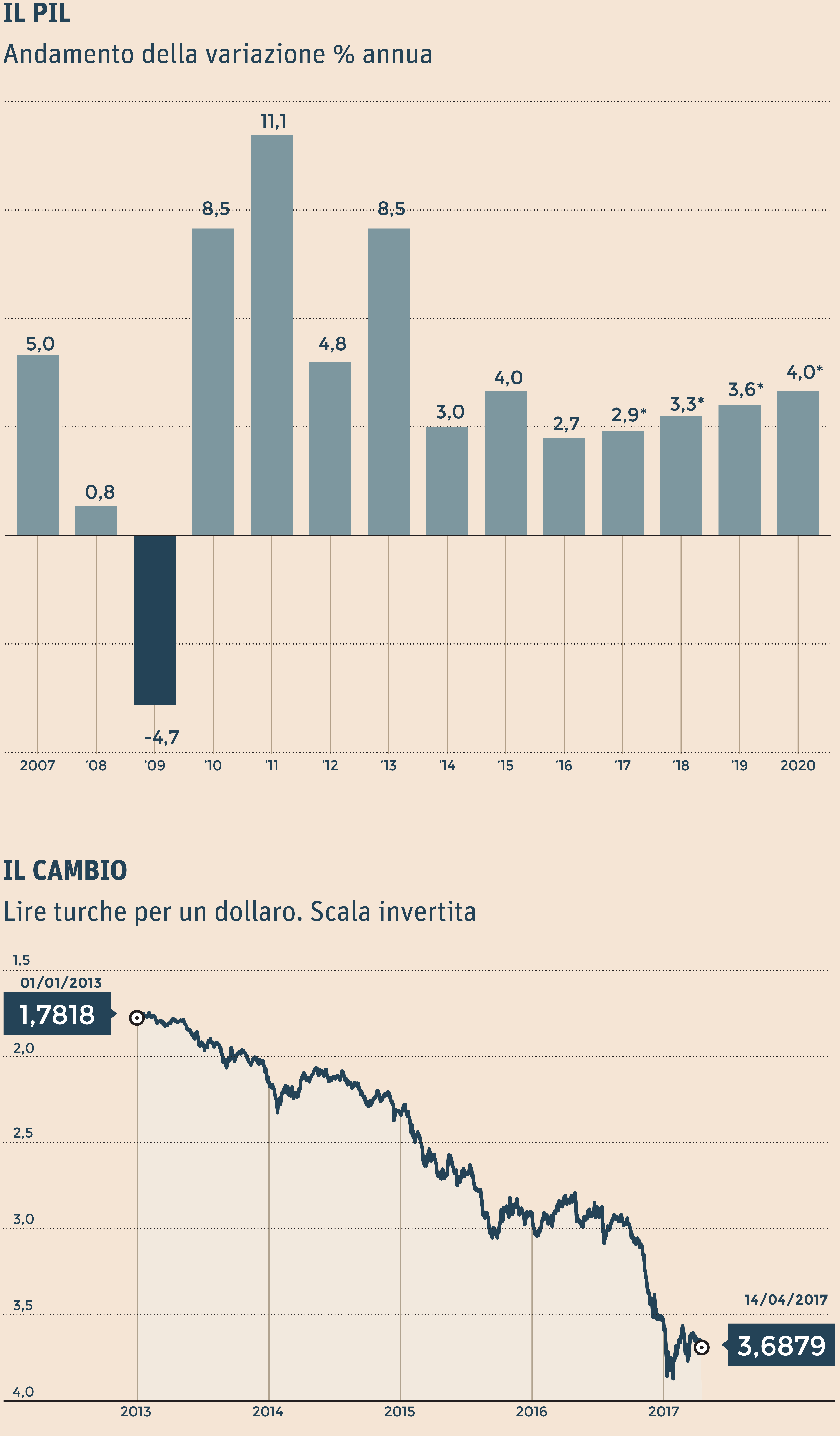
A Kayseri, città natale dell’ex presidente Abdullah Gul, ex compagno di strada di Erdogan, si dice scherzando che se non hai un figlio abbastanza sveglio per entrare in affari è meglio mandarlo all’università. I giovani all’università ci vanno eccome, ma la battuta sottolinea che questa è una città laboriosa dove la Musiad, l’associazione degli imprenditori musulmani, ha stampato un libretto dal titolo “Homo Islamicus”, che promuove con toni entusiastici i legami tra Islam, capitalismo e libero mercato, rimarcando con enfasi che Maometto prima di diventare il Profeta era un mercante.
Gli strati popolari vedono ancora in Erdogan l’uomo che li ha emancipati dall’emarginazione. Alle periferie di Istanbul, dove si attraversano ponti sul Bosforo con campate alte come la Torre Eiffel e si imboccano i tunnel sotto il mare - realizzati con il concorso di aziende italiane come Astaldi e Italfer - vivono i “turchi neri”, gli emigrati dall’Anatolia, sempre guardati con sospetto dai “turchi bianchi”, l’élite secolarista che ha dominato per decenni la vita politica.
Questa Turchia affluente non può dimenticare la lunga stagione iniziata nel 2002 con l’ascesa al del Partito della Giustizia e dello Sviluppo. Da allora il Pil è passato da 230 a oltre 800 miliardi di dollari, il reddito pro capite è balzato da 3.500 a 11mila dollari. È questo passato che alla vigilia del voto cerca di rinverdire Erdogan: la crescita, dicono le stime ufficiali, nel 2017 potrebbe superare il 3%, il doppio della media europea, ma siamo lontani dalle performance alla cinese vicine al 10% di qualche anno fa.
E anche i ponti e i tunnel sul Bosforo non sono per tutti: costa cinque dollari in lire turche l’ebbrezza di correre sotto il mare tra Europa e Asia su un nastro d’asfalto perfetto, illuminato come la pista di una aeroporto. Ma pochi se lo possono permettere: la disoccupazione è all’11-12% e le Tigri dell’Anatolia fanno fatica a pagare i fornitori. Gli stessi investitori internazionali aspettano con ansia che lo Stato li rimborsi per i mancati introiti sulle tariffe di opere di ottomana magnificenza, ma decisamente sproporzionate.
Il domatore delle Tigri ha una ricetta che secondo gli economisti ha il fiato corto. Pompare denaro nel sistema del credito, alle aziende, alle famiglie e ai consumi, tenendo bassi i tassi di interesse. Chi non segue il diktat viene eliminato come in un reality. Erdogan ha quindi messo sotto tutela la Banca centrale, con il risultato che il Paese ha un deficit cronico delle partite correnti: in pratica si consuma più di quanto si produce.
Ma questo non bastava. Coperta dal clamore di migliaia di arresti dopo il golpe fallito del 15 luglio, dalle cronache delle battaglie in Siria e dalla campagna elettorale per il referendum costituzionale sui poteri del presidente, Erdogan ha silenziosamente messo a segno la scalata agli “asset” della Turchia mettendo sotto diretto controllo le maggiori società pubbliche, dalle linee aeree alle telecomunicazioni, alle banche. Ha quindi trasferito le quote di controllo della compagnia aerea Turkish Airlines, della Halkbank, della società petrolifera Tpao e della Turkish Telekom nel Fondo sovrano Swf (Sovereign wealth fund). Il Fondo era stato istituito con una modesta dotazione di 13 milioni di dollari e adesso possiede partecipazioni per miliardi.
Oggi il Fondo è diventato una sorta di “banca” di Erdogan. Il presidente ha indicato i cinque membri del consiglio d’amministrazione, ovviamente tutti dei fedelissimi, e a dirigerlo ha proiettato Yigit Bulut, un personaggio eccentrico salito alla ribalta durante la rivolta di piazza Taksim nel 2013, quando affermò convinto che stavano tentando di uccidere Erdogan con la telecinesi.
Non importa se la lira scivola sui mercati, se la Turchia ha oltre 420 miliardi di dollari di debito estero e le imprese esposizioni a breve per 200 miliardi, la maggior parte con le banche europee. Domani basta dire “Evet”, sì, e con una frustata il domatore ammansirà le Tigri e i turchi.
© Riproduzione riservata





