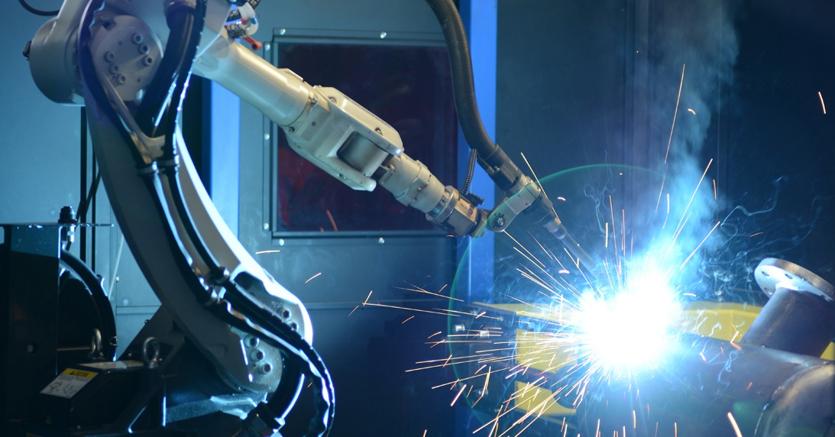
Facciamo un salto indietro di mezzo secolo e pensiamo alla forma del nostro sistema industriale quale poteva essere alla fine degli anni Sessanta. Esso si presentava come una clessidra irregolare, il cui vertice era composto dal nucleo - complessivamente ristretto, ma consistente - dei grandi gruppi pubblici e privati, che formavano l'apice di quell'assetto economico. La base della clessidra era invece composta da una miriade di piccole e piccolissime imprese, una sorta di costante della nostra storia economica. Invece, il centro della clessidra era sottilissimo: le imprese di media taglia erano poche rispetto alle altre nazioni europee.
Se consideriamo il presente, al contrario, è proprio alle medie imprese che dobbiamo guardare per rintracciare i nuovi protagonisti del nostro sistema imprenditoriale. Le imprese di taglia media e anche “intermedia” (cioè quelle che hanno acquistato una dimensione superiore, senza però essere davvero comparabili alle grandi imprese internazionali) sono diventate il soggetto più attivo della nostra economia, quelle che più si sono espanse sui mercati internazionali e hanno realizzato le più solide performance di lunga durata. Non c'è dubbio che esse ormai occupino il centro, per molti aspetti, della nostra scena economica e ne rappresentino la parte più dinamica e innovativa.
E all’analisi del presente, letto valutando il percorso degli ultimi cinquant’anni e la strada da compiere per rilanciare il Paese, è dedicato il Dossier «L’Italia che cambia» del nuovo Sole 24 Ore . Il termine di paragone non è casuale, visto che nel 1965 avveniva la fusione tra le testate Il Sole e 24 Ore e che ora, davanti alla sfida del nuovo giornale, è ancora più opportuno interpretare il presente alla luce del passato e riconoscendo le sfide future.
Secondo le analisi di Mediobanca, condotte sui dati Unioncamere, il loro numero è di circa 1.700 in totale, con la massima concentrazione al Nord (soprattutto in Lombardia, ma anche in Emilia e in Veneto), con ramificazioni importanti nel tessuto d'impresa del Centro e, ahimè, concentrate in aree ristrette del Mezzogiorno.
Quali sono le origini e le fondamenta della nuova configurazione del sistema delle imprese? Esse vanno cercate nei territori, dei quali hanno saputo canalizzare le risorse e le competenze nella direzione della crescita, che è avvenuta attraverso la proiezione internazionale delle loro attività. Spesso le medie imprese appaiono come l'evoluzione matura dei distretti industriali di un tempo, quelli che erano gemmati sulla specializzazione produttiva di un territorio. Esse hanno saputo dare un'accelerazione al loro processo di crescita che le ha emancipate da una dimensione altrimenti troppo locale e ristretta.
Hanno guardato decisamente al di là dei confini nazionali e hanno affrontato il mare della globalizzazione quando era nella fase della sua grande espansione. Ma attenzione: sovente non l’hanno fatto da sole, ma coinvolgendo alcune delle imprese di minori dimensioni che erano loro subfornitrici. A loro volta, queste ultime hanno saputo utilizzare accortamente il loro traino per misurarsi con l’economia internazionale.
Ne è derivato un aggregato economico dai lineamenti specificamente italiani, grazie a un mix di flessibilità operativa, capacità combinatoria di vari fattori (fortemente accentuata dall’impiego delle tecnologie digitali), attitudini sperimentali, che hanno permesso di sviluppare originali percorsi di crescita. Il profilo maturo del “made in Italy” viene da qui. Moda, design ed enogastronomia sono settori che hanno conquistato rilievo e visibilità. Ma grande è il peso di realtà come la meccanica e la meccatronica.
La loro convergenza ha contribuito a rafforzare questo embrionale modello italiano. Il quale si è gradualmente sostituito al precedente (quello a clessidra, per intenderci) in maniera graduale, quasi interstiziale. Così si è trasformata anche la geografia dello sviluppo: ricordate le distinzioni in uso per decenni tra Nord-Ovest, Nord-Est e così via? Forse è arrivato il tempo di abbandonarle a favore di nuove rappresentazioni geografiche.
Per alcuni si è ormai delineato un asse di crescita che, grosso modo, tende a ricalcare quello dell’Alta velocità ferroviaria. Esso procede dal Veneto (Vicenza, Verona) in direzione di Brescia e poi di Milano, per articolarsi verso Bologna e protendersi in direzione di Firenze. Nord, Grande Nord, se si vuole, ma un Nord che tende a integrarsi con una parte del Centro, rendendo obsolete alcune linee di demarcazione di una volta.
La nuova geografia dello sviluppo presenta al momento due limiti: il primo, lo si è detto, è che lascia fuori anche aree del Nord peraltro rilevanti, sebbene oggi meno dinamiche. C’è un pezzo di Nord-Ovest, che va da Torino a Genova, il quale resta distante da quella direttrice Nord-Centro di cui s’è detto. Il secondo, enorme, è il divario col Sud, il vero problema dei problemi.
In ultima analisi, l’efficacia del nuovo modello italiano, appena abbozzato, andrà verificata sulla capacità di estendersi e di includere una parte più vasta del Paese. È questa la condizione necessaria per imprimere una spinta forte e duratura al nostro sistema economico nel suo complesso.
© Riproduzione riservata