Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 29 giugno 2012 alle ore 08:43.
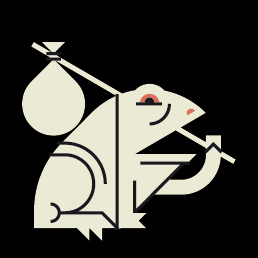 Illustrazione di Francesco Muzzi
Illustrazione di Francesco Muzzi
Uno dei primi ricordi di mio padre risale agli anni della guerra, quando non aveva neppure 4 anni: un soldato inglese gli regalò del cioccolato, un tedesco gli strappò dalle mani gli occhiali da sole della mamma. A un grado embrionale, dunque, la sua coscienza politica si formò con lo stesso meccanismo di certi esperimenti sull'apprendimento degli scimpanzé: banane e scosse elettriche.
Nel mio caso le cose furono più ingarbugliate, lo schema elementare di simpatie e antipatie su cui si regge ogni coscienza politica non trovò appigli così saldi: le mie passioni civili erano costrette a fluttuare. Nel 1989, a 13 anni, appresi dell'esistenza del Muro nello stesso istante in cui lo vidi crollare. Da lì in poi, fu come assistere a una partita in cui, nottetempo, qualcuno avesse cancellato le linee di gioco: per orientarmi ci vollero anni di letture, congetture e arrabbiature. Se mio padre riassaporasse oggi quel cioccolato, chissà, qualcosa risveglierebbe la potenza dell'originario insight – alleati buoni, nazisti cattivi. Io devo accontentarmi di madeleine molto più astratte: la stagione della mia formazione politica è riaffiorata quando mi sono trovato tra le mani il libretto postumo di un autore che allora si sentiva nominare spesso, François Furet. S'intitola Inventaires du communisme e non fa che affinare le tesi del Passato di un'illusione, analisi e anamnesi di una fata morgana (quella comunista) di cui egli stesso era stato in balia. Ebbene, fu proprio grazie ai detrattori di Furet che feci la mia conoscenza con una coppia inseparabile di sostantivo e aggettivo: era, dicevano, un "anticomunista viscerale". E questo, a quanto pare, non andava bene.
Ogni formazione politica è anche un'educazione sentimentale, e io mi trovai nella morsa di un double bind: tutto quel che apprendevo dei regimi comunisti mi rovinava la digestione non meno di quel che sapevo di altre dittature, ma un codice non scritto – più simile a un Galateo che a un catechismo ideologico – imponeva di lasciar fuori le "viscere" dall'anticomunismo, e solo da quello. Beninteso, potevo, anzi dovevo condannare il Gulag o il Grande Terrore, ma a freddo, con apatia da filosofo stoico. Da bravo Candido chiesi lumi sul perché del doppio criterio, al di là delle questioni storiografiche sul grado di atrocità comparata dei regimi (sapevo bene che Aids è diverso da Ebola, ma mi erano antipatici entrambi).
Il comunismo è morto, rispondevano, non ha senso attardarsi in livori da Guerra fredda. Sarà, ma come la mettevamo con i comunismi superstiti, come quello cubano? Era lecito alterarsi, in quel caso? No, non lo era. Ne avrei avuto conferma anni dopo da uno che del galateo ha fatto la sua stella polare ideologica: Michele Serra. Fu quando Bertinotti, allora presidente della Camera, mandò i suoi auguri di compleanno a Fidel Castro. Per biasimare il gesto, Serra scrisse un pezzo da antologia del bon ton: esordiva dicendo – a freddo, senza tradire emozioni – che Castro «in termini tecnici ben prima che ideologici» (?) è un dittatore; poi dava giù di viscere contro l'arcidefunta dittatura di Batista («disgustoso regime di pochi plutocrati»), e tra un cliché e l'altro sui sognatori della Sierra maestra lasciava cadere una frasetta sprezzante contro gli anticastristi di Miami e la loro «pressione danarosa e volgare».
Capii, da quella coppia di aggettivi, che l'anticastrismo – e per estensione l'anticomunismo – era anzitutto una passione da cafoni che non sanno stare in società, e che l' "anticomunista viscerale" ha qualcosa del Merola di Zappatore, che s'intrufola, sporco e brutto, in una compagnia di «uommene scicche e femmene pittate». Reinaldo Arenas, scrittore cubano morto in esilio, ricordava di quando a Harvard si trovò a tavola accanto a un professore filocastrista. Gli sfilò il piatto da sotto il naso e lo scagliò contro il muro, tra lo sconcerto dei commensali. Ecco, non c'è bisogno di evocare quei fantomatici "salotti" che ossessionano le fantasie degli esclusi. Non serve un salotto fisico perché vigano certe regole della conversazione salottiera, indagate da Georg Simmel in un saggio di cent'anni fa, prima tra tutte quella che impone di tener fuori «dissonanze emotive, eccitazioni e depressioni, luci e ombre della vita più intima».
Quando si parla di comunismo, ovunque ci si trovi, anche in mezzo al traffico, si dischiude un salotto magico da cui ogni animosità è bandita come segno d'ineleganza. Con gli anni avrei appreso che c'erano ragioni per questa regola – alcune non prive di nobiltà storica, altre piuttosto meschine – ma non bastò a togliermi dalla testa che si trattasse di una cosa sbagliata. E decisi che no, il mio anticomunismo non avrebbe divorziato dalle mie viscere, anche se da bambino nessun cosacco mi aveva rubato l'orsacchiotto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Permalink
CAMILLO - Cose che non resteranno Il blog di Cristian Rocca
11/10/2014
Pillole di Gommalacca / Perfume Genius
11/10/2014








