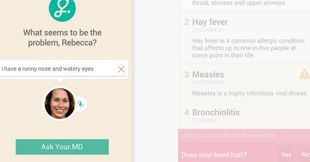Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 14 aprile 2013 alle ore 15:35.

Sindrome da Pmi, da piccola, piccolissima impresa. Il nascente (e crescente) mercato della startup nostrane rischia di assomigliare molto, troppo al tessuto imprenditoriale italiano, formato al 95 per cento da micro-imprese che non riescono (o non possono) crescere di dimensioni. La diagnosi si ottiene interrogando gli ultimi dati elaborati dall'osservatorio VeM, attivo presso l'Università Liuc di Castellanza, in collaborazione con Aifi.
Il rapporto, che sarà diffuso via internet domani, fotografa il mercato del capital venture nostrano che resta piccolo rispetto agli altri paesi europei ma riesce ad alimentare la nascita di micro-startup che però faticano a svilupparsi. «È vero che in tre anni siamo raddioppiati come numero operazioni ed è triplicato il peso del venture capital su tutto il mercato di rischio – commenta Jonathan Donadonibus docente alla Liuc di Castellanza e coordinatore del Private equity monitor –. Ma il nostro resta un mercato troppo piccolo. Quello francese è cinque volte più ricco, quello tedesco sette». È anche vero che anche negli Stati Uniti qualcosa sta andando storto nella raccolta fondi dei cv. Per la prima volta da dieci anni (si legge nel report diffuso pochi giorni fa da Thomson Reuters e dalla National Venture Capital Association) il numero di fondi che hanno raccolto fondi è calato. Un segnale che però non deve preoccupare più di tanto visto che nel primo trimestre la raccolta è cresciuta del 22% rispetto a un anno fa a 4,1 miliardi di dollari.
Ben più preoccupante è invece il dato sul taglio degli investimenti che vanno ad alimentare il nostro mondo startup. Per quanto non esaustivo, il rapporto Vem mostra un progressiva e consistente riduzione del finanziamento medio da 2,1 milioni del 2010 agli 800mila dell'anno scorso. «Un trend – sottolinea Donadonibus – che mostra chiaramente come l'Italia si stia caratterizzando per essere un mercato di capital seed, si finanziano molte iniziative ma si spende poco per ciascuna di esse». In altre parole i dati confermano un boom di startup digitali che richiedono meno soldi per partire. Parliamo di idee, progetti, business plan in cerca di una prima forma imprenditoriale.
Il rischio vero è quello di un equity gap. Chi superata la fase del seed comincia a camminare con le proprie gambe, magari raggiunge un fatturato di qualche milione di euro e ha bisogno di nuove risorse per fare il salto di qualità si trova in una valle della morte perché – come sottolinea Donadonibus – «è troppo piccolo per raccogliere fondi da un soggetto di private equity e troppo grande per un venture capital». La conseguenza è quella di una rivisitazione del nanismo imprenditoriale italico che non lascia ben sperare. Altri numeri contenuti nel rapporto suggeriscono questo possibile sviluppo del mercato. Come ad esempio l'avvicinamento di venture capital e business angel. Le operazioni che vedono questi due soggetti insieme sono passati in tre anni dal 5 al 20 per cento. Ma anche il consolidamento degli attori: sei operatori da soli muovono il cinquanta del mercato.
Un altro segnale da non sottovalutare è la debolezza dell'offerta di startup legate agli spin off. «L'ict cuba il 50% delle iniziative – osserva il professore della Liuc –. Una operazione su tre sono o app o social network. Ecco perché chiedono pochi soldi. Ma in Italia un social network a chi lo vendi?».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Permalink
Ultimi di sezione
-
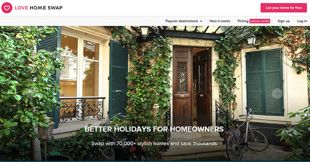
APP AND ENTERTAINMENT
Ecco le migliori app per organizzare le vacanze last-minute
di Anna Volpicelli
-

nova24
Startup, la mappa delle regioni che hanno ricevuto più finanziamenti dal Fondo Pmi
di Luca Tremolada
-

TREND
Effetto Grecia anche su Google: vacanze e crisi sono il tormento degli italiani
-

Gadget
I Google Glass cambiano faccia: arriva la Enterprise Edition?
-

DIGITAL IMAGING
Fotografia: ecco le migliori app per i professionisti dell'immagine - Foto
di Alessio Lana
-

la app della discordia
UberPop sospeso anche in Francia. E ora in Europa è fronte comune